Tra le altre forme voglio segnalare che anche il “genio femminile” si manifesta in stili femminili di santità. Così papa Francesco al n. 12 della recente Esortazione apostolica Gaudete et exsultate.
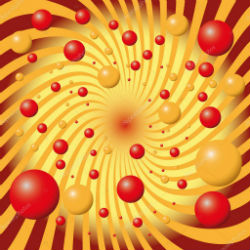 Ognuno è se stesso, da piccolo e da grande. Pertanto ognuno, se coerente, si esprime secondo la propria identità. Il papa stesso chiarisce: “siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova” (Ge 12). Io e miliardi di altre donne presenti su questo mirabile cosmo, pur in situazioni anche opposte, abbiamo una unica finalità che è espressa in un ordine divino: “Siate santi, perché io, il Signore Dio vostro, sono santo” (Lv 19,2). E’ un imperativo. Di lì non si scappa. Lo vuoi o non lo vuoi, la vocazione di ogni persona è alla santità, alla perfezione dell’amore ed ognuno/a la esprime secondo le proprie peculiarità. Non c’è altra strada. Ed è entusiasmante. Costi quel che costi. Scrive ancora papa Francesco: “Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino di santità. Lascia che tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo. Non ti scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito Santo affinché sia possibile, e la santità, in fondo, è il frutto dello Spirito Santo nella tua vita (cfr Gal 5,22-23) (GE 15).
Ognuno è se stesso, da piccolo e da grande. Pertanto ognuno, se coerente, si esprime secondo la propria identità. Il papa stesso chiarisce: “siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova” (Ge 12). Io e miliardi di altre donne presenti su questo mirabile cosmo, pur in situazioni anche opposte, abbiamo una unica finalità che è espressa in un ordine divino: “Siate santi, perché io, il Signore Dio vostro, sono santo” (Lv 19,2). E’ un imperativo. Di lì non si scappa. Lo vuoi o non lo vuoi, la vocazione di ogni persona è alla santità, alla perfezione dell’amore ed ognuno/a la esprime secondo le proprie peculiarità. Non c’è altra strada. Ed è entusiasmante. Costi quel che costi. Scrive ancora papa Francesco: “Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino di santità. Lascia che tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo. Non ti scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito Santo affinché sia possibile, e la santità, in fondo, è il frutto dello Spirito Santo nella tua vita (cfr Gal 5,22-23) (GE 15).
E Dio, venuta la pienezza dei tempi, in Gesù Cristo, ce ne ha tracciato il percorso ben dettagliato nel Vangelo: è il percorso delle Beatitudini. Un percorso decisamente nuovo, ‘controcorrente’, non facile, ma affascinante. Si tratta di essere poveri in spirito, vivere un‘esistenza austera e povera, “indifferenti verso tutte le cose create”; salute e malattia, ricchezza e povertà, onore e disonore, vita lunga o breve e così via… (GE 69).
Ma non basta. Gesù propone di essere miti e misericordiosi. L’agitazione e l’arroganza producono stanchezza, perciò “è meglio essere sempre miti, e si realizzeranno le nostre più grandi aspirazioni: i miti avranno in eredità la terra” (GE,74). Il papa richiama la misericordia come capacità di perdono e chiarisce: “dare e perdonare è tentare di riprodurre nella nostra vita un riflesso della perfezione di Dio, che dona e perdona in modo sovrabbondante” e conclude deciso: “Guardare e agire con misericordia, questo è santità” (GE 81-82).
E non basta ancora. La scalata è bella anche se faticosa: per giungere alla santità è necessario anche essere ‘puri di cuore’ e ‘operatori di pace’. La prima – secondo il papa – si riferisce a “chi ha un cuore semplice, senza sporcizia, un cuore che sa amare… Il Signore si aspetta una dedizione al fratello che sgorga dal cuore”.
La seconda, forse impegna proprio nel nostro tempo, con una visione alla globalità delle situazioni: sempre e comunque spargere spruzzi di pace, leggeri ma fecondi.
“Essere nel pianto” e “perseguitati per la giustizia” secondo Gesù non sono una calamità. E’ beatitudine. Scrive il papa: “La persona che vede le cose come sono realmente, si lascia trafiggere dal dolore e piange nel suo cuore è capace di raggiungere le profondità della vita e di essere veramente felice. Quella persona è consolata, ma con la consolazione di Gesù…. Così può avere il coraggio di condividere la sofferenza altrui e smette di fuggire dalle situazioni dolorose. In tal modo scopre che la vita ha senso nel soccorrere un altro nel suo dolore, nel comprendere l’angoscia altrui, nel dare sollievo agli altri” (GE 76).
sr Biancarosa Magliano,fsp
biancarosam@tiscali.it



 Custode delle notizie: una vera e propria missione
Custode delle notizie: una vera e propria missione
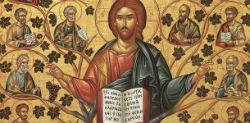 Dal Vangelo di Giovanni Gv 15,9-17
Dal Vangelo di Giovanni Gv 15,9-17
 Le juniores presenti a Cuba, nei giorni 27-29 aprile c.a. hanno partecipato a un intenso corso di Formazione. Esso aveva come tema centrale “le sfide e le speranze che vengono offerte dalla realtà cubana”. E ciò è stato fatto anche tenendo presente l’esperienza che vive la vita Consacrata giovane in quel Paese. Un apporto forte è stato offerto inoltre dalla realtà internazionale del gruppo: 3 cubani e 9 cubane, 2 salvadoregne, 1 filippina,1 peruviana, 1 haitiana, 1 cilena, 1 colombiana, 1 brasiliano, 1 guatemalteca, 1 paraguayana e 4 della repubblica Domenicana. Ha condotto l’incontro p. Luis Fernando s.j. Egli da subito li ha invitati ad accogliere la realtà cubana nella sua peculiarità, in quanto diversa dalle altre realtà del Continente americano. Hanno così potuto conoscere la realtà di quel Paese, soprattutto per le disuguaglianze che esistono nelle loro stesse Congregazioni. Le differenze tra Cuba e gli altri paesi sono davvero notevoli.
Le juniores presenti a Cuba, nei giorni 27-29 aprile c.a. hanno partecipato a un intenso corso di Formazione. Esso aveva come tema centrale “le sfide e le speranze che vengono offerte dalla realtà cubana”. E ciò è stato fatto anche tenendo presente l’esperienza che vive la vita Consacrata giovane in quel Paese. Un apporto forte è stato offerto inoltre dalla realtà internazionale del gruppo: 3 cubani e 9 cubane, 2 salvadoregne, 1 filippina,1 peruviana, 1 haitiana, 1 cilena, 1 colombiana, 1 brasiliano, 1 guatemalteca, 1 paraguayana e 4 della repubblica Domenicana. Ha condotto l’incontro p. Luis Fernando s.j. Egli da subito li ha invitati ad accogliere la realtà cubana nella sua peculiarità, in quanto diversa dalle altre realtà del Continente americano. Hanno così potuto conoscere la realtà di quel Paese, soprattutto per le disuguaglianze che esistono nelle loro stesse Congregazioni. Le differenze tra Cuba e gli altri paesi sono davvero notevoli.
 Secondo le più recenti stime di Fondazione ISMU, gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2017 che professano la religione cristiana ortodossa si confermano come l’anno precedente i più numerosi (oltre 1,6 milioni, +0,7%), seguiti dai musulmani (poco più di 1,4 milioni, -0,2%) e dai cattolici (poco più di un milione, -0,1%) [1].
Secondo le più recenti stime di Fondazione ISMU, gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2017 che professano la religione cristiana ortodossa si confermano come l’anno precedente i più numerosi (oltre 1,6 milioni, +0,7%), seguiti dai musulmani (poco più di 1,4 milioni, -0,2%) e dai cattolici (poco più di un milione, -0,1%) [1].
 «Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».
«Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».
 Si chiama “Religion2go” la nuova app allo studio della Fondazione Bruno Kessler di Trento che ha come obiettivo quello di mettere la tecnologia al servizio della religione. Come? Attraverso la nuova app “Replicate”, grazie alla quale con il proprio smartphone è possibile fotografare un oggetto – in questo caso un oggetto di culto – e crearne una copia digitale in 3D da condividere “to go” in rete, attraverso un visualizzatore, o addirittura vissuto in forma di realtà virtuale. “Questo progetto – spiega Fabio Poiesi, del Centro per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione Ict – nasce da un percorso avviato con l’Istituto di scienze religiose, che fa parte del polo umanistico della Fondazione. Si basa su un percorso di osservazione partecipata che sta coinvolgendo rappresentanti religiosi di vario credo”. “In Italia esistono 840 comunità religiose di credo diverso – spiega Sara Hejazi, dell’Istituto di scienze religiose trentino – abbiamo avviato una serie di interviste a ministri di culto in tutta Italia e ad oggi le testimonianze raccolte riportano un grande interesse sulla questione della virtualizzazione. Il mondo virtuale può essere usato per mettere insieme generazioni diverse o per superare le distanze geografiche, creando ponti tra le comunità religiose sparse in tutto il mondo”.
Si chiama “Religion2go” la nuova app allo studio della Fondazione Bruno Kessler di Trento che ha come obiettivo quello di mettere la tecnologia al servizio della religione. Come? Attraverso la nuova app “Replicate”, grazie alla quale con il proprio smartphone è possibile fotografare un oggetto – in questo caso un oggetto di culto – e crearne una copia digitale in 3D da condividere “to go” in rete, attraverso un visualizzatore, o addirittura vissuto in forma di realtà virtuale. “Questo progetto – spiega Fabio Poiesi, del Centro per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione Ict – nasce da un percorso avviato con l’Istituto di scienze religiose, che fa parte del polo umanistico della Fondazione. Si basa su un percorso di osservazione partecipata che sta coinvolgendo rappresentanti religiosi di vario credo”. “In Italia esistono 840 comunità religiose di credo diverso – spiega Sara Hejazi, dell’Istituto di scienze religiose trentino – abbiamo avviato una serie di interviste a ministri di culto in tutta Italia e ad oggi le testimonianze raccolte riportano un grande interesse sulla questione della virtualizzazione. Il mondo virtuale può essere usato per mettere insieme generazioni diverse o per superare le distanze geografiche, creando ponti tra le comunità religiose sparse in tutto il mondo”.
 Mentre si susseguono numerosi i fatti di cronaca che stigmatizzano atti indisciplinati di vari studenti della Penisola, non mancano purtroppo le “ricette” di soluzioni semplicistiche al problema. Nemmeno la scuola è indenne dal costume italiano di trasformare gli accadimenti in “fenomeni”, da curare con pillole di saggezza spiccia o direttamente con il Codice Penale: c’è, infatti, chi invoca un richiamo al contratto dei docenti per tutelarli da ragazzi bulli e genitori violenti. Uno scenario da Far West. D’altronde, che andare a scuola fosse una missione da eroi e che far lezione domandasse, oltre ad una grande competenza, una buona dose di coraggio, era ormai risaputo. Non ci sono soluzioni miracolistiche.
Mentre si susseguono numerosi i fatti di cronaca che stigmatizzano atti indisciplinati di vari studenti della Penisola, non mancano purtroppo le “ricette” di soluzioni semplicistiche al problema. Nemmeno la scuola è indenne dal costume italiano di trasformare gli accadimenti in “fenomeni”, da curare con pillole di saggezza spiccia o direttamente con il Codice Penale: c’è, infatti, chi invoca un richiamo al contratto dei docenti per tutelarli da ragazzi bulli e genitori violenti. Uno scenario da Far West. D’altronde, che andare a scuola fosse una missione da eroi e che far lezione domandasse, oltre ad una grande competenza, una buona dose di coraggio, era ormai risaputo. Non ci sono soluzioni miracolistiche.
 Il popolo cristiano fin dagli inizi, nelle difficoltà e nelle prove ricorre alla Madre, come indica la più antica antifona mariana: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio: non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
Il popolo cristiano fin dagli inizi, nelle difficoltà e nelle prove ricorre alla Madre, come indica la più antica antifona mariana: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio: non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
 «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore.
«Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore.