 Dal Vangelo di Giovanni Gv 2,13-25
Dal Vangelo di Giovanni Gv 2,13-25
Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: Lo zelo per la tua casa mi divorerà.
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù.
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo.
………………………………………………………
La liturgia ci fa continuare il nostro itinerario quaresimale con alcuni brani del vangelo di Giovanni. Per quest’anno (ciclo B) saranno Gv 2,13-25, il brano odierno, con la descrizione della cacciata dal tempio dei venditori e la promessa da parte di Gesù di un nuovo tempio; nella IV domenica la seconda parte del discorso notturno con Nicodemo, Gv 3,14-21 e la V domenica la richiesta di alcuni greci di vedere Gesù, Gv 12,20-33. Un itinerario volto ad approfondire alcuni aspetti importanti per la fede cristiana, in riferimento alla Pasqua del Signore Gesù. Il testo odierno segue immediatamente il racconto del segno di Cana (Gv 2, 1-12) con cui forma un dittico, ed entrambi si concludono con la fede dei discepoli (cfr. vv. 11 e 22), ed è seguito dall’incontro con Nicodemo (di cui ascolteremo una parte nella IV domenica). La pericope si compone di un versetto introduttivo (v. 13), il racconto del fatto (vv. 14.16), la discussione che ne segue con la richiesta di un segno (vv. 18-22) e un sommario conclusivo (vv. 23-25) che prepara i brani seguenti. Al centro dell’attenzione sta Gesù che si propone come il Figlio di Dio Padre e come il nuovo tempio in cui adorare Dio in spirito e verità (cfr. il testo della samaritana, Gv 4,1-42, proposto nella III domenica nell’anno A).
La liturgia della Parola si completa con il brano di Es 20,1-17 (il testo del decalogo) e la lettura paolina da 1 Cor 1,22-25 dove ci viene ricordato che in Cristo crocifisso troviamo la sapienza e la potenza divina. Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. L’introduzione della pericope fa menzione della Pasqua dei Giudei, espressione tipica di Giovanni, che intende porre una netta separazione tra la festa ebraica e la pasqua cristiana. Per Gesù la festa ebraica era scaduta nel suo significato, passando dal ricordo della liberazione ad un evento di mercato (il commercio degli animali per il sacrifico, favorito dai sacerdoti per il guadagno che comportava). Secondo l’evangelista Giovanni Gesù andò tre volte a Gerusalemme per celebrare tale festa, quella del testo odierno è la prima pasqua (la seconda è narrata in 6,4 in riferimento alla moltiplicazione dei pani; la terza la troviamo in 11,55, appena prima della passione e morte, come nei sinottici, cfr. Mc 14,1ss e paralleli). L’attività di Gesù si svolge nel quarto vangelo soprattutto nella città santa a differenza dei sinottici che invece ambientano il ministero pubblico in Galilea e lo fanno salire a Gerusalemme (la città è situata su una collina) per l’unica pasqua menzionata quella della sua passione, morte e resurrezione. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, 16e ai venditori di colombe disse: “Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!”. Di fronte allo spettacolo poco edificante e ancor meno religioso del commercio nel cortile del tempo, come pure dell’andirivieni di gente ed animali che usavano il cortile riservato ai pagani (dei gentili) come scorciatoia pur raggiungere il monte degli ulivi (cfr. Mc 11,15-17), Gesù richiama il senso profondo del tempio e dell’attività che vi si deve svolgere. Quello di Gesù è un gesto che si rifà a Ml 3,1: “ecco, io manderò il mio messaggero a preparare la via davanti a me e presto entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate” e Zc 14,21: “in quel giorno non vi sarà più mercante nel tempio del Signore“; altri testi profetici deplorano il culto solo esteriore ( Am 5,21-24; Is 11,11-17; Ger 7,21-26). Siamo nella linea dell’escatologia giudaica in cui il Messia avrebbe purificato il tempio. A differenza dei sinottici non definisce il tempio casa di preghiera, ma casa del Padre mio . Si tratta di un distinguo importante: il tempio come dimora di Dio è un dato tipico e tradizionale nell’AT (cfr. Es 25,40; 1Re 6,1; Sal 122,1) e di conseguenza centro del culto a lui dovuto. In questo testo per la prima volta Gesù chiama Dio Padre mio e indirettamente si proclama suo Figlio; affermazione sconcertante per un israelita e che ci fa comprendere quanto Gesù dice sul suo rapporto con Dio contenute nel quarto vangelo (5,17-26; 6,32.37.40; 10,30; 14,10). Se Dio è Padre allora il culto a lui dovuto non può consistere solo in sacrifici materiali, ma dovrà essere un culto spirituale e interiore da vivere nell’amore, secondo le esigenze dell’alleanza stipulata da Dio con il suo popolo (cfr. 1Re 19,10.14). (G. Zavini).
I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: Lo zelo per la tua casa mi divorerà. Questo commento redazionale ci fa capire che il testo è raccontato dall’evangelista alla luce della resurrezione (cfr. Sal 69,10) e in senso profetico; infatti il mutamento di tempo del verbo dal passato al futuro indica che tutta la vicenda di Gesù, che l’evangelista sta per narrare, si svolgerà nel segno dello zelo per Dio. La sua è una vita tutta volta a compiere la volontà del Padre, sino alla fine e in questo senso il testo diventa anche un annuncio della passione di Gesù. Mentre per i sinottici questo episodio è il motivo addotto per condannare Gesù (cfr. Mc 11,18; Lc 19,47-48), in Giovanni è preludio della sua morte. Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: “Quale segno ci mostri per fare queste cose?”. Rispose loro Gesù: “Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere”. Gli dissero allora i Giudei: “Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?”. Come altrove nei vangeli ( cfr. Mc 8,11; Mt 12,38; 16,1; Lc 11,16,29-30) davanti ai gesti profetici di Gesù (in questo caso l’autorità esercitata sul tempio e su quanto vi accade) i giudei, o più in generale i suoi avversari, chiedono un segno prodigioso a garanzia dell’autorità di Gesù. Ma il segno proposto da Gesù si pone su di un piano completamente diverso: non un prodigio strepitoso, segno di potenza, ma un gesto profetico: Giovanni gioca intenzionalmente sull’ambiguità del verbo farò risorgere (in greco eghéiro che significa sia innalzare un edificio, sia far risorgere un morto). Indicando la sua resurrezione afferma che avrebbe trasformato il vecchio tempio (di pietre) in uno nuovo che avrebbe rivelato la sua divinità. Il tempio si identifica così con il suo corpo; è il segno di Giona di cui parlano anche i sinottici (cfr. Mt 12,38-39; 16,1-4; Mc 8,11-13; Lc 11,16.29; 12,54-56). La risposta del v. 20 ci mostra l’equivoco in cui sono caduti i giudei: essi si riferiscono ai lavori nel tempio, voluti da Erode il Grande; la costruzione era infatti cominciata nel 20/19 a.C. (come attesta Flavio Giuseppe,Ant . XV, 380). Da ciò ricaviamo che l’evangelista pone l’attività di Gesù nel 27/28, data in cui i lavori non erano ancora ultimati anche se la parte essenziale era compiuta. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. 22 Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. Ancora due versetti redazionali: l’evangelista precisa il senso delle parole di Gesù come profezia della sua pasqua. Ilcorpo, l’umanità di Gesù, è il luogo della presenza e della manifestazione di Dio in mezzo all’umanità, dunque è il vero tempio. Il culto dovrà d’ora in poi fare riferimento alla sua persona (Gv 1,14; 1,51; 4,20-24). Giovanni parla del corpo di Gesù solo in questo versetto e nei due testi in cui questa profezia si compie: alla deposizione di Gesù dalla croce (tempio distrutto) e alla scoperta del sepolcro vuoto, dopo la sua resurrezione (Gv 19,38; 20,12). Alla luce di tale evento e per l’azione dello Spirito santo, i discepoli ricorderanno queste parole del Maestro: Cristo risorto è il nuovo Tempio, il solo luogo della presenza salvifica di Dio tra gli uomini, il Tempio spirituale. (G. Zevini) La fede nella Scrittura è posta dall’evangelista sullo stesso piano di quella nella parola detta da Gesù, a significare che solo dopo la resurrezione i discepoli compresero appieno la portata delle parole e dei gesti, di tutta la vita di Gesù. Se la morte di Gesù è il segno del suo zelo per Dio, la sua resurrezione inaugura il tempio nuovo, spirituale, in cui si vive una fede senza limiti né barriere, come diceva Isaia (Is 56,7). Per Giovanni il nuovo tempio, sempre attuale e duraturo, è il corpo di Cristo risorto dai morti. Di qui Giovanni conserva la destinazione primordiale del tempio: il luogo della presenza di Dio tra il suo popolo. (Van Den Bussche). Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. 24 Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo. Questi tre versetti costituisco un sommario, come se ne trovano anche nei sinottici, che riassume l’attività di Gesù e ne anticipa il senso, dove si valuta l’uomo sotto l’aspetto della fede e dell’incredulità. Il tema della fede infatti verrà sviluppato nei due capitoli successivi con il racconto del colloquio con Nicodemo (3,1-21), la testimonianza del Battista (3,22-36), la samaritana (4,1-42) e la guarigione del ragazzo (4,43-54 che apre ad una universalità della fede). Per l’evangelista ci sono diversi tipi di fede: alcuni insufficienti, come la fede nel taumaturgo Gesù: molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome (v. 23), che ritroviamo anche in Nicodemo. Altri che si aprono ad un approfondimento (la samaritana che dimostra una fede messianica) ed infine la vera fede nel Figlio di Dio (il Battista, 3,22-36; Maria e i discepoli 2,11.22), quella a cui bisogna approdare. Gesù conosce l’intimo dell’uomo, le sue fragilità e non si lascia ingannare dall’entusiasmo superficiale che segue i suoi segni; egli ha la conoscenza propria di Dio e sa distinguere coloro che accettano appieno le sue parole e la sua persona, senza lasciarsi condizionare dalle apparenze (cfr. Gv 21,17; 1Gv 3,20). Egli attende la risposta di ciascuno e nei capitoli 3 e 4 l’evangelista ci mostra tre esempio significativi: Nicodemo, rappresentante del giudaismo ortodosso, la samaritana appartenente al giudaismo eretico e l’ufficiale romano un pagano. Il segno del tempio che Gesù ha appena offerto, è un gesto che ci richiama all’autenticità del rapporto con Dio, liberando dall’esteriorità in cui il sistema dei sacrifici l’aveva rinchiuso. Il percorso quaresimale è anche per noi un tempo propizio per purificare e rafforzare la nostra fede e vivere il culto a Dio nella libertà e nella verità del vero tempio, che è l’umanità di Gesù Cristo.
Monastero Matris Domini
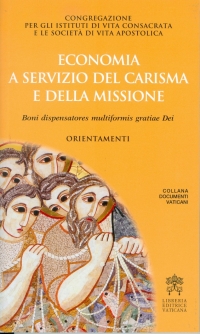 Presso l’Aula Magna dell’Antonianum (Roma) il 6 marzo c.a. è stato presentato l’ultimo documento preparato dalla Congregazione per la Vita consacrata e le Società di vita apostolica “Economia a servizio del carisma e della missione”- Orientamenti, già disponibile in italiano e spagnolo. In arrivo inglese e francese.
Presso l’Aula Magna dell’Antonianum (Roma) il 6 marzo c.a. è stato presentato l’ultimo documento preparato dalla Congregazione per la Vita consacrata e le Società di vita apostolica “Economia a servizio del carisma e della missione”- Orientamenti, già disponibile in italiano e spagnolo. In arrivo inglese e francese.


 La scuola italiana, dalle materne alle superiori, è frequentata in Italia da 8.826.893 studenti, 1.109.585 dei quali frequentano scuole non statali, cioè non gestite dallo Stato, ma che dallo Stato sono controllate e riconosciute come luoghi di istruzione pubblici in base alla legge 62 del 2000. Per garantire l’istruzione a tutti, lo Stato ha stanziato nell’anno scolastico 2015/2016 49 miliardi e 418 milioni di euro per la scuola statale e 499 milioni per quella paritaria. Proprio per quest’ultima, però, sono via via diminuiti gli stanziamenti: sono passati da 530 milioni nell’anno scolastico 2006/2007 a 499 milioni nell’anno scolastico 2015/2016. Significa che ogni studente delle scuole statali riceve in finanziamenti, dallo Stato centrale, 6403,52 euro solo di spese correnti. La cifra aumenta di molto se si considerano i finanziamenti degli enti locali. Nella Francia laica e secolarizzata, secondo i dati OCSE del 2014, la differenza tra la spesa per uno studente delle scuole paritarie e uno che frequenta le scuole statali è di soli 3.824 euro, mentre in Italia è di 6.769 euro (a vantaggio delle scuole statali). Gli scarsi finanziamenti hanno provocato, nel corso degli anni, un calo delle iscrizioni alle scuole paritarie, che sono passate dall’11,85% dell’anno scolastico 2010/2011 al 10,64% dell’anno 2015/2016. C’è però un dato che testimonia la fiducia riposta da molte famiglie nelle scuole pubbliche non statali: l’aumento degli studenti con bisogni particolari, come stranieri e disabili, con un corrispondente risparmio per le scuole pubbliche statali. I ragazzi disabili iscritti nelle pubbliche paritarie sono passati dagli 11.547 dell’anno scolastico 2010/2011 ai 12.211 dell’anno scolastico 2014/2015, mentre gli stranieri sono passati da 45.069 a 60.017. Come abbiamo, visto il 93,8% degli alunni frequenta scuole pubbliche statali. Ma queste come garantiscono la qualità? Non è chiaro, dal momento che l’Italia è agli ultimi posti nella gran parte dei punteggi delle edizioni 2015 dei test OCSE che servono per verificare le competenze degli studenti nell’ambito scientifico. Siamo quart’ultimi nella capacità di lettura, quint’ultimi in matematica. Tra i grandi Paesi europei, ci collochiamo davanti solo alla Spagna. Nella laicissima Francia, lo Stato paga gli insegnanti delle scuole paritarie e le rette sono bassissime: il 32% degli studenti frequenta scuole paritarie e nei test OCSE la Francia ci batte abbondantemente.
La scuola italiana, dalle materne alle superiori, è frequentata in Italia da 8.826.893 studenti, 1.109.585 dei quali frequentano scuole non statali, cioè non gestite dallo Stato, ma che dallo Stato sono controllate e riconosciute come luoghi di istruzione pubblici in base alla legge 62 del 2000. Per garantire l’istruzione a tutti, lo Stato ha stanziato nell’anno scolastico 2015/2016 49 miliardi e 418 milioni di euro per la scuola statale e 499 milioni per quella paritaria. Proprio per quest’ultima, però, sono via via diminuiti gli stanziamenti: sono passati da 530 milioni nell’anno scolastico 2006/2007 a 499 milioni nell’anno scolastico 2015/2016. Significa che ogni studente delle scuole statali riceve in finanziamenti, dallo Stato centrale, 6403,52 euro solo di spese correnti. La cifra aumenta di molto se si considerano i finanziamenti degli enti locali. Nella Francia laica e secolarizzata, secondo i dati OCSE del 2014, la differenza tra la spesa per uno studente delle scuole paritarie e uno che frequenta le scuole statali è di soli 3.824 euro, mentre in Italia è di 6.769 euro (a vantaggio delle scuole statali). Gli scarsi finanziamenti hanno provocato, nel corso degli anni, un calo delle iscrizioni alle scuole paritarie, che sono passate dall’11,85% dell’anno scolastico 2010/2011 al 10,64% dell’anno 2015/2016. C’è però un dato che testimonia la fiducia riposta da molte famiglie nelle scuole pubbliche non statali: l’aumento degli studenti con bisogni particolari, come stranieri e disabili, con un corrispondente risparmio per le scuole pubbliche statali. I ragazzi disabili iscritti nelle pubbliche paritarie sono passati dagli 11.547 dell’anno scolastico 2010/2011 ai 12.211 dell’anno scolastico 2014/2015, mentre gli stranieri sono passati da 45.069 a 60.017. Come abbiamo, visto il 93,8% degli alunni frequenta scuole pubbliche statali. Ma queste come garantiscono la qualità? Non è chiaro, dal momento che l’Italia è agli ultimi posti nella gran parte dei punteggi delle edizioni 2015 dei test OCSE che servono per verificare le competenze degli studenti nell’ambito scientifico. Siamo quart’ultimi nella capacità di lettura, quint’ultimi in matematica. Tra i grandi Paesi europei, ci collochiamo davanti solo alla Spagna. Nella laicissima Francia, lo Stato paga gli insegnanti delle scuole paritarie e le rette sono bassissime: il 32% degli studenti frequenta scuole paritarie e nei test OCSE la Francia ci batte abbondantemente.
 La donna, pilastro nella edificazione della Chiesa e della società in America Latina è il tema scelto dal Papa Francesco per la prossima Assemblea Plenaria della Pontificia Commissione per l’America Latina (Cal), che si svolgerà in Vaticano dal 6 al 9 marzo 2018
La donna, pilastro nella edificazione della Chiesa e della società in America Latina è il tema scelto dal Papa Francesco per la prossima Assemblea Plenaria della Pontificia Commissione per l’America Latina (Cal), che si svolgerà in Vaticano dal 6 al 9 marzo 2018
 Dal Vangelo di Giovanni Gv 2,13-25
Dal Vangelo di Giovanni Gv 2,13-25


 Nei giorni 20 e 21 febbraio 2018 si è realizzato il secondo modulo del Convegno organizzato da USMI e CHARIS sul tema: “Prendersi cura delle Sorelle nell’età anziana e nelle fragilità”.
Nei giorni 20 e 21 febbraio 2018 si è realizzato il secondo modulo del Convegno organizzato da USMI e CHARIS sul tema: “Prendersi cura delle Sorelle nell’età anziana e nelle fragilità”.
 Una struttura per l’accoglienza, il conforto e la riabilitazione dei disabili, dove tutti gli ospiti “si danno da fare nello spirito del reciproco aiuto”. È “Snehonir”, la “Casa della Tenerezza” di Rajshahi, dove le suore della congregazione locale Shanti Rani (Regina della pace) e i padri del Pime (Pontificio istituto missioni estere) accolgono bambini e ragazzi con disabilità mentali e fisiche, sordomuti, ciechi e bambine sfregiate con l’acido. Non solo: la casa si prende cura anche di bambini senza disabilità, orfani o provenienti da famiglie molto povere che non hanno la possibilità di allevarli.
Una struttura per l’accoglienza, il conforto e la riabilitazione dei disabili, dove tutti gli ospiti “si danno da fare nello spirito del reciproco aiuto”. È “Snehonir”, la “Casa della Tenerezza” di Rajshahi, dove le suore della congregazione locale Shanti Rani (Regina della pace) e i padri del Pime (Pontificio istituto missioni estere) accolgono bambini e ragazzi con disabilità mentali e fisiche, sordomuti, ciechi e bambine sfregiate con l’acido. Non solo: la casa si prende cura anche di bambini senza disabilità, orfani o provenienti da famiglie molto povere che non hanno la possibilità di allevarli. A nove mesi Robi contrasse la poliomielite e rimase paralizzato. Oggi, grazie alla fisioterapia di sr. Gertrude e alle cure amorevoli delle suore e della signora che ha accettato di fargli da madre, si muove in maniera autonoma con la sedia a rotelle, si è laureato e gioca a cricket”.
A nove mesi Robi contrasse la poliomielite e rimase paralizzato. Oggi, grazie alla fisioterapia di sr. Gertrude e alle cure amorevoli delle suore e della signora che ha accettato di fargli da madre, si muove in maniera autonoma con la sedia a rotelle, si è laureato e gioca a cricket”.
 L’albero dell’ulivo, tipico delle culture del Vicino Oriente, nella Bibbia è simbolo di pace, fecondità, benedizione.
L’albero dell’ulivo, tipico delle culture del Vicino Oriente, nella Bibbia è simbolo di pace, fecondità, benedizione.
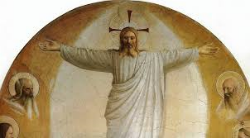 Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.
Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.
 L’unione della Madre con il Figlio nell’opera della Redenzione raggiunge il culmine sul Calvario, dove Cristo offrì se stesso quale vittima immacolata a Dio (Eb 9,14) e dove Maria stette presso la Croce (cfr Gv 19,25), soffrendo profondamente con il suo Unigenito e associandosi con animo materno al sacrificio di lui, amorosamente consenziente all’immolazione della vittima da lei generata e offrendola anch’ella all’eterno Padre.
L’unione della Madre con il Figlio nell’opera della Redenzione raggiunge il culmine sul Calvario, dove Cristo offrì se stesso quale vittima immacolata a Dio (Eb 9,14) e dove Maria stette presso la Croce (cfr Gv 19,25), soffrendo profondamente con il suo Unigenito e associandosi con animo materno al sacrificio di lui, amorosamente consenziente all’immolazione della vittima da lei generata e offrendola anch’ella all’eterno Padre.