Dal Vangelo di Marco Mc 1,12-15
 E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».
…………………………………………………
In questa prima domenica di Quaresima sembra che Gesù ci indichi come vivere il grande dono della Quaresima. Un tempo davvero di grazie che non può essere consegnato alla normalità, troppe volte senza senso.
E per ottenere che questo tempo, e non solo, sia vissuto bene, il Vangelo ci avverte:
“In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto ed egli vi rimase quaranta giorni, tentato da satana: stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni (Battista) fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio, e diceva: ‘Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino: convertitevi e credete al Vangelo” (Mc. l, 12-15)
Un programma denso di significato, ma che Gesù riassume con due parole dal contenuto difficile ma innovativo: convertirsi e credere al Vangelo!
Ma sapremo, in ogni modo, pone al centro della nostra vita, in questo tempo santo, l’urgenza di una necessaria conversione, con la guida del Vangelo? Lasciamoci condurre dalle parole a noi sempre preziose di Paolo VI.
“Dobbiamo dunque convertirci al Signore. Qui sarebbe necessaria un’analisi previa. Che cosa vuol dire questa parola «conversione», alla quale la nostra mente moderna è così poco disposta, fino quasi a cancellarla dal dizionario stesso della vita spirituale? Qual è il vero significato di tale richiamo? A cominciare da quello etimologico, molto semplice, convertirsi vuol dire cambiare strada, scegliere una direzione, un indirizzo. Ebbene la Quaresima chiama tutti a rivolgersi a Dio; a tracciare fra noi e il Signore una linea diretta, quella completa attenzione che molte volte è distratta dalle cose profane, con le faccende quotidiane, gli affanni della vita.
Occorre, invece, che risplenda su tutta questa esperienza così complessa, talvolta confusa e talvolta non del tutto limpida, lo splendore del raggio di immediatezza che ci indica Iddio.
E non si tratta di muoverci verso di Lui materialmente, fisicamente: sarebbe già gran cosa, perché ciò implica la pratica degli esercizi che a Dio ci portano.
C’è assai di più. Sappiamo tutti che la parola «conversione» indica un senso di mutamento, di rivolgimento, di metànoia: il rinnovarsi, cioè. Ora ed è ciò che più conta – tale rivolgimento non tocca tanto le cose esteriori, le abitudini, le vicende a cui è legata la nostra esistenza, bensì, invece, la cosa tanto nostra, e tanto poco nostra: il cuore.
C’è non poco da cambiare dentro di noi: è necessario rimodellare la nostra mentalità; avere il coraggio di entrare fin nel segreto della nostra coscienza, dei nostri pensieri, e là operare un cambiamento. Questo, inoltre, deve essere così vivo e sincero da produrre – e siamo ancora al contenuto della parola «conversione» – una novità.
Qui sta l’esigenza prima del grande esercizio ascetico e penitenziale della Quaresima. Allora ci chiediamo: che cosa fare per ottenere un tale risultato e come comportarci?
La risposta è ovvia: entrare in se stessi, riflettere sulla propria persona, acquisire una nozione chiara di quel che siamo, vogliamo e facciamo; e, a un certo momento – qui la frase drammatica, ma risolutiva – convertire, rompere qualche cosa di noi, spezzare questo o quell’elemento che magari ci è molto caro ed a cui siamo abituati, sì da non rinunciarvi facilmente.
Il termine «conversione» entra in queste profondità e dimostra queste esigenze.
E non è tutto. Stabilito il rinnovamento, è d’uopo incominciare di nuovo, far sorgere in noi un po’ di primavera, di rifioritura; una manifestazione anche esteriore del fenomeno verificatosi all’interno del nostro essere. Si diceva poco fa’ che ricordare queste nozioni a chi già conosce le vie del Signore, ha ormai vissuto le ore decisive ed ha orientato nella maniera giusta la sua vita, sembrerebbe cosa superflua, convenzionale e quasi retorica. Così non è: perché tutti abbiamo sempre bisogno di convertirci.
C’è un bel paragone, addotto da esperto maestro di spirito. Esso si riferisce al navigante il quale deve, di continuo, rettificare la guida del timone, e perciò guardare che la direzione sia sempre quella esatta indicata dalla bussola. Per sua natura, la nostra vita è incline a deviare. Siamo volubili, fragili; i nostri stati d’animo sono contraddittori, successivi, complicati, e soggetti agli stimoli esteriori, al punto che la nostra rettitudine interiore ne risulta compromessa.
È perciò logico, indispensabile ad ogni stagione ed anno, ad ogni Quaresima, riportarci al buon cammino primitivo se già fu determinato; trovare la direzione giusta se non fosse ancora allineata perpendicolarmente verso il Signore. A così alta finalità mirano i doni e i carismi che la santa Quaresima ci offre. Come si fa a convertirsi?
Il primo passo – tutti lo sappiamo – consiste nell’ascoltare, sentire il richiamo e orientare la nostra mente là donde parte la voce. Questa voce è la parola di Dio, che deve risuonare sempre nuova, e quale eco personale che il Signore suscita nelle nostre anime.
Oh, come piacerebbe sostare in conversazione con ciascuna delle persone qui presenti e chiedere se hanno questa capacità di udito, se ascoltano la parola divina, a cominciare da quella che arriva dal di fuori con la sacra predicazione, che ora, nella Quaresima e nella riforma liturgica, diviene tanto organizzata, premurosa, sollecita, urgente. Abbiamo tutti questa indispensabile ricettività? o non forse imitiamo anche noi tanti superficiali, allorché mormorano: sono cose già note, già sentite, non sono per me… e così via? (3 marzo 1965). “Pregare non significa macinare ‘avemaria’ e poi essere lontani dalla legge del Signore; non è fare una doppia vita: fare delle scelte comode. Pregare significa soprattutto aderire alla volontà di Dio;
entrare nella logica del Vangelo che è la logica della povertà, la logica della accoglienza, la logica del servizio, la logica della fiducia, la logica della speranza.
Logica di SPERANZA .. soprattutto nei momenti difficili, quando le cose vanno di traverso, quando la salute non c’è più.
Coltivare la speranza significa non darsi mai per vinti: significa sapere che Dio è più forte di tutti i nostri problemi, e che alla fine la spunta; significa sapere infine che la morte non è l’ultimo capitolo della vita .. Questo significa preghiera e speranza”. (Tonino Bello)
 Definire l’ateismo al singolare può risultare un’operazione imprecisa e fuorviante; sarebbe più corretto parlare di ateismi, vista la varietà delle forme, dei contenuti e degli orientamenti. In ambito teologico la percezione è mutata profondamente e ha abbandonato i toni apologetici passando a un’attività di analisi e a una riflessione sulla testimonianza della speranza cristiana e della freschezza evangelica.
Definire l’ateismo al singolare può risultare un’operazione imprecisa e fuorviante; sarebbe più corretto parlare di ateismi, vista la varietà delle forme, dei contenuti e degli orientamenti. In ambito teologico la percezione è mutata profondamente e ha abbandonato i toni apologetici passando a un’attività di analisi e a una riflessione sulla testimonianza della speranza cristiana e della freschezza evangelica.


 Emozione, orgoglio, soddisfazione unanime per un progetto che ha visto protagonista l’intera città, ma anche senso di responsabilità e consapevolezza di un successo che non è un traguardo, ma tappa di un percorso che può e deve crescere e continuare a far crescere. Sono questi i sentimenti e le aspettative che hanno salutato l’annuncio di Parma Capitale della cultura 2020, avvenuto venerdì mattina a Roma. Una vittoria che, come preannunciato in un precedente comunicato congiunto con le amministrazioni di Reggio Emilia e Piacenza, le altre città emiliane arrivate tra le 10 finaliste, coinvolgerà anche l’area emiliana, in un’ottica di collaborazione e di alleanza. I doverosi festeggiamenti lasciano quindi subito posto all’agenda dei lavori. Così il vescovo Enrico Solmi ha salutato – in una nota diffusa dal Sir – tale riconoscimento: “Parma capitale della cultura, è un titolo ambito quanto plausibile. Perché la nostra città – insieme ad altre in Italia – si distingue per una ricca storia e per insigni monumenti che la rappresentano. Ricordo la splendida piazza del duomo sulla quale si affacciano la cattedrale, il coevo palazzo vescovile, il battistero, il palazzo che alloggia la Caritas, mentre da un lato si insinua un angolo del Seminario già residenza dei canonici. Chi arriva dai borghi rimane meravigliato da tale raccolta armonia che compone un insieme unico. Estendendo il raggio di osservazione, Parma offre tante altre opere, tra le quali spicca la gotica chiesa di San Francesco, deturpata sede di carcere napoleonico, per la quale si sta avviando un promettendo recupero. Essere capitale della cultura – lungi dalla tentazione di una vuota quanto possibile vanagloria – sollecita a riconoscere le fonti di tanta magnificenza e riconoscerle vive ancora oggi come fonti di un modo di vivere, buono, bello e accogliente che si proietta verso un futuro di speranza. Questo è l’impegno della città ed anche della Chiesa, che non sono soltanto custodi, ma attivi testimoni e propositori. Questo è un auspicio, ma ancor più, un impegno”.
Emozione, orgoglio, soddisfazione unanime per un progetto che ha visto protagonista l’intera città, ma anche senso di responsabilità e consapevolezza di un successo che non è un traguardo, ma tappa di un percorso che può e deve crescere e continuare a far crescere. Sono questi i sentimenti e le aspettative che hanno salutato l’annuncio di Parma Capitale della cultura 2020, avvenuto venerdì mattina a Roma. Una vittoria che, come preannunciato in un precedente comunicato congiunto con le amministrazioni di Reggio Emilia e Piacenza, le altre città emiliane arrivate tra le 10 finaliste, coinvolgerà anche l’area emiliana, in un’ottica di collaborazione e di alleanza. I doverosi festeggiamenti lasciano quindi subito posto all’agenda dei lavori. Così il vescovo Enrico Solmi ha salutato – in una nota diffusa dal Sir – tale riconoscimento: “Parma capitale della cultura, è un titolo ambito quanto plausibile. Perché la nostra città – insieme ad altre in Italia – si distingue per una ricca storia e per insigni monumenti che la rappresentano. Ricordo la splendida piazza del duomo sulla quale si affacciano la cattedrale, il coevo palazzo vescovile, il battistero, il palazzo che alloggia la Caritas, mentre da un lato si insinua un angolo del Seminario già residenza dei canonici. Chi arriva dai borghi rimane meravigliato da tale raccolta armonia che compone un insieme unico. Estendendo il raggio di osservazione, Parma offre tante altre opere, tra le quali spicca la gotica chiesa di San Francesco, deturpata sede di carcere napoleonico, per la quale si sta avviando un promettendo recupero. Essere capitale della cultura – lungi dalla tentazione di una vuota quanto possibile vanagloria – sollecita a riconoscere le fonti di tanta magnificenza e riconoscerle vive ancora oggi come fonti di un modo di vivere, buono, bello e accogliente che si proietta verso un futuro di speranza. Questo è l’impegno della città ed anche della Chiesa, che non sono soltanto custodi, ma attivi testimoni e propositori. Questo è un auspicio, ma ancor più, un impegno”.
 “E’ buono uscire da se stessi, alle periferie del mondo e dell’esistenza per portare Gesù!”. E’ il messaggio lanciato da papa Francesco ai giovani la domenica delle palme del 2013.
“E’ buono uscire da se stessi, alle periferie del mondo e dell’esistenza per portare Gesù!”. E’ il messaggio lanciato da papa Francesco ai giovani la domenica delle palme del 2013.
 (RC) sull’Aspromonte da mons. Giuseppe Cognata, allora vescovo di quella diocesi, vero e appassionato figlio di don Bosco e discepolo fedele di san Francesco di Sales del quale seguì lo zelo pastorale, la spiritualità, la dottrina, l’ottimismo.
(RC) sull’Aspromonte da mons. Giuseppe Cognata, allora vescovo di quella diocesi, vero e appassionato figlio di don Bosco e discepolo fedele di san Francesco di Sales del quale seguì lo zelo pastorale, la spiritualità, la dottrina, l’ottimismo.
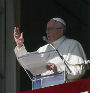


 Come ogni anno l’USMI Basilicata, ha programmato, il Convegno regionale formativo che sì svolto presso l’Hotel Heraclea di Policoro (MT) dall’11 al 13 febbraio c.a. per le circa 300 religiose presenti nel territorio. Hanno preso parte un centinaio di sorelle che hanno potuto partecipare perché la Regione ha concesso alla scuola il “ponte di carnevale” come festa.
Come ogni anno l’USMI Basilicata, ha programmato, il Convegno regionale formativo che sì svolto presso l’Hotel Heraclea di Policoro (MT) dall’11 al 13 febbraio c.a. per le circa 300 religiose presenti nel territorio. Hanno preso parte un centinaio di sorelle che hanno potuto partecipare perché la Regione ha concesso alla scuola il “ponte di carnevale” come festa.
 E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
 Le scalabriniane che accolgono i migranti venezuelani
Le scalabriniane che accolgono i migranti venezuelani
 La favola-mito della cura essenziale è di origine latina con base greca. La riporta Igino, scrittore del I secolo d.C.; se ne servirà Heidegger, quando analizzerà il tema della “Cura” (Sorge) in Essere e Tempo.
La favola-mito della cura essenziale è di origine latina con base greca. La riporta Igino, scrittore del I secolo d.C.; se ne servirà Heidegger, quando analizzerà il tema della “Cura” (Sorge) in Essere e Tempo.
 Fratel MichaelDavide Semeraro, monaco benedettino, all’indomani del Messaggio del Papa per la Quaresima, “rilegge” le tre pratiche quaresimali – preghiera, digiuno, elemosina – spiegando che “non sono fuori tempo”. La preghiera come apertura alla trascendenza, il digiuno come “disciplina” e l’elemosina come occasione per comprendere che “in ogni donna e in ogni uomo si nasconde un povero che attende di essere scoperto”.
Fratel MichaelDavide Semeraro, monaco benedettino, all’indomani del Messaggio del Papa per la Quaresima, “rilegge” le tre pratiche quaresimali – preghiera, digiuno, elemosina – spiegando che “non sono fuori tempo”. La preghiera come apertura alla trascendenza, il digiuno come “disciplina” e l’elemosina come occasione per comprendere che “in ogni donna e in ogni uomo si nasconde un povero che attende di essere scoperto”.