Fiat lux
 a ricordare la relazione costante che il cristiano deve avere con Dio, riproducendo nella sua esistenza quotidiana ciò che ha accolto credendo alla rivelazione (cfr. 1Gv 2,9-10: «Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello, rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo»), inoltre richiama innegabilmente il fatto che Dio è fonte, per il credente, di ogni bene, di vita e di salvezza, secondo l’abituale significato della metafora nel Nuovo Testamento. Si può dire che l’affermazione di 1Gv 1,5 presupponga che la pienezza e la potenza di vita stiano anzitutto (o forse “soltanto”) in Dio.
a ricordare la relazione costante che il cristiano deve avere con Dio, riproducendo nella sua esistenza quotidiana ciò che ha accolto credendo alla rivelazione (cfr. 1Gv 2,9-10: «Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello, rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo»), inoltre richiama innegabilmente il fatto che Dio è fonte, per il credente, di ogni bene, di vita e di salvezza, secondo l’abituale significato della metafora nel Nuovo Testamento. Si può dire che l’affermazione di 1Gv 1,5 presupponga che la pienezza e la potenza di vita stiano anzitutto (o forse “soltanto”) in Dio.
Nel Nuovo Testamento si ritrovano i valori simbolici della luce già individuati nell’Antico Testamento, ma con sottolineature peculiari e aspetti innovativi. Notiamo dapprima, però, un uso più concreto del termine: l’apparizione di una «luce dal cielo» (At 9,3; 22,6; 26,13) è legata all’epifania di Gesù Cristo a Paolo, così come l’apparizione di un angelo illumina la cella in cui Pietro è imprigionato (At 12,7); analogamente l’evento della trasfigurazione di Gesù è descritto facendo riferimento alla luce (cfr. Mt 17,2.5). Questa descrizione di particolari manifestazioni del divino come apparizioni di una «luce» si discosta dall’Antico Testamento che preferisce parlare del fuoco (cfr., p. es., Es 3,2; 19,18; 24,17). Probabilmente il riferimento alla luce, senza precisazione della sua fonte, veniva percepito dagli autori del Nuovo Testamento come rimando più adeguato alla trascendenza divina.
Dal punto di vista antropologico, interessante è il detto di Mt 6,22-23, che paragona l’occhio umano a una lampada, secondo un’immagine comune sia nel mondo greco che in quello giudaico: «La lampada del corpo è l’occhio; perciò, se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso; ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra!». Si faccia attenzione che il riferimento finale alla «luce» è probabilmente sempre un immagine dell’occhio: come organo della vista è ciò che consente che ci sia luce nella persona. Il detto, quindi, non fa tanto riferimento a una “illuminazione interiore”, ma al valore dello sguardo sulla realtà che si vive e sui rapporti con gli altri, che può essere «semplice» (cioè retto, limpido, mite) o «cattivo» (cioè, malizioso, invidioso, cupido). L’occhio esprime l’intenzionalità fondamentale che il soggetto applica alla realtà e questa si riflette sulla sua situazione complessiva di vita (rappresentata dal «corpo»), descritta come luminosa o tenebrosa. Nel brano parallelo l’evangelista Luca aggiunge un versetto («Se dunque il tuo corpo è tutto luminoso, senza avere alcuna parte nelle tenebre, sarà tutto nella luce, come quando la lampada ti illumina con il suo fulgore», Lc 11,36) che sembra suggerire che la vita di colui che ha lo sguardo «semplice» sia capace di diffondere luce; con ciò ci si ricollega all’interpretazione matteana del detto sulla lampada che non va nascosta (Mt 5,14-16 «Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli»).
Come si vede il fine della testimonianza, data dalle opere buone che sgorgano dallo sguardo semplice sulla realtà, è la glorificazione di Dio, il riconoscimento della sua paternità e del suo operare nella storia. Infatti diversi detti collegano l’immagine della luce al processo del pubblico manifestarsi e quindi della rivelazione: così è per il detto sulla lampada che non si può nascondere in Mc 4,21-22 («Diceva loro: “Viene forse la lampada per essere messa sotto il moggio o sotto il letto? O non invece per essere messa sul candelabro? Non vi è infatti nulla di segreto che non debba essere manifestato e nulla di nascosto che non debba essere messo in luce”»; cfr. Lc 8,16; 11,33) e per Mt 10,27 («Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze»; cfr. Lc 8,17; 12,2-3). Quello che Gesù annuncia, infatti, è di per se stesso destinato a diventare manifesto, in quanto espressione del disegno divino di salvezza che chiede all’uomo di essere accolto. Ma ciò significa, ovviamente, che Gesù stesso (o meglio: il Messia atteso) può essere definito «luce» (così in Mt 4,16, nella ripresa di Is 9,1; e in Lc 2,32): questo non tanto in relazione alla sua natura, ma piuttosto alla sua missione, che è quella di donare la salvezza divina (riprendendo quindi il valore simbolico della luce che si trova in diversi passi dell’Antico Testamento). La connessione fra luce e offerta della salvezza si può trovare anche nella parola apostolica (cfr At 13,47, dove Paolo e Barnaba applicano alla loro attività l’oracolo di Is 4,6, e Ef 3,8-9), ovviamente in quanto proclamazione del Vangelo di Gesù. Collegando questo a Mt 5,14-16 si vede come la vita dell’apostolo e discepolo debba essere improntata all’assoluta trasparenza luminosa del suo parlare e del suo agire in riferimento all’annuncio del Cristo.
La rappresentazione della rivelazione divina con la metafora della luce viene ripresa nelle lettere paoline, con alcuni tratti caratteristici. Anzitutto sottolinea la possibilità per il credente di conoscere o comprendere la realtà salvifica che gli viene donata (2Cor 4,6: «Dio, che disse: “Rifulga la luce dalle tenebre”, rifulse nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo»; cfr. anche Ef 1,17-18: «Il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di lui; illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi»). In questa stessa prospettiva il momento iniziale della vita cristiana, la conversione alla fede in Gesù Cristo può essere definita come «illuminazione» (cfr. Eb 6,4; Eb 10,32; secondo alcuni autori questi passi farebbero riferimento al battesimo, ma non è certo; l’uso del termine «illuminazione» per indicare il battesimo si trova però nel II secolo d.C, negli scritti di Giustino). In secondo luogo la manifestazione del Cristo è anche svelamento di ciò che si trova nella profondità del cuore umano (1Cor 4,5 «Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori; allora ciascuno riceverà da Dio la lode»; cfr. Ef 5,13 dove l’accento è però sulla condanna) e quindi vale come giudizio. In questo la prospettiva escatologica (cioè quella della fine dei tempi) e quella etica (relativa alla prassi quotidiana) si intrecciano. Infatti il cristiano, accogliendo la salvezza di Cristo, è reso già ora «capace di partecipare alla sorte dei santi nella luce» (Col 1,12): in questo versetto si deve evidentemente intendere la «luce» come una metafora della comunione con la divinità. D’altra parte sono ripetuti gli inviti a vivere nella luce e a rifiutare le opere delle tenebre, dove l’immagine si riferisce senz’altro alla rettitudine dell’agire (cfr Rm 13,12; Ef 5,8-9); anzi il richiamo alla separazione primordiale fra luce e tenebre (2Cor 4,6) spiega anche la calda esortazione a uno stile di vita chiaramente distinto da quello dei non-credenti (2Cor 6,14 «Non lasciatevi legare al giogo estraneo dei non credenti. Quale rapporto infatti può esservi fra giustizia e iniquità, o quale comunione fra luce e tenebre?»). L’idea della separazione e della distinzione rispetto ai non credenti, sia dal punto di vista etico sia da quello della speranza nella vita futura, soggiace probabilmente anche all’uso dell’espressione «figli della luce» (cfr. Lc 16,8; Gv 12,36; Ef 5,8; 1Ts 5,5) che non si trova nell’Antico Testamento, ma è frequente nei testi di Qumran.
Nel Vangelo di Giovanni è Gesù stesso a definirsi «luce del mondo» (Gv 8,12; 9,5; cfr. 12,35-36.46) e il significato dell’immagine è duplice: da una parte, infatti, sottolinea il ruolo di Gesù nella Rivelazione, anzi il suo essere la Rivelazione stessa (la «verità» nel linguaggio giovanneo) che va accolta con fede (non a caso la definizione di Gv 9,5 apre il racconto del miracolo di guarigione del cieco nato che non solo riacquista la vista, ma giunge alla fede); dall’altra la connessione fra luce e vita riprende il tema della salvezza, ovvero della pienezza di vita, offerta da Dio agli uomini in Gesù. La connessione tra luce e vita, che risale all’esperienza basilare dell’essere umano e che veniva affermata dal racconto di Gen 1, viene ripresa in forma marcatamente cristologica, affermando che tale connessione dipende dal “Verbo” sin dal «principio» (cfr. Gv 1,4 «In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini») e va accolta dall’uomo credendo in Gesù di Nazareth. Chi rifiuta la sua persona si trova di fatto nelle «tenebre» (Gv 3,19-21; cfr. 11,9-10): in tal senso la rivelazione e l’offerta di salvezza sono anche giudizio, perché smascherano alcune situazioni o posizioni esistenziali come radicalmente opposte alla volontà divina di vita e quindi apportatrici di morte.
Nella prima lettera di Giovanni la «luce» non è posta come predicato di Gesù, ma di Dio (1Gv 1,5: «Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che noi vi annunciamo: Dio è luce e in lui non c’è tenebra alcuna»). Questo non va inteso come una pura definizione dell’essenza divina, cosa che tra l’altro comporterebbe di intendere il vocabolo «luce» in senso concreto e non metaforico, perché il contesto immediatamente seguente mette in rapporto tale affermazione con la condotta concreta dei credenti, che devono «camminare nella luce» (1Gv 1,7). L’immagine serve quindi anzitutto a ricordare la relazione costante che il cristiano deve avere con Dio, riproducendo nella sua esistenza quotidiana ciò che ha accolto credendo alla rivelazione (cfr. 1Gv 2,9-10: «Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello, rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo»), inoltre richiama innegabilmente il fatto che Dio è fonte, per il credente, di ogni bene, di vita e di salvezza, secondo l’abituale significato della metafora nel Nuovo Testamento. Si può dire che l’affermazione di 1Gv 1,5 presupponga che la pienezza e la potenza di vita stiano anzitutto (o forse “soltanto”) in Dio.
Filippo Serafini,
docente di Sacra Scrittura, Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare, Roma
Liberamente tratto da DISF.org
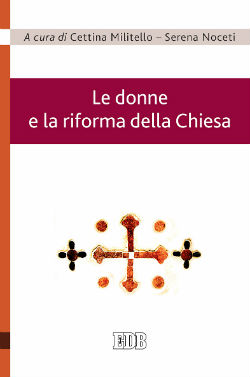 Il volume raccoglie i contributi del XIII colloquio dell’Istituto “Costanza Scelfo” per i problemi dei laici e delle donne nella Chiesa, su Le donne e la riforma della Chiesa, svoltosi a Roma dal 27 al 29 aprile 2017.
Il volume raccoglie i contributi del XIII colloquio dell’Istituto “Costanza Scelfo” per i problemi dei laici e delle donne nella Chiesa, su Le donne e la riforma della Chiesa, svoltosi a Roma dal 27 al 29 aprile 2017.


 In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo.
In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo.
 In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.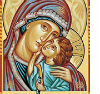
 Maria, la rivoluzione della tenerezza
Maria, la rivoluzione della tenerezza
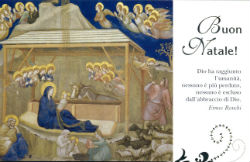 La Vergine ci offre suo Figlio come principio di vita nuova.
La Vergine ci offre suo Figlio come principio di vita nuova.
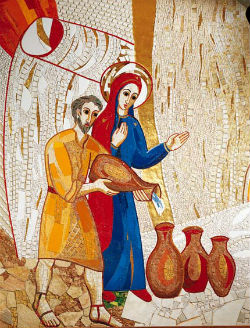 Il Polo Lionello Bonfanti – E. di C. Spa organizza la quarta edizione del Corso per Superiore/i, Consigli Generali/ Provinciali, Econome/i e in generale coloro che hanno un ruolo di governo e/o responsabilità all’interno di Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica e/o loro opere
Il Polo Lionello Bonfanti – E. di C. Spa organizza la quarta edizione del Corso per Superiore/i, Consigli Generali/ Provinciali, Econome/i e in generale coloro che hanno un ruolo di governo e/o responsabilità all’interno di Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica e/o loro opere
 a ricordare la relazione costante che il cristiano deve avere con Dio, riproducendo nella sua esistenza quotidiana ciò che ha accolto credendo alla rivelazione (cfr. 1Gv 2,9-10: «Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello, rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo»), inoltre richiama innegabilmente il fatto che Dio è fonte, per il credente, di ogni bene, di vita e di salvezza, secondo l’abituale significato della metafora nel Nuovo Testamento. Si può dire che l’affermazione di 1Gv 1,5 presupponga che la pienezza e la potenza di vita stiano anzitutto (o forse “soltanto”) in Dio.
a ricordare la relazione costante che il cristiano deve avere con Dio, riproducendo nella sua esistenza quotidiana ciò che ha accolto credendo alla rivelazione (cfr. 1Gv 2,9-10: «Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello, rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo»), inoltre richiama innegabilmente il fatto che Dio è fonte, per il credente, di ogni bene, di vita e di salvezza, secondo l’abituale significato della metafora nel Nuovo Testamento. Si può dire che l’affermazione di 1Gv 1,5 presupponga che la pienezza e la potenza di vita stiano anzitutto (o forse “soltanto”) in Dio.
 Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa». Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa». Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.

 Navighiamo in un mondo di distrazione crescente e di relazioni personali sempre più in pericolo. Il male, sotto forme diverse, germoglia un po’ ovunque. Fin troppo facile snocciolarne il lungo elenco. Ma è certo – come assicurava Teresa di Calcutta – che fra tutti i mali, il peggiore che può soffrire un essere umano è la mancanza di affetto. Eppure anche nella fotografia più scura fanno capolino piccole luci di speranza, accese da chi senza clamore non s’arrende e non rinuncia ad essere se stesso, con dignità; il suo sguardo vede e soccorre chi incontra; svolge il suo compito responsabilmente; fa del bene nelle situazioni più ordinarie… Gente normale, insomma. Inconsapevolmente eroica. Gente che nella fatica quotidiana conosce la gioia di imparare a sintonizzarsi sugli altri in modo genuino. E nel nostro mondo argina l’imperante disaffezione alle idee, all’impegno, alla fede…
Navighiamo in un mondo di distrazione crescente e di relazioni personali sempre più in pericolo. Il male, sotto forme diverse, germoglia un po’ ovunque. Fin troppo facile snocciolarne il lungo elenco. Ma è certo – come assicurava Teresa di Calcutta – che fra tutti i mali, il peggiore che può soffrire un essere umano è la mancanza di affetto. Eppure anche nella fotografia più scura fanno capolino piccole luci di speranza, accese da chi senza clamore non s’arrende e non rinuncia ad essere se stesso, con dignità; il suo sguardo vede e soccorre chi incontra; svolge il suo compito responsabilmente; fa del bene nelle situazioni più ordinarie… Gente normale, insomma. Inconsapevolmente eroica. Gente che nella fatica quotidiana conosce la gioia di imparare a sintonizzarsi sugli altri in modo genuino. E nel nostro mondo argina l’imperante disaffezione alle idee, all’impegno, alla fede…