 religiose) e le congregazioni religiose è stato istituito il TAVOLO CURA per il confronto e la progettazione nell’ambito della cura delle Religiose anziane e malate.
religiose) e le congregazioni religiose è stato istituito il TAVOLO CURA per il confronto e la progettazione nell’ambito della cura delle Religiose anziane e malate.
Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

 religiose) e le congregazioni religiose è stato istituito il TAVOLO CURA per il confronto e la progettazione nell’ambito della cura delle Religiose anziane e malate.
religiose) e le congregazioni religiose è stato istituito il TAVOLO CURA per il confronto e la progettazione nell’ambito della cura delle Religiose anziane e malate.

Nelle Filippine l’Associazione dei Superiori Maggiori “ha invitato tutte le Congregazioni religiose del Paese a dotarsi di speciali uffici dedicati al cambiamento climatico e così coordinare la loro azione sul fronte dell’emergenza ambientale”. In una sua recente Assemblea essa – rispondendo così all’appello lanciato da Papa Francesco nell’Enciclica Laudato si’ – ha deciso di mettere la “giustizia climatica” tra le sue priorità sulla cura della casa comune. Con questa iniziativa essa intende seguire l’esempio della Federazione delle Conferenze episcopali asiatiche (Fabc), che, recentemente, ha istituito un Climate Change Desk e punta a creare un ufficio dedicato al cambiamento climatico in ciascuna Conferenza episcopale del continente. I nuovi uffici lavoreranno in stretta collaborazione con le associazioni cattoliche impegnate sul fronte ambientale e, in particolare, con il Global Catholic Climate Movement (Gccm), la rete cattolica globale sui cambiamenti climatici creata lo scorso gennaio in vista del Summit mondiale sul clima (Cop 21) che si terrà a Parigi il prossimo dicembre.
L’associazione si è inoltre impegnata a diffondere e far conoscere l’enciclica Laudato si’ tra i fedeli. “L’obiettivo – si legge nella dichiarazione – è di fare maturare una consapevolezza e una ‘spiritualità ecologica che siano inserite nel contesto dei carismi di ciascuna Congregazione religiosa’ e del loro impegno per l’ambiente, la gestione dei disastri, la buona governance, la lotta alla corruzione e la promozione della pace”.
Un coinvolgimento globale – ben organizzato – di ognuno e di tutti, delle comunità e dei singoli. Non basta più guardare al povero o alla famiglia indigente della porta accanto e al mendicante sul marciapiede sotto casa. Non bastano più – anche se sempre e comunque necessarie e non sopprimibili – le molteplici mense e le plurime case-famiglia. Lo sguardo, l’attenzione, l’impegno di tutti e di ognuno – anche soprattutto dei consacrati – hanno immancabilmente una ampiezza umano-cosmica. E’ ritornare all’eden, nei primordi della storia umana. Là dove il primo uomo scoperse con gioioso stupore e ferma attrattiva l’altro essere diverso e certamente simile a sé, ma soprattutto suo complementare, insieme chiamati valorare e custodire, lavorare, far produrre quello che oggi è definito da papa Francesco “casa comune”. Tutto è inscindibilmente legato a tutti e a tutto. Da allora. Tutte e tutti sciamo insieme – inscindibilmente – legati alla questione umano-ambientale. Uomo e ambiente dei e nei vari continenti perché tutti e tutto sia conforme a quell’iniziale mandato. (Da: Bollettino radiogiornale, 07.08.2015).

ISTITUTO SUORE FRANCESCANE ALCANTARINE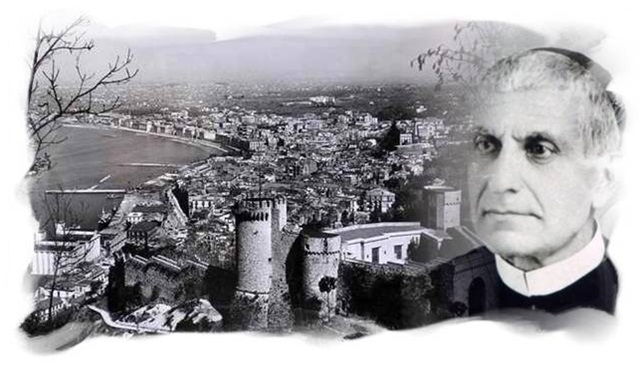
La nostra storia
 Dal 1867 il curato don Vincenzo Gargiulo, allo scopo di porre rimedio alla situazione di miseria e degrado sociale della zona, aveva attivato numerose iniziative parrocchiali di catechesi e sostegno sociale ai più poveri. Nella sua opera si avvaleva del contributo di suor Maria Agnese Russo, terziaria francescana, e di un gruppo di giovani della parrocchia.
Dal 1867 il curato don Vincenzo Gargiulo, allo scopo di porre rimedio alla situazione di miseria e degrado sociale della zona, aveva attivato numerose iniziative parrocchiali di catechesi e sostegno sociale ai più poveri. Nella sua opera si avvaleva del contributo di suor Maria Agnese Russo, terziaria francescana, e di un gruppo di giovani della parrocchia. Il nostro carisma
Il nostro carisma  La nostra missione
La nostra missione Il nostro slancio missionario, è a servizio della missione del Figlio di Dio per rendere testimonianza alla voce di Lui con la parola e con le opere.
Il nostro slancio missionario, è a servizio della missione del Figlio di Dio per rendere testimonianza alla voce di Lui con la parola e con le opere.

“Dio si stanca dei grandi regni, mai dei piccoli fiori” (Tagore).
 EDITORIALE
EDITORIALE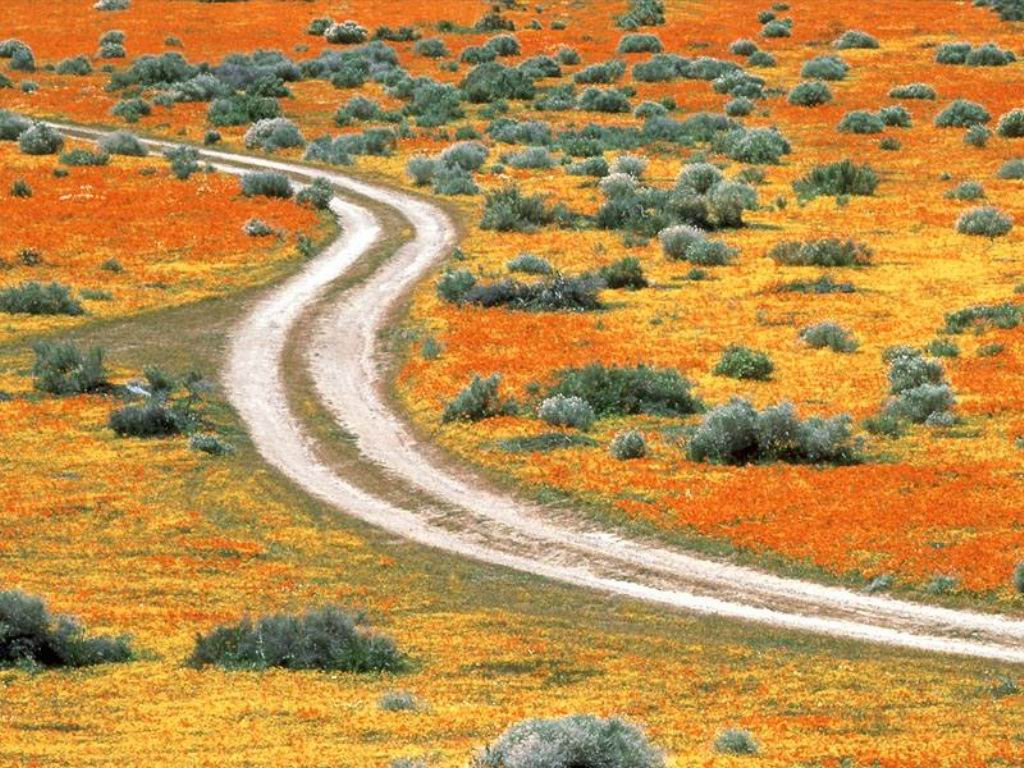
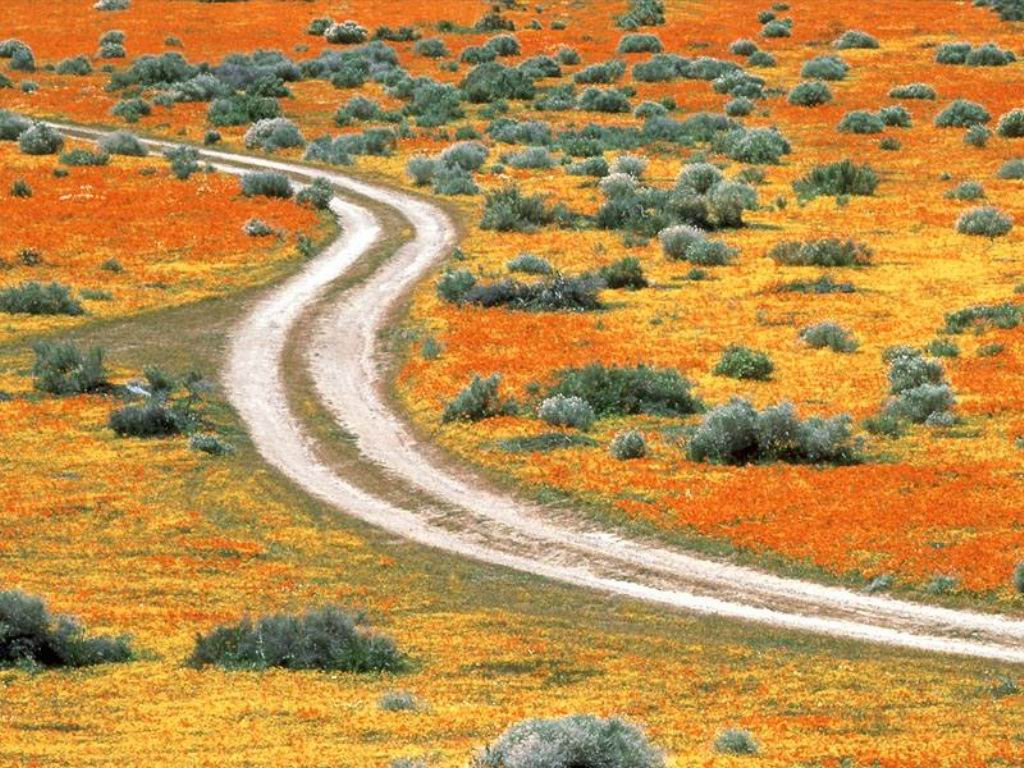 Perché ‘Gioia di servire’? Il tema è sicuramente impopolare oggi e così diverso dai ‘valori’ che la società moderna propone. Papa Francesco a più riprese richiama sul fatto che la salute di un cristiano si vede dalla gioia. Ma non basta certo avere l’idea chiara di felicità per sapere come viverla secondo lo stile del Vangelo. Neppure è sufficiente affermare sono felice con Dio e questo mi basta perché la vita sia felicemente consacrata. Parole e propositi si misurano e si verificano nel vissuto quotidiano con gli altri e per gli altri. Certamente in ogni tappa del cammino, per tutti – credenti e religiosi compresi – rimane il rischio di cadere nell’individualismo che oggi chiude la vita interiore nella ricerca spasmodica dell’avere per sé o per brillare agli occhi degli altri. Il che finisce per trasformare in persone risentite e senza vita. Certo è istintivo per tutti fare dei propri desideri l’assoluto e persino scambiare la fede con le proprie sicurezze… La domanda è se e come ci si lascia interpellare dal Vangelo; se davvero se ne fa il vademecum per la vita di ogni giorno e per le scelte che ognuno, nel proprio piccolo spazio, è chiamato ad operare. La via per entrare nella gioia di servire è fondarsi sulla umile scoperta – poi consapevolezza crescente e sconvolgente esperienza – che Dio ci ama. Lontano da Lui l’amore si fa sempre accaparratore.
Perché ‘Gioia di servire’? Il tema è sicuramente impopolare oggi e così diverso dai ‘valori’ che la società moderna propone. Papa Francesco a più riprese richiama sul fatto che la salute di un cristiano si vede dalla gioia. Ma non basta certo avere l’idea chiara di felicità per sapere come viverla secondo lo stile del Vangelo. Neppure è sufficiente affermare sono felice con Dio e questo mi basta perché la vita sia felicemente consacrata. Parole e propositi si misurano e si verificano nel vissuto quotidiano con gli altri e per gli altri. Certamente in ogni tappa del cammino, per tutti – credenti e religiosi compresi – rimane il rischio di cadere nell’individualismo che oggi chiude la vita interiore nella ricerca spasmodica dell’avere per sé o per brillare agli occhi degli altri. Il che finisce per trasformare in persone risentite e senza vita. Certo è istintivo per tutti fare dei propri desideri l’assoluto e persino scambiare la fede con le proprie sicurezze… La domanda è se e come ci si lascia interpellare dal Vangelo; se davvero se ne fa il vademecum per la vita di ogni giorno e per le scelte che ognuno, nel proprio piccolo spazio, è chiamato ad operare. La via per entrare nella gioia di servire è fondarsi sulla umile scoperta – poi consapevolezza crescente e sconvolgente esperienza – che Dio ci ama. Lontano da Lui l’amore si fa sempre accaparratore.
La gioia di servire non può quindi prescindere dalla fatica di passare dall’egocentrismo alla relazione. È terribile essere amati per ciò che si fa e non per ciò che si è: fa immaginare che “le persone intorno a noi guardino sempre e solo il ‘brutto’ che è dentro di noi; e questo sguardo è intollerabile” (J. Vanier). Allora ci si difende, si diventa duri, persino violenti. In ognuno c’è qualcosa di straordinariamente bello e integro. E di tutto questo il nostro mondo ha estremo bisogno perché in fondo al cuore di ognuno, più a fondo di ogni ferita, c’è un bambino in cerca di tenerezza… Dio, basterebbe una piccola scintilla di pura amicizia – e si sarebbe salvi; di amore – e si sarebbe redenti. Una mano tesa, un volto, uno sguardo aiutano a ritrovare l’immagine positiva di sé. Ma se la ‘mano tesa’ che dice ‘ti voglio bene’ non è sincera o non è fedele; se dice ‘ti amo’ solo perché lo ha imparato sui libri o semplicemente perché si ritiene autorizzata a dirlo, allora quel ‘bambino’ non oserà più prendere la mano che gli viene tesa e gli sarà insopportabile sentire qualcuno che dice: abbi fiducia!
È decisivo sapere quale padrone si serve, a chi ci si affida perché il Regno della gioia si sviluppi e cresca e diventi un grande albero alla cui ombra tanti possano trovare ospitalità.
Luciagnese Cedrone, ismc

Chiesa sinodale in cammino
Come la Chiesa deve rispondere e “intercettare” i cambiamenti che interessano la famiglia nella società contemporanea? Rispondere a tale interrogativo è stato uno degli obiettivi del Sinodo straordinario dei vescovi del 2014. Ora è al via la seconda assemblea sinodale voluta da Papa Francesco sullo stesso tema: La Vocazione della Famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo.
La scelta delle due tappe ha consentito la più ampia possibilità di confronto e anche una evoluzione del dibattito nella Chiesa in vista di una mediazione condivisa fra i padri sinodali. Secondo il desiderio di Francesco proposte e riflessioni sono arrivate a Roma dai quattro angoli del mondo, da diverse Chiese locali, gruppi e comunità… Voci variegate che ora arricchiscono l’Instrumentum laboris, frutto e sintesi delle risposte al ‘questionario preparatorio’, ‘traccia di lavoro’ per il sinodo ordinario, che aprirà i suoi lavori il 4 ottobre prossimo. Peccato solo che non vi sia alcun cenno sul celibato in vista del Regno!…
In una situazione di enorme «fragilità»…
La famiglia è realtà “ferita” a causa di contraddizioni culturali e sociali, di natura socio-politica e socio- economica… Le giovani generazioni mostrano serie difficoltà ad “essere” e “pensarsi” come una famiglia, mentre una cultura ostile ha ridotto la tensione verso la famiglia al desiderio di costruire dei simulacri temporanei di essa. Certo ci vuole coraggio per formare una famiglia, riconosce Bergoglio. E insieme al coraggio è necessaria una grande consapevolezza: il matrimonio è una vera e propria vocazione, come lo sono il sacerdozio e la vita religiosa.
… ma intatta nella propria «forza»
La famiglia, progetto di Dio per gli essere umani, resta il “pilastro fondamentale e irrinunciabile del vivere sociale” e l’architrave dell’intera umanità, in quanto capace di reggere tutto il peso del suo tessuto connettivo. Le divisioni al suo interno si sconfiggono solo con l’amore. È fonte di grande speranza, perché cellula che dà vita alla spina dorsale del corpo sociale. Il matrimonio consacrato da Dio custodisce quel legame tra l’uomo e la donna che Dio ha benedetto fin dalla creazione del mondo; ed è fonte di pace e di bene per l’intera vita coniugale e familiare. La famiglia, in sintesi, è la comunità che risponde concretamente alla polverizzazione della collettività. E davvero è l’isola che permette all’acqua della società liquida di non invadere tutto il mondo. Comunità responsabile, prevale infatti sul disimpegno e sul consumismo dei sentimenti. Forse è il più grande gesto controcorrente della società attuale.
Luciagnese Cedrone, ismc
lucia.agnese@tiscali.it

 “Si posseggono solo i regali, non le prede”. Lo ha scritto Jean Bastaire nel suo libro Eros redento. Chi non ha mai provato quel dolce turbamento che assale quando sul tavolo, sul comodino, forse sul cuscino, o ‘nascosto’ in un cassetto trova, inatteso, un piccolo pacco dall’aspetto delizioso e con il proprio nome? Un pacchetto deposto lì da una mano amica, un cuore gentile.
“Si posseggono solo i regali, non le prede”. Lo ha scritto Jean Bastaire nel suo libro Eros redento. Chi non ha mai provato quel dolce turbamento che assale quando sul tavolo, sul comodino, forse sul cuscino, o ‘nascosto’ in un cassetto trova, inatteso, un piccolo pacco dall’aspetto delizioso e con il proprio nome? Un pacchetto deposto lì da una mano amica, un cuore gentile.