10. Gesù, Parola fatta carne, nel secondo Testamento
 Come all’origine della fede ebraica non vi è il libro sacro, ma l’incontro con la Parola così all’origine della fede cristiana non vi sono i libri sacri ma la persona di Gesù, che con la sua predicazione, le sue opere, la sua morte e risurrezione porta a compimento la rivelazione di Dio. A differenza dei profeti che parlano a nome di Dio: «Così dice il Signore», Gesù afferma di essere in persona la Parola: «In verità (Amen), io vi dico». Egli con autorevolezza riconosce la validità perenne delle Scritture ebraiche, ma le interpreta in maniera nuova, imprimendo loro un orientamento nuovo (Mt 5,17). La sua persona e la sua parola valgono molto di più del tempio, della legge, dei profeti (Mt 5,21-48; 12,6; 24,35). Gesù è la rivelazione definitiva di Dio (Eb 1,1-2) che si manifesta nella parola di Dio diventata carne, cioè, persona umana, storia (Gv 1,14). La prima comunità cristiana lo riconosce come il «Signore» (Kyrios in greco, il termine che nella traduzione greca della Bibbia era usato per indicare il nome ebraico impronunziabile di JHWH). Gesù Kyrios è l’unico nome che salva (At 4,12) e la sua parola è sacra come quella di JHWH.
Come all’origine della fede ebraica non vi è il libro sacro, ma l’incontro con la Parola così all’origine della fede cristiana non vi sono i libri sacri ma la persona di Gesù, che con la sua predicazione, le sue opere, la sua morte e risurrezione porta a compimento la rivelazione di Dio. A differenza dei profeti che parlano a nome di Dio: «Così dice il Signore», Gesù afferma di essere in persona la Parola: «In verità (Amen), io vi dico». Egli con autorevolezza riconosce la validità perenne delle Scritture ebraiche, ma le interpreta in maniera nuova, imprimendo loro un orientamento nuovo (Mt 5,17). La sua persona e la sua parola valgono molto di più del tempio, della legge, dei profeti (Mt 5,21-48; 12,6; 24,35). Gesù è la rivelazione definitiva di Dio (Eb 1,1-2) che si manifesta nella parola di Dio diventata carne, cioè, persona umana, storia (Gv 1,14). La prima comunità cristiana lo riconosce come il «Signore» (Kyrios in greco, il termine che nella traduzione greca della Bibbia era usato per indicare il nome ebraico impronunziabile di JHWH). Gesù Kyrios è l’unico nome che salva (At 4,12) e la sua parola è sacra come quella di JHWH.
La parola di Gesù ‘Verbum Domini’ è testimoniata nei 27 libri nel Nuovo Testamento, ma tra questi eccelle il Vangelo che significa buona notizia.
«A nessuno sfugge che tra tutte le Scritture, anche quelle del Nuovo Testamento, i Vangeli possiedono una superiorità meritata, in quanto costituiscono la principale testimonianza relativa alla vita e alla dottrina del Verbo incarnato, nostro Salvatore. La Chiesa ha sempre e in ogni luogo ritenuto e ritiene che i quattro Vangeli sono di origine apostolica. Infatti, ciò che gli apostoli per mandato di Cristo predicarono, in seguito, per ispirazione dello Spirito Santo, fu dagli stessi e da uomini della loro cerchia tramandato in scritti che sono il fondamento della fede, cioè l’Evangelo quadriforme secondo Matteo, Marco, Luca e Giovanni » (DV 18)
I vangeli si sono formati tra gli anni 70 e 90 d.C. Tre persone autorevoli della Chiesa primitiva Marco a Roma, Matteo in Palestina, Luca ad Antiochia, mossi dallo Spirito, decisero, tenendo conto delle esigenze di queste diverse comunità, di presentare secondo un’ottica catechetico –pastorale, il racconto della vita e dei miracoli, della morte e risurrezione del loro Maestro, Gesù di Nazareth. Dopo qualche anno, con uno stile diverso, ma affascinante, sorge il Vangelo secondo Giovanni.
I quattro Vangeli sono, in forma diversa, un solo VANGELO, l’unica «bella, buona notizia» di quanto Dio abbia amato l’umanità. Il termine Vangelo appare nel primo versetto del Vangelo secondo Marco e costituisce il titolo della sua opera: «Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio». La diversa presentazione di Gesù, che i quattro evangelisti offrono, aiuta a capire che il Vangelo redatto da Marco non è quello di Luca o di Matteo o di Giovanni. Per questo motivo si dice «Vangelo secondo Marco, secondo Matteo, secondo Luca, secondo Giovanni». Il Vangelo è uno e, in quanto buona/bella notizia che riguarda Gesù, ci giunge nell’interpretazione di Matteo, Marco, Luca, e Giovanni. I Vangeli interpretano la vita, il messaggio, la storia di Gesù. Questa memoria interpretativa non toglie nulla alla storicità di Gesù, anzi la valorizza perché restituisce nell’oggi la sua perenne attualità.
«I quattro su indicati Vangeli, di cui la Chiesa afferma senza esitazione la storicità, trasmettono fedelmente quanto Gesù Figlio di Dio, durante la sua vita tra gli uomini, effettivamente operò e insegnò per la loro eterna salvezza, fino al giorno in cui fu assunto in cielo (cfr. At 1,1-2)» (cfr. DV 19)
L’evangelista Luca all’inizio del suo Vangelo precisa che scrive con attenzione e responsabilità ciò che riguarda Gesù per aiutare i cercatori di Dio (Teofilo) a dare solidità alla propria fede.
«Poiché molti hanno messo mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi, come ce li hanno trasmessi chi ne furono testimoni fin da principio e divennero ministri della parola, così ho deciso anch’io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne per te un resoconto ordinato, illustre Teòfilo, perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto» (Lc 1, 1-4)
Una interessante sintesi dei quattro Vangeli
Alcuni definiscono il Vangelo di Marco: Vangelo del catecumeno, perché ha lo scopo di aiutare colui che viene introdotto alla fede a diventare discepolo del Signore. Il Vangelo di Matteo, invece, è il Vangelo del catechista, il Vangelo che aiuta colui che deve introdurre altri alla fede. In questo Vangelo, Gesù è il maestro che insegna. Il Vangelo di Luca è il Vangelo del discepolo /testimone, vale a dire, di colui che avendo intrapreso la sequela di Gesù vuole seguirlo fedelmente, fino alla fine, nonostante tutto. Giovanni, infine, è il Vangelo del presbitero, o del cristiano maturo e contemplativo che riesce ad avere una visione profonda e unitaria dei vari misteri della salvezza.
Differenza tra cronaca e interpretazione
Gli evangelisti non hanno voluto fare una cronaca su Gesù, non hanno voluto dire chi è Gesù, che cosa ha fatto, che cosa ha detto, in maniera neutrale. Gli evangelisti hanno desiderato comunicare l’evento-Gesù che è salvezza, come lo stesso nome Gesù significa. I quattro Vangeli interpretano la sua vita, il suo messaggio, la sua storia. Essi cantano a quattro voci che Gesù è il Messia di Israele, il Figlio di Dio morto e risorto, il salvatore del mondo.
Per capire la fondamentale differenza tra informazione /cronaca e interpretazione ci basti pensare alla differenza tra la fotografia e il ritratto. La fotografia può riprodurre tanti particolari di un fatto o di un oggetto; il ritratto, dipinto con passione, esprime, invece, il calore, le emozioni, l’amore che l‘artista comunica, oltre che con il pennello e con i colori, con il suo cuore. E chi ammira la sua opera ne recepisce la freschezza e attualità del messaggio.
sr Filippa Castronovo, fsp
paceegrazia@gmail.com
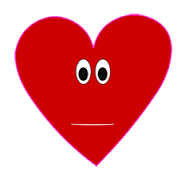 Cuore
Cuore 


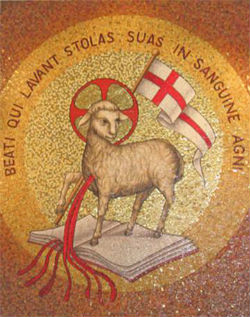 Agnello
Agnello
 LA VIA
LA VIA
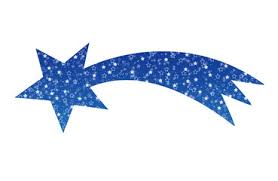 LA STELLA
LA STELLA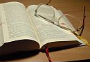
 Quando leggi è Dio che ti parla; quando preghi sei tu che gli rispondi (san Girolamo)
Quando leggi è Dio che ti parla; quando preghi sei tu che gli rispondi (san Girolamo)
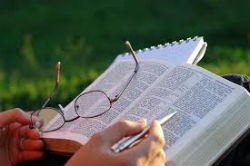 La Costituzione Dogmatica DV al n. 12 offre i criteri indispensabili per ‘leggere’ la Scrittura. Basandosi sul presupposto teologico che Dio ha parlato per mezzo di uomini e alla maniera umana, precisa: «Poiché Dio nella S. Scrittura ha parlato per mezzo di uomini alla maniera umana, l’ interprete della Sacra Scrittura per capire bene ciò che egli ha voluto comunicarci deve ricercare con attenzione ciò che gli agiografi in realtà abbiano inteso significare e a Dio è piaciuto manifestare con le loro parole» (n. 12). Il documento: L’Interpretazione della Bibbia nella Chiesa (PCB-1993) seguendo le indicazioni della DV presenta due passi importanti: l’esegesi e l’interpretazione.
La Costituzione Dogmatica DV al n. 12 offre i criteri indispensabili per ‘leggere’ la Scrittura. Basandosi sul presupposto teologico che Dio ha parlato per mezzo di uomini e alla maniera umana, precisa: «Poiché Dio nella S. Scrittura ha parlato per mezzo di uomini alla maniera umana, l’ interprete della Sacra Scrittura per capire bene ciò che egli ha voluto comunicarci deve ricercare con attenzione ciò che gli agiografi in realtà abbiano inteso significare e a Dio è piaciuto manifestare con le loro parole» (n. 12). Il documento: L’Interpretazione della Bibbia nella Chiesa (PCB-1993) seguendo le indicazioni della DV presenta due passi importanti: l’esegesi e l’interpretazione.
 I libri cristiani che compongono il Nuovo Testamento, tra i quali emergono i quattro Vangeli (cfr. DV 18), si sono formati in modo più veloce rispetto ai libri delle Scritture ebraiche. La loro origine coinvolge molto meno persone e il loro contenuto non si basa su di un insegnamento divino da tramettere, ma sulla persona di Gesù, più importante delle stesse Scritture. Gli stessi testimoni oculari erano ritenuti più autorevoli di qualsiasi documento scritto. Dopo la loro morte nacque la necessità di non perdere la loro memoria fedele e la loro testimonianza su Gesù e cominciò a operarsi il passaggio dalla tradizione orale a quella scritta. I motivi di questa decisione sono tre:
I libri cristiani che compongono il Nuovo Testamento, tra i quali emergono i quattro Vangeli (cfr. DV 18), si sono formati in modo più veloce rispetto ai libri delle Scritture ebraiche. La loro origine coinvolge molto meno persone e il loro contenuto non si basa su di un insegnamento divino da tramettere, ma sulla persona di Gesù, più importante delle stesse Scritture. Gli stessi testimoni oculari erano ritenuti più autorevoli di qualsiasi documento scritto. Dopo la loro morte nacque la necessità di non perdere la loro memoria fedele e la loro testimonianza su Gesù e cominciò a operarsi il passaggio dalla tradizione orale a quella scritta. I motivi di questa decisione sono tre:
 Come all’origine della fede ebraica non vi è il libro sacro, ma l’incontro con la Parola così all’origine della fede cristiana non vi sono i libri sacri ma la persona di Gesù, che con la sua predicazione, le sue opere, la sua morte e risurrezione porta a compimento la rivelazione di Dio. A differenza dei profeti che parlano a nome di Dio: «Così dice il Signore», Gesù afferma di essere in persona la Parola: «In verità (Amen), io vi dico». Egli con autorevolezza riconosce la validità perenne delle Scritture ebraiche, ma le interpreta in maniera nuova, imprimendo loro un orientamento nuovo (Mt 5,17). La sua persona e la sua parola valgono molto di più del tempio, della legge, dei profeti (Mt 5,21-48; 12,6; 24,35). Gesù è la rivelazione definitiva di Dio (Eb 1,1-2) che si manifesta nella parola di Dio diventata carne, cioè, persona umana, storia (Gv 1,14). La prima comunità cristiana lo riconosce come il «Signore» (Kyrios in greco, il termine che nella traduzione greca della Bibbia era usato per indicare il nome ebraico impronunziabile di JHWH). Gesù Kyrios è l’unico nome che salva (At 4,12) e la sua parola è sacra come quella di JHWH.
Come all’origine della fede ebraica non vi è il libro sacro, ma l’incontro con la Parola così all’origine della fede cristiana non vi sono i libri sacri ma la persona di Gesù, che con la sua predicazione, le sue opere, la sua morte e risurrezione porta a compimento la rivelazione di Dio. A differenza dei profeti che parlano a nome di Dio: «Così dice il Signore», Gesù afferma di essere in persona la Parola: «In verità (Amen), io vi dico». Egli con autorevolezza riconosce la validità perenne delle Scritture ebraiche, ma le interpreta in maniera nuova, imprimendo loro un orientamento nuovo (Mt 5,17). La sua persona e la sua parola valgono molto di più del tempio, della legge, dei profeti (Mt 5,21-48; 12,6; 24,35). Gesù è la rivelazione definitiva di Dio (Eb 1,1-2) che si manifesta nella parola di Dio diventata carne, cioè, persona umana, storia (Gv 1,14). La prima comunità cristiana lo riconosce come il «Signore» (Kyrios in greco, il termine che nella traduzione greca della Bibbia era usato per indicare il nome ebraico impronunziabile di JHWH). Gesù Kyrios è l’unico nome che salva (At 4,12) e la sua parola è sacra come quella di JHWH.
 Il Pentateuco è il libro ‘vertice’ della Bibbia ebraica. Contiene la torà che i libri profetici commentano e gli altri scritti meditano. Numerosi esempi di prima parte della Bibbia aiutano a capire il lungo cammino della formazione della Bibbia, nel suo sviluppo storico e letterario.
Il Pentateuco è il libro ‘vertice’ della Bibbia ebraica. Contiene la torà che i libri profetici commentano e gli altri scritti meditano. Numerosi esempi di prima parte della Bibbia aiutano a capire il lungo cammino della formazione della Bibbia, nel suo sviluppo storico e letterario.
 La Bibbia, come sappiamo, non è stata scritta da uno scrittore geniale che, dentro le pareti della sua stanza, redasse il ‘libro sacro ’ come una storia continua. La Bibbia è nata nel grembo di una comunità viva, composta da persone concrete, desiderose di vivere la fede in Dio nonostante la loro fragilità. Questa comunità credente documenta la propria storia di fede, realizzando una specie di ‘album’ di famiglia, che raccoglie tutti gli aspetti della vita: documenti, storie, poesie, feste, leggi… Mano a mano che si aggiorna le storie in esso narrate aumentano e i fatti antichi riacquistano nuovo spessore. In questo speciale ‘album’ la comunità credente, mentre ricorda gli eventi importanti che l’hanno segnata, ri – esprime la sua fede nelle nuove situazioni, crescendo, simultaneamente, nella fedeltà all’alleanza.
La Bibbia, come sappiamo, non è stata scritta da uno scrittore geniale che, dentro le pareti della sua stanza, redasse il ‘libro sacro ’ come una storia continua. La Bibbia è nata nel grembo di una comunità viva, composta da persone concrete, desiderose di vivere la fede in Dio nonostante la loro fragilità. Questa comunità credente documenta la propria storia di fede, realizzando una specie di ‘album’ di famiglia, che raccoglie tutti gli aspetti della vita: documenti, storie, poesie, feste, leggi… Mano a mano che si aggiorna le storie in esso narrate aumentano e i fatti antichi riacquistano nuovo spessore. In questo speciale ‘album’ la comunità credente, mentre ricorda gli eventi importanti che l’hanno segnata, ri – esprime la sua fede nelle nuove situazioni, crescendo, simultaneamente, nella fedeltà all’alleanza.