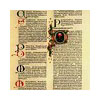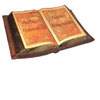I numerosi libri che formano la Bibbia e costituiscono il canone, cioè la collezione dei libri dell’Antico e del Nuovo Testamento, diversi per genere, stile, data, trasmettano l’unica parola di Dio, detta e scritta con le parole degli uomini. Questi libri hanno avuto un lungo e originale processo di composizione che testimonia il crescere della Parola nella storia e nella vicende umane. I libri biblici o parti di essi sono stati, in molti casi, rielaborati e reinterpretati nelle nuove situazioni storiche. I testi più tardivi non vengono dal nulla, ma si riferiscono a quelli anteriori o con citazioni esplicite o approfondendone il significato, altre volte, infine, affermando il compimento di quanto annunciato. Questo dato mostra che la Bibbia interpreta se stessa. La necessità dell’ interpretazione non è, dunque, un’invenzione moderna, come, talvolta, ingenuamente si crede. La Bibbia attesta l’esigenza di una corretta interpretazione della Parola scritta mostrando, che a volte, presenta difficoltà di comprensione. Acconto a brani di comprensione immediata ve ne sono altri più oscuri. Il profeta Daniele (Dn 9, 2), ad esempio, s’interroga su determinati oracoli di Geremia. Gli Atti degli Apostoli raccontano l’incontro del diacono Filippo con l’ etiope che non capiva un passo del libro di Isaia (Is 53 7-8) mostrando di aver bisogno di un interprete: «Capisci quello che stai leggendo?» Egli rispose: «E come potrei capire, se nessuno mi guida?» (At 8, 30-35). Nella seconda lettera di Pietro si legge che «nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione» (2Pt 1, 20) come pure che le lettere dell’ apostolo Paolo contengono «alcune cose difficili da comprendere e gli ignoranti e gli instabili le travisano al pari delle altre Scritture, per loro propria rovina» (2Pt 3, 16).
Perché la parola di Dio contenuta nella Bibbia agisca come Parola che ‘taglia’ ‘edifica’ ed ‘opera’ (Eb 4,12) è necessario scoprire come la Bibbia interpreta se stessa, proponendosi come fondamentale ‘scuola’ di ermeneutica e di ‘lectio divina’.
Gli esempi al riguardo sono numerosi. Il dono della terra, contenuto fondamentali della promessa fatta da Dio ad Abramo (Gn 15,7.18) nello svolgimento della rivelazione, acquista spessore e dimensioni nuove. Abramo, di fatto, non ha mai posseduta la terra verso cui ha orientato tutta la sua esistenza, ma ha creduto fortemente in base alla promessa di Dio. Nello sviluppo della storia sacra, l’entrata nella terra, nei tempi successivi, dopo l’evento dell’Esodo, al tempo della monarchia, quando si costruisce il Tempio è compresa come entrata nel santuario:
Tu lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua eredità,
luogo che per tua dimora,
Signore, hai preparato,
santuario che le tue mani,
Signore, hanno fondato (Es 15,17).
Come è facile capire, questo capitolo si riferisce all’evento eccezionale dell’Esodo e su di esso si fonda, ma nel corso della storia ha avuto sviluppi ulteriori. Il contesto storico di questo versetto è l’epoca monarchica quando a Gerusalemme si costruì il Tempio. L’Esodo divenne la luce interpretativa per capire che anche nel presente Dio continua la sua azione di salvezza. L’entrata nella terra è, pure, compresa come l’entrare in comunione con Dio (Es 19,4); partecipazione al suo riposo (Sal 132,7-8). Nel NT l’entrata nella terra diviene ingresso nel santuario celeste e nella eredità eterna (Eb 6,12.18-20. 9,15). Il dato geografico viene ad acquistare una profondità senza paragoni e rinvia alla scopo della rivelazione che è la comunione con Dio che si realizza nell’Alleanza.
L’importante oracolo del profeta Natan, che promette a Davide una «casa stabile per sempre» cioè una dinastia (2Sam 7, 12-16) viene approfondito nei testi successivi (2Sam 23, 5; 1Re 2, 4; 3, 6; 1Cr 17, 11-14) fino a comprendere che il regno promesso è universale (Sal 2, 8; Dn 2, 25.44; 7, 14; cfr. Mt 28, 18).
Un altro esempio riguarda la giustizia di Dio: nei testi più antichi si riteneva che Dio premiasse i buoni e punisse i malvagi (Sal 1, 1-6; 112, 1-10). Questa comprensione, di fatto, non coincide con l’esperienza umana che vede patire il giusto: come spiegare allora che il giusto soffre e il peccatore sembra essere felice? Per questo, alcuni Salmi e il libro Giobbe, scritte in periodi successivi (Sal 44; Gb 10, 1-7; 13, 3-28; 23-24)contestano questa concezione. Interrogando Dio si aprono al mistero della sofferenza e comprendono che non è affatto vero che la sofferenza è punizione per i peccati. (Sal 37; Gb 38-42; Is 53; Sap 3-5).
Negli scritti del Nuovo Testamento questa lettura, detta intertestuale, assume una nuova luce e un orizzonte immenso. Gesù, maestro di vera interpretazione, supera la visione legalista degli «degli scribi e dei farisei» del suo tempo (Mt 5, 20). Leggendo la Bibbia con la Bibbia restituisce alla persona umana il suo valore prioritario, secondo il progetto di Dio (Mc 2, 27-28; Mc 7, 1-23) e a Dio il suo volto misericordioso di Padre che sembrava essere stato dimenticato (Mc 2, 15-17 ). Gesù interpreta le Scritture mosso unicamente dal desiderio profondo di compiere la volontà di Dio espressa in esse (cfr. Mt 5, 17; 9, 13; Mc 7, 8-13 ; 10, 5-9 ). L’Apocalisse, ultimo libro della Bibbia, presenta la certezza della vittoria di Cristo risorto nella storia e il messaggio di speranza che ne consegue, con citazioni esplicite, allusioni e immagini delle Scritture ebraiche, che rilegge alla luce della pasqua di Gesù. Tutti gli autori del Nuovo Testamento proclamano che la parola di Dio rivelata nella storia in molti modi e tempi trova il suo compimento nella vita, nell’ insegnamento e soprattutto nella morte e risurrezione di Gesù, fonte di perdono e di vita eterna (cfr. 1Cor 15, 3-5).
Il canone biblico, elenco normativo di libri ispirati
Il termine canone deriva dal greco ma anche dalle lingue semitiche ebraico, accadico e ugaritico. Il significato principale è canna o calamo. Il canone sarebbe una canna di legno usata come strumento di misura.
Da questo significato concreto si passa a quello filosofico ed etico venendo a indicare la norma o la regola di comportamento.
Il termine canone applicato alla Bibbia indica l’elenco dei libri sacri che contengono la parola di Dio, luce al nostro cammino. La determinazione di questo elenco normativo per la fede (canone) non è stata lineare. Il canone della Bibbia ebraica risale al periodo compreso fra le due rivolte giudaiche, tra il 70 e il 135 d.C., ad opera di scribi e farisei. La definizione del canone del Nuovo Testamento, cioè, i 27 libri che lo compongono, ha avuto un percorso lungo e accidentato che va dal II al IV sec.d.C.
L’apostolo Poalo nella lettera ai galati usa il termine canone per indicare il comportamento cristiano coerente al vangelo: «E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l’Israele di Dio» (Gal 6,16).
sr Filippa Castronovo, fsp
paceegrazia@gmail.com