L’evangelizzazione e la rete.
Opportunità e illusioni.
 La rete è un ambiente e una esperienza
La rete è un ambiente e una esperienza
- La Rete non esiste, Internet non esiste. Noi siamo colpiti dalla tecnologia, ma finché resteremo colpiti dalla tecnica, dal «macchinoso», non ne capiremo il significato antropologico.
- La Rete è una rivoluzione antica… In particolare la Rete è una rivoluzione che potremmo definire «antica», cioè con salde radici nel passato perché dà forma nuova a desideri e valori antichi quanto l’essere umano.
- Quando si guarda a internet occorre non solo vedere le prospettive di futuro che offre, ma anche i desideri e le attese che l’uomo ha sempre avuto e alle quali prova a rispondere, e cioè: relazione e conoscenza.
Ha scritto Papa Francesco nel suo messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 2014: <<La rete digitale può essere un luogo ricco di umanità, non una rete di fili ma di persone umane>>.
- La vita stessa è una rete che si esprime fisicamente e anche digitalmente…
Internet è una realtà che ormai fa parte della vita quotidiana.
Internet non è una opzione: è un dato di fatto. L’evangelizzazione non può non considerare questa realtà. Perché? Per rispondere a questa domanda è necessario rispondere a un’altra domanda:
Che cos’è internet? Non è un insieme di cavi, fili, modem e computer. Sarebbe errato identificare la “realtà” e l’esperienza di internet alla infrastruttura tecnologica che la rende possibile. Sarebbe come dire, per fare un esempio, che il “focolare domestico” (home) si possa ridurre all’edificio abitativo (house) di una famiglia.
Internet è innanzitutto una esperienza. Finché si ragionerà in termini strumentali non si capirà nulla della Rete e del suo significato. La Rete “è” una esperienza, cioè l’esperienza che quei cavi rendono possibile così come le pareti domestiche rendono possibile l’esperienza del «sentirsi a casa». Internet dunque è uno spazio di esperienza che sempre di più sta diventando parte integrante, in maniera fluida, della vita quotidiana: un nuovo contesto esistenziale.
“L’ambiente digitale non è un mondo parallelo o puramente virtuale, ma è parte della realtà quotidiana di molte persone, specialmente dei più giovani” (Benedetto XVI).
Quindi:
– Lo spazio digitale non è inautentico, alienato, falso o apparente, ma è un’estensione del nostro spazio vitale quotidiano, che richiede «responsabilità e dedizione alla verità». Crolla la distinzione tra reale e virtuale! Vive quella di fisico e digitale…
Siamo chiamati, dunque, a vivere bene sapendo che la Rete è parte del nostro ambiente vitale, e che in essa ormai si sviluppa una parte della nostra capacità di fare esperienza.
Quindi la mediazione tecnologica non è affatto pura alienazione. Del resto la nostra relazione è sempre mediata.
Non basta il contatto fisico per rendere il nostro rapporto AUTENTICO. Viviamo spesso rapporti fisici e falsi. Se abbiamo bisogno di spegnere il cellulare per riscoprire i rapporti non significa che siamo equilibrati ma che non sappiamo vivere le sfide del nostro tempo.
Benedetto XVI: “Lo sviluppo delle reti sociali richiede impegno: le persone sono coinvolte nel costruire relazioni e trovare amicizia, nel cercare risposte alle loro domande, nel divertirsi, ma anche nell’essere stimolati intellettualmente e nel condividere competenze e conoscenze. I network diventano così, sempre di più, parte del tessuto stesso della società in quanto uniscono le persone sulla base di questi bisogni fondamentali. Le reti sociali sono dunque alimentate da aspirazioni radicate nel cuore dell’uomo”.
Quindi la rete è un tessuto connettivo delle esperienze umane.
Non uno strumento. Le tecnologie della comunicazione stanno dunque creando un ambiente digitale nel quale l’uomo impara a informarsi, a conoscere il mondo, a stringere e mantenere in vita le relazioni, contribuendo a definire anche un modo di abitare il mondo e di organizzarlo, guidando e ispirando i comportamenti individuali, familiari, sociali.
La Gaudium et spes aveva già parlato di un preciso impatto delle tecnologie sul modus cogitandi dell’uomo (n. 5).
Giovanni Paolo II nella lettera apostolica Il rapido sviluppo, individuava 5 territori di impatto dei processi mediatici:
- «la formazione della personalità e della coscienza,
- l’interpretazione e la strutturazione dei legami affettivi,
- l’articolazione delle fasi educative e formative,
- l’elaborazione e la diffusione di fenomeni culturali,
- lo sviluppo della vita sociale, politica ed economica»
(Il rapido sviluppo, n. 2).
Il significato spirituale della tecnologia digitale
NON E’ POSSIBILE PARLARE DI PASTORALE E COMUNICAZIONE SENZA COMPRENDERE LA VALENZA SPIRITUALE DELLA TECNOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE
L’uomo ha sempre cercato di capire la realtà attraverso le tecnologie. Pensiamo a come la fotografia e il cinema hanno mutato il modo di rappresentare le cose e gli eventi; l’aereo ci ha fatto comprendere il mondo in maniera diversa del carro con le ruote; la stampa ci ha fatto comprendere la cultura in maniera diversa. E così via. La «tecnologia», dunque, non è un insieme di oggetti moderni e all’avanguardia. Essa è parte dell’agire con il quale l’uomo esercita la propria capacità di conoscenza, di libertà e di responsabilità.
Le «macchine» sempre di più stanno assumendo un valore che tocca le dimensioni dell’uomo più elevate: pensare, esprimersi, comunicare, capire il mondo. Il nostro compito come cristiani è di vedere con occhi nuovi la tecnologia e i suoi prodotti interrogandoci sul loro significato e valore nel progetto di Dio sul mondo.
Ecco un punto chiave: il legame profondo e radicale tra la tecnologia e la spiritualità. La tecnologia, scrive Benedetto XVI nella Caritas in Veritate, «è un fatto profondamente umano, legato alla libertà dell’uomo. Nella tecnica si esprime e si conferma la signoria dello spirito sulla materia» (n. 69). La tecnologia, dunque, esprime la capacità dell’uomo di organizzare la materia in un progetto di valore spirituale.
Il cristiano, quindi, è chiamato a comprendere la natura profonda, la vocazione stessa della tecnologie digitali in relazione allo vita dello spirito.
Ovviamente la tecnica è ambigua perché la libertà dell’uomo può essere spesa anche per il male, ma proprio questa possibilità mette in luce la sua natura legata alla vita spirituale.
Un momento cruciale di questa comprensione spirituale delle nuove tecnologie fu la promulgazione del Decreto del Concilio Vaticano II Inter mirifica, il 4 dicembre 1963. che esordisce:
«Tra le meravigliose invenzioni tecniche che, soprattutto ai nostri giorni, l’ingegno umano, con l’aiuto di Dio, ha tratto dal creato, la Madre Chiesa accoglie e segue con speciale cura quelle che più direttamente riguardano lo spirito dell’uomo e che hanno aperto nuove vie per comunicare, con massima facilità, notizie, idee e insegnamenti d’ogni genere». Meno di un anno dopo della promulgazione della Inter Mirifica Paolo VI in un suo discorso aveva usato parole di una bellezza sconcertante, a mio avviso. Vi cito queste parole sintetizzandole un po’: «La scienza e la tecnica ci fanno intravedere nuovi misteri: il cervello meccanico viene in aiuto del cervello spirituale».
E proseguiva il Pontefice: «Lo sforzo di infondere in strumenti meccanici il riflesso di funzioni spirituali è innalzato ad un servizio che tocca il sacro». Quindi lo sforzo dell’uomo consiste nell’infondere il «riflesso di funzioni spirituali» agli «strumenti meccanici». E’ questa la definizione potremmo dire «teologica» della tecnologia, la sua «vocazione». E’ grazie alla tecnologia che la materia può offrire «allo spirito stesso un sublime ossequio».
Paolo VI sente dunque salire dall’homo tecnologicus il gemito di aspirazione ad un grado superiore di spiritualità. L’uomo tecnologico è dunque lo stesso uomo spirituale.
Lo sviluppo tecnologico, se ben inteso, riesce ad esprimere una forma di anelito alla «trascendenza» rispetto alla condizione umana così come è vissuta attualmente (Cfr S. GEORGE, Religion and technology in the 21st Century. Faith in the e-World, Hershey (PA), Information Science Publishing, 2006, 87-90).
*****
Nel 2007 il Documento di Aparecida aveva accolto questa sfida quando al n. 35 si legge che i “nuovi linguaggi della tecnologia” sono in grado di rivelare e occultare “il senso della vita umana”
La tecnologia diventa uno dei modi ordinari che l’uomo ha a disposizione per esprimere la sua naturale spiritualità. Anzi, se usate saggiamente, dunque, le nuove tecnologie, ha scritto Benedetto XVI nel suo 45 Messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, «possono contribuire a soddisfare il desiderio di senso, di verità e di unità che rimane l’aspirazione più profonda dell’essere umano».
Questo valore umano è quanto mai parte della nostra esperienza perché ormai noi, in un certo modo «siamo» in Rete, parte della nostra vita è là. Ci rendiamo conto ormai che noi esistiamo anche in Rete. Una parte della nostra vita è digitale. Dunque anche una parte della nostra vita di fede è digitale, vive nell’ambiente digitale.
Dunque anche una parte della nostra vita di fede è digitale, vive nell’ambiente digitale.
Un mio studente africano della Pontificia Università Gregoriana una volta mi disse: «Io amo il mio computer perché dentro il mio computer ci sono tutti i miei amici».
Finché si dirà che bisogna uscire dalla relazioni in Rete per vivere relazioni reali si confermerà la schizofrenia di una generazione che vive l’ambiente digitale come un ambiente puramente ludico in cui si mette in gioco un secondo sé, un’identità doppia che vive di banalità effimere, come in una bolla priva di realismo fisico, di contatto reale con il mondo e con gli altri.
La fede nell’ambiente digitale
Ecco, dunque: proprio su questo valore spirituale dell’ambiente digitale si fonda la possibilità dell’annuncio della fede in questo ambiente.
In un tempo in cui la tecnologia tende a diventare il tessuto connettivo di molte esperienze umane quali le relazioni e la conoscenza, è necessario chiedersi: può la Rete essere una dimensione nella quale vivere il Vangelo? E ancora: se la tecnologia e, in particolare, la rivoluzione digitale ha un impatto sul modo di pensare la realtà, ciò non finirà per riguardare anche, in qualche modo, la fede? Non avrà un impatto sul modo di pensare la fede? Come?
Vorrei qui esporre alcune sfide importanti:
- Dalla pastorale della risposta alla pastorale della domanda
Viviamo bombardati dai messaggi, subiamo una sovrainformazione, la cosiddetta information overload.
Il problema oggi non è trovare le risposte ma riconoscere quelle giuste significativo sulla base delle tante risposte che ricevo.
Al tempo dei motori di ricerca, le risposte sono a portata di mano, sono dovunque. Per questo è importante oggi non tanto dare risposte. Tutti danno risposte! “The teacher doesn’t need to give any answers because answers are everywhere” (Sugata Mitra, professore di Educational Technology alla Newcastle University). Oggi è importante riconoscere le domande importanti, quelle fondamentali. E così fare in modo che nella nostra vita resti aperta, che Dio ci possa ancora parlare.
L’annuncio cristiano oggi corre il rischio di presentare un messaggio accanto agli altri, una risposta tra le tante.
Più che presentare il Vangelo come il libro che contiene tutte le risposte, bisognerebbe imparare a presentarlo come il libro che contiene tutte le domande giuste.
La grande parola da riscoprire, allora, è una vecchia conoscenza del vocabolario cristiano: il discernimento spirituale che significa riconoscere tra le tante risposte che oggi riceviamo quali sono le domande importanti, quelle vere e fondamentali. E’ un lavoro complesso, che richiede una grande sensibilità spirituale.
“Non bisogna mai rispondere a domande che nessuno si pone” (Evangelii Gaudium, 155).
La Chiesa sa coinvolgersi con le domande e i dubbi degli uomini? Sa risvegliare i quesiti insopprimibili del cuore, sul senso dell’esistenza? Occorre sapersi inserire nel dialogo con gli uomini e le donne di oggi, per comprenderne le attese, i dubbi, le speranze», dunque.
Mi ha colpito il fatto che Papa Francesco, rispondendo a una domanda posta da un giornalista sul volo che da Tel Aviv lo riportava a Roma abbia detto: “
“Non so se mi sono avvicinato un po’ alla sua inquietudine…
- Dalla pastorale centrata sui contenuti alla pastorale centrata sulle persone
Oggi sta cambiando anche la modalità di fruizione dei contenuti.
Stiamo assistendo al crollo delle programmazioni… Fino a qualche tempo fa MTV (Music Television) tra i giovani era considerata una emittente di «culto». Adesso sta subendo una crisi o, se vogliamo, una sua trasformazione da quel che era – cioè emittente di una notevole quantità di video musicali introdotti da VJ – in emittente di reality show e serie televisive indirizzate soprattutto al target adolescenziale e ai giovani adulti.
I giovani, infatti, ormai fruiscono la musica da internet e non ci sono più ragioni perché la fruiscano dalla Tv. La Tv è un rumore di fondo, il brusio del mondo. La si lascia parlare… Raramente oggi trova posto nelle camere dei ragazzi. Oggi, inoltre, il vedere implica la selezione, e la possibilità del commento e dell’interazione. E questa possibilità è data da un social network come YouTube.
La fede sembra partecipare di questa logica. Le programmazioni sono sostituite dalle ricerche personali e dai contenuti accessibili sempre in rete.
Il catechismo era una forma per presentare in maniera ordinata, coerente e scandita i contenuti della fede. In un tempo in cui i palinsesti sono in crisi, questa modalità di presentare la fede è in crisi.
Quali sfide tutto questo pone alla fede e alla sua comunicazione? Come far sì che la Chiesa non diventi un container da tenere accesso come un televisore che «parla» senza comunicare?
La grande sfida qui è quella percepita già nel 2007 dal documento di Aparecida: la frammentazione, l’incapacità di «percepire un significato coerente del mondo che ci circonda» (n. 36) e un certo individualismo (n. 44)
Ma sempre nel documento di Aparecida al n. 100 leggiamo: “Nell’evangelizzazione, nella catechesi e, in generale, nella pastorale, continuano a essere utilizzati linguaggi poco significativi per la cultura attuale e, in particolare, per la cultura dei giovani. Molte volte, i linguaggi usati sembrano non tener conto dei cambiamenti dei codici esistenzialmente rilevanti nelle nostre società”.
Una direzione di risposta a questa domanda la troviamo in un passaggio di mons. Claudio Maria Celli, nel suo intervento al Sinodo dei vescovi sulla Nuova Evangelizzazione: «la gerarchia ecclesiastica, come anche quella politica e sociale, deve trovare nuove forme per elaborare la propria comunicazione, affinché il suo contributo a questo forum riceva un’attenzione adeguata. Stiamo imparando a superare il modello del pulpito e dell’assemblea che ascolta per il rispetto della nostra posizione. Siamo obbligati a esprimere noi stessi in modo da coinvolgere e convincere gli altri che a loro volta condividono le nostre idee con i loro amici, “followers” e partners di dialogo».
La vita della Chiesa è chiamata ad assumere una forma sempre più comunicativa e partecipativa.
******
- Dalla pastorale della trasmissione alla pastorale della testimonianza
Infatti la vera novità dell’ambiente digitale è la sua natura di social network, cioè il fatto che permette di far emergere non solo le relazioni tra me e te, ma le mie relazioni e le tue relazioni. Cioè in rete emergono non solo le persone e i contenuti, ma emergono le relazioni.
È cambiato il significato stesso della parola COMUNICAZIONE
—– Comunicare dunque non significa più trasmettere ma condividere —–
La società e la cultura non sono più pensabili e comprensibili solamente attraverso i contenuti. Non ci sono innanzitutto le cose, ma le «persone». Ci sono soprattutto le relazioni: lo scambio dei contenuti che avviene all’interno delle relazioni tra persone. La base relazionale della conoscenza in Rete è radicale.
Si capisce bene dunque quanto sia importante la testimonianza. È questo un aspetto determinante. Oggi l’uomo della Rete si fida delle opinioni in forma di testimonianza. Pensiamo alle librerie digitali o agli store musicali. Ma gli esempi si possono moltiplicare: si tratta sempre e comunque di quegli user generated content che hanno fatto la «fortuna» e il significato dei social network.
La logica delle reti sociali ci fa comprendere meglio di prima che il contenuto condiviso è sempre strettamente legato alla persona che lo offre. Non c’è, infatti, in queste reti nessuna informazione «neutra»: l’uomo è sempre coinvolto direttamente in ciò che comunica.
In questo senso il cristiano che vive immerso nelle reti sociali è chiamato a un’autenticità di vita molto impegnativa: essa tocca direttamente il valore della sua capacità di comunicazione. Infatti, ha scritto Benedetto XVI nel suo Messaggio per la Giornata delle Comunicazioni del 2011, «quando le persone si scambiano informazioni, stanno già condividendo se stesse, la loro visione del mondo, le loro speranze, i loro ideali».
Il documento di Aparecida al n. 145 affermava chiaramente: “La missione non si limita a un programma e a un progetto; no, essa significa condividere l’esperienza dell’avvenimento dell’incontro con Cristo, testimoniarlo e annunciarlo da persona a persona, da comunità a comunità, e dalla Chiesa fino ai confini della terra (cf. At 1,8)”
Ha scritto tempo fa Papa Francesco: «Solo chi comunica facendosi testimone diretto della verità può rappresentare un punto di riferimento. Il suo coinvolgimento personale è la radice stessa della sua affidabilità come comunicatore».
Dunque un annuncio del Vangelo che non passi per l’autenticità di una vita quotidiana personale condivisa resterebbe, oggi più che mai, un messaggio espresso in un codice comprensibile forse con la mente, ma non col cuore.
La fede quindi non solo si «trasmette», ma soprattutto può essere suscitata nell’incontro personale, nelle relazioni autentiche.
Sempre il documento di Aparecida al n. 489, pur essendo stato scritto prima della nascita dei social networks, già affermava: «i siti Internet possono rinforzare e stimolare un interscambio di esperienze e informazioni che intensificano l’esperienza religiosa, fornendo accompagnamento e orientamento”.
Ha scritto Papa Francesco nel Messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni 2014: «La testimonianza cristiana non si fa con il bombardamento di messaggi religiosi, ma con la volontà di donare se stessi agli altri “attraverso la disponibilità a coinvolgersi pazientemente e con rispetto nelle loro domande e nei loro dubbi, nel cammino di ricerca della verità e del senso dell’esistenza umana” (Benedetto XVI, Messaggio per la XLVII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, 2013).
«Pensiamo all’episodio dei discepoli di Emmaus. Occorre sapersi inserire nel dialogo con gli uomini e le donne di oggi, per comprenderne le attese, i dubbi, le speranze, e offrire loro il Vangelo, cioè Gesù Cristo«.
«Dialogare significa essere convinti che l’altro abbia qualcosa di buono da dire, fare spazio al suo punto di vista, alle sue proposte. Dialogare non significa rinunciare alle proprie idee e tradizioni, ma alla pretesa che siano uniche ed assolute«.
—– Dunque EVANGELIZZARE IN RETE è innanzitutto ASCOLTARE
- Dalla pastorale della propaganda alla pastorale della prossimità
Evangelizzare, dunque, non significa affatto fare «propaganda» del vangelo. La Chiesa in Rete è chiamata dunque non a una «emittenza» di contenuti religiosi, ma a una «condivisione» del Vangelo.
E per Papa Francesco questa condivisione è larga. Scrive chiaramente: «internet può offrire maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti, e questa è una cosa buona, è un dono di Dio». Il Papa sembra leggere nella rete il segno di un dono e di una vocazione dell’umanità ad essere unita, connessa. Rivive, grazie alle nuove tecnologie della comunicazione, «la sfida di scoprire e trasmettere la “mistica” di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po’ caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio» (Evangelii Gaudium, 87).
Nel suo Messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni 2014, papa Francesco ha definito il potere dei «media» come «prossimità.
Come si manifesta l’essere prossimo nel nuovo ambiente creato dalle tecnologie digitali? Papa Francesco, parlando ai comunicatori nel 2002, aveva scelto la parabola del buon samaritano, come immagine di riferimento del comunicatore.
Qui c’è il cuore del discorso. Ed è la parte più complessa, forse.
Vedete, noi a volte pensiamo il mondo come un insieme di oggetti, di cose, di informazioni. Non è così: un oggetto esiste come nodo di un insieme di interazioni, di relazioni. Così ognuno di noi.
Vedete, la tessera di un mosaico può essere d’oro, ma il vero valore del suo significato si sprigiona solo quando la tessera trova il suo posto rispetto alle altre.
La rete oggi fa sì che i CONTENUTI non vivono al di fuori delle RELAZIONI. Oggi è strategica la capacità di connettere tra loro in modo dinamico contenuti e persone.
TUTTO È IPERTESTO
Chi evangelizza oggi deve essere un “hub” che mette in relazioni i contenuti con le persone.
Chi evangelizza non è chiamato a “predicare” nel senso tradizionale, ma a sviluppare relazioni e a connettere il vangelo con le persone.
Oggi un contenuto che non genera relazione, cioè incontro, passione, dialogo, è un contenuto insignificante, cioè privo di valore.
Così se il Vangelo non genera relazione, cioè incontro, passione, dialogo, è un contenuto insignificante, cioè privo di valore.
Allora oggi non è importante «sapere comunicare il Vangelo», avere strategie di comunicazione del Vangelo, ma avere una vita che genera relazioni e che connetta il Vangelo che si vive con la vita della gente. Guardiamo i nostri profili Facebook…
Vedete…. Il Papa non «comunica», ma «è presente».
Quella del Papa è una semplice «presenza», una presenza nuda. Papa Francesco non compie sforzi comunicativi, se non quelli più ovvi e naturali.
Intende essere sempre se stesso, non il lettore di un testo scritto o un emittente di informazioni: comunica per connaturalità, per semplice presenza. Quello che sto dicendo significa una cosa semplice:
Il Papa è un testimone.
Ricordiamo bene quando Papa Francesco si è affacciato per la prima volta dalla loggia delle benedizioni, subito dopo la sua elezione: non solo ha benedetto chi era in piazza e chi lo seguiva dalla tv e da internet, ma si è prima chinato, chiedendo a tutti di pregare per lui.
Che cosa ha fatto dal punto di vista comunicativo? Ha reso attivo chi era immaginato come recettore passivo, seppure di una benedizione. La conseguenza è stata che tutta la piazza ha reagito, partecipando in prima persona alla “costruzione” dell’evento.
Lo stesso si dica per un altro momento da cui molti sono stati colpiti, e cioè quando Papa Francesco ha accolto un gruppo di scout, ragazze e ragazzi, arrivati a San Pietro da Piacenza. Uno di loro ha tirato fuori dalla tasca un telefonino e ha scattato un selfie, cioè un autoritratto con l’obiettivo frontale. Ha fotografato così se stesso, gli amici e il Papa in mezzo a loro, e lo ha caricato su Instagram, un social network di fotografie.
La dinamica è la stessa: il Papa più che «comunicare», Papa Francesco crea «eventi comunicativi», ai quali si ci sente richiamati a partecipare attivamente. La relazione per lui è contenuto della comunicazione.
- 5. Dalla pastorale delle idee alla pastorale della narrazione
– Le foto «taggate», «geolocalizzate», collocate nel tempo esatto in cui sono state condivise sono l’album fotografico live della nostra vita.
– I nostri tweets o gli updates dello stato su Facebook e i post dei nostri blog conservano i nostri pensieri, ma anche i nostri stati emotivi.
– Le librerie on line e gli altri negozi tengono traccia dei nostri gusti, delle nostre scelte, dei nostri acquisti e a volte anche dei commenti.
– I video su YouTube costruiscono per frammenti il film della nostra vita fatto dai nostri video e da quelli che ci piacciono.
- Infatti lo streaming della nostra vita non è fatto solo di ciò che immettiamo in Rete ma anche di ciò che «gradiamo», da ciò che ci piace, e che segnaliamo agli altri anche grazie al pulsante like ai nostri followers e ai nostri friends.
L’esperienza condivisa sui social networks è l’opposto di ciò che accadeva ai tempi di Robert Musil che scriveva: «la probabilità di apprendere dal giornale una vicenda straordinaria è molto maggiore di quella di viverla personalmente».
Oggi invece i social networks offrono l’opportunità di rendere più significativa l’esperienza vissuta soggettivamente proprio grazie alla pubblicazione e alla condivisione in una rete di relazioni. Le notizie dei giornali sono invece irrelate a me e dunque, in un certo senso, finiscono per essere percepite come meno «straordinarie» o comunque meno interessanti.
La rete è una opportunità perché narrare in ogni caso è restituire i soggetti della conoscenza alla densità simbolica ed esperienziale del mondo. E oggi è molto alimentato il bisogno di narrazione all’interno di legami e relazioni. La narrazione di rete può essere, sì, individualistica e autoreferenziale, ma può essere anche polifonica e aperta.
Interessante a questo proposito la possibilità di aggregare materiali condivisi su differenti social networks su una piattaforma come Storify che permette l’interconnessione con Twitter, Facebook, Flickr, Youtube,… e le apre alla condivisione. Alla base è la consapevolezza che ciascuno di noi è un living link. L’interattività è la cifra radicale di questo lifestreaming.
- Dalla pastorale della voce e del testo a quella (anche) dell’immagine (il Papa in Instagram)
Il 19 marzo 2016 Papa Francesco è «sbarcato» su Instagram co l’account @franciscus. Questo Papa viene raccontato al meglio in tutta la sua potenza proprio dalle immagini scattate dai fedeli. Le immagini che lo ritraggono al meglio addirittura a volte non sono quelle «pulite» e nitide, ma quelle «sporche», persino sfocate e mosse, dei fedeli. Il Papa del popolo viene raccontato dal popolo che coglie non solo i gesti ma anche il contesto dei gesti dal di dentro. E in questo modo, appunto, il Papa è già in Instagram dall’inizio al di là di ogni ufficialità.
Perché le foto? Perché la foto parla. Non intendo dire solamente che ha valore simbolico, ma innanzitutto è oggetto di condivisione. Condividere una propria foto è un gesto che permette di condividere un pezzo di vita vissuta.
E oggi non c’è più bisogno di una macchina fotografica. Tutti gli smartphone, che siano iPhone, Android o Windows Phone o altro ancora, sono ormai dotati di un obiettivo di una certa qualità. Avere uno smartphone in tasca significa dunque anche avere sempre a portata di mano una macchina fotografica.
Questa evoluzione tecnologica sta dando vita a una vera e propria rivoluzione della esperienza umana della fotografia che consiste nel fatto che oggi si può fotografare in qualunque istante della vita.
La «macchina fotografica» è obsoleta come oggetto, o meglio è riservata a cultori del click. Si vanno moltiplicando, anzi, i professionisti, e specialmente i reporter, che praticano la cosiddetta «phonografia». La caratteristica di questa pratica fotografica consiste nel fatto che lo scatto ne è solamente il primo momento. A questo, infatti fa seguito il secondo momento, cioè la post-produzione, cioè l’elaborazione della foto grazie a numerose applicazioni che ne permettono la modifica anche applicando filtri: è un gesto che permette di elaborare un’immagine per adeguarla alla propria visione. Il terzo momento consiste nella condivisione: ogni scatto elaborato può sempre essere condiviso sui social networks.
Dunque: scatto, elaborazione e condivisione
La logica del social network, sposandosi con quella dello scatto ha così trasformato la fotografia da «memoria» a «esperienza». Si scattano foto per «vedere» meglio ciò che si vede e per condividere l’esperienza che si sta facendo sul momento con gli amici. Le «istantanee» diventano i pezzi di una narrazione «lifestreaming». La condivisione in diretta delle fotografie sviluppa un flusso di immagini che non è pensato per essere archiviato, indicizzato, memorizzato. Le foto si accavallano, si sostituiscono, man mano che vengono postate in successione. Più che creazione di memoria, dunque, si tratta di plasmare l’esperienza e di condividerla.
Come cambierà il modo di dire la fede al tempo delle istantanee simboliche e condivise?
Ma ecco una domanda più ampia e generale sollevata dalla presenza del Papa su Instagram: Come cambierà il modo di dire la fede al tempo delle istantanee simboliche e condivise? Non lo sappiamo, ma certo lo stiamo vivendo: la fede si esprime e si condivide grazie anche alle foto. Per questo Papa Francesco «sbarca» su Instagram. Perché in questo flusso di immagini si può discernere un «desiderium naturale videndi Deum». Ci sono vari esperimenti a questo proposito dai nomi interessanti quali «Framing God in all things» o «Picturing God».
Non solo: #theology è diventato anche un hashtag abbastanza usato su Instagram. Il potenziamento dell’espressione simbolica certamente avrà un impatto anche sulla nostra capacità di dire la fede nella cultura della digitale.
E’ una strada interessante da percorrere anche per gruppi e comunità: quali le immagini per dire la fede? Quali gli hashtag, cioè le parole-chiave, da usare? La Chiesa ha una lunga tradizione di catechesi visiva in tempi in cui l’alfabetizzazione era limitata. E questa tradizione può dire molto all’uomo d’oggi alla ricerca di immagini per esprimere il proprio desiderio di una vita piena, oltre che di trascendenza.
7. Dalla comunità al network e viceversa
Nella sua omelia per la solennità della Pentecoste del 2012 Benedetto XVI ha posto una domanda importante e impegnativa: «E’ vero, abbiamo moltiplicato le possibilità di comunicare, di avere informazioni, di trasmettere notizie, ma possiamo dire che è cresciuta la capacità di capirci o forse, paradossalmente, ci capiamo sempre meno?».
E’ una domanda che ha un significato che potremmo definire radicale: basta moltiplicare le connessioni per sviluppare la comprensione reciproca tra le persone e le relazioni di comunione?
Ecco allora la nostra vocazione al tempo della connessione relazionale: la vocazione a vivere la Rete da luogo di «connessione» a luogo di «comunione». Il rischio di questi tempi è di confondere i due termini: la connessione non produce automaticamente una comunione.
Essere connessi non significa automaticamente essere in relazione. La connessione non basta a fare della Rete un luogo di condivisione pienamente umana.
Ecco dunque un compito specifico del cattolico in Rete: farla maturare da luogo di «connessione» a luogo di «comunione». Il rischio di questi tempi è proprio quello di confondere questi due termini. La connessione di per sé non basta a fare della Rete un luogo di condivisione pienamente umana. Lavorare in vista di tale condivisione è compito specifico del cristiano.
E questo soprattutto oggi dove le singole persone o le singole comunità rischiano di rimanere ancora più di prima dentro BOLLE FILTRATE, dentro muri invalicabili. Cerco di spiegarmi meglio…
Oggi si è tutti connessi grazie ai social networks quali Facebook o Twitter. Come forse sapete sia i social networks sia i motori di ricerca come Google conservano le informazioni delle persone che li frequentano, e questi dati sono utilizzati per dirigere le risposte o gli aggiornamenti circa i contatti personali. È come se Google e Facebook «ci conoscessero» sulla base dei nostri accessi alla rete, dei siti che visitiamo, di cosa ci interessa di più.
Questi dati orientano la risposta alle nostre ricerche. Gli aggiornamneti di Facebook o le risposte alle nostre ricerche non sono mai «oggettive». Sono orientate sul soggetto, e dunque persone diverse ottengono risultati differenti. Il vantaggio è immediato: arrivo subito a ciò che presumibilmente mi interessa di più perché Google mi ‘conosce’ e mi suggerisce cosa possa attirarmi maggiormente.
Ma d’altra parte c’è un grande rischio: quello di rimanere chiusi in una sorta di «bolla» che fa da filtro a ciò che è diverso da me, per cui io non sono più in grado di accorgermi che ci sono persone, articoli, libri, ricerche che non corrispondono alle mie idee o che esprimono un’opinione diversa dalla mia.
Quindi, alla fine, io sarò circondato da un mondo di informazioni e da un mondo di relazioni che mi somigliano, uguali a me. Così rischio di rimanere chiuso alla provocazione intellettuale che proviene dall’alterità e dalla differenza.
Il rischio è evidente: perdere di vista la diversità, aumentare l’intolleranza, chiusura alla novità e all’imprevisto che fuoriesce dai miei schemi relazionali o mentali. L’altra persona diventa per me significativo se mi è in qualche modo simile, altrimenti non esiste. A questo punto oggi più che mai il dialogo tra persone di fede diversa, di stili di vita differenti, l’ecumenismo, il dialogo interreligioso, il confronto all’interno della Chiesa tra gruppi e movimenti assumono un valore fondamentale in un mondo che tende a costruire, anche in rete – cioè il luogo in termini di principio più aperto possibile – isole di autoreferenzialità.
L’altro diventa per me significativo, dunque, soltanto se mi è in qualche modo simile, altrimenti non esiste.
Ecco dunque che il Papa ribadisce: «Costatata la diversità culturale, bisogna far sì che le persone non solo accettino l’esistenza della cultura dell’altro, ma aspirino anche a venire arricchite da essa e ad offrirle ciò che si possiede di bene, di vero e di bello” (Discorso nell’Incontro con il mondo della cultura, Belém, Lisbona, 12 maggio 2010)».
Ma per la comunione che i cattolici sperimentano nella Chiesa non basta una comunicazione bella, buona, sana. Non basta: la comunione non è frutto dei nostri sforzi. La Chiesa non è frutto di un «consenso», cioè un «prodotto» della comunicazione.
Se fosse così, sarebbe a forte rischio la comprensione della Chiesa come «corpo mistico», che sembra diluirsi in una sorta di piattaforma di connessioni. In questo contesto il battesimo rischia di risolversi in una sorta di «procedura di accesso» (login), che permette anche una rapida disconnessione (log off). Il radicamento in una comunità ecclesiale si risolverebbe in una sorta di «installazione» di un programma che si può dunque facilmente anche «disinstallare» (uninstall).
Ciò che da un punto di vista cattolico dunque DEVE rimanere chiaro è che la comunità ecclesiale non è un prodotto della comunicazione, ma ha sempre un principio e un fondamento «esterno».
Le relazioni in Rete dipendono dalla presenza e dall’efficace funzionamento degli strumenti di comunicazione; la comunione ecclesiale invece è radicalmente un «dono» dello Spirito. E’ questo dono che trasforma la connessione in comunione.
Occorre rileggere il racconto della torre di Babele. Noi siamo convinti che la differenza delle lingue sia la punizione di Dio per una umanità che ha progettato di invadere lo spazio di Dio. L’esegesi biblica recente ci sta facendo capire che invece Babele è una «nuova creazione» che denuncia e sventa il progetto di un monolitismo totalitario della civiltà di Babele per cui «Tutta la terra aveva un’unica lingua e uniche parole» (una civiltà ripiegata su se stessa). indirizzando l’uomo verso un progetto di comunione che parta da quella condizione di pluralismo descritta nella tavola dei popoli di Genesi 10, dove la varietà delle lingue e delle culture costituisce una ricchezza e non un ostacolo alla comunicazione e alla comunione dei popoli.
8. Dal pensare in gruppo al pensare in rete
Ma questa conversazione è ormai globale. Internet comporta la connessione e la condivisione di risorse, tempo, contenuti, idee… Si pensa insieme! L’esempio ormai «classico» è quello di Wikipedia. Al di là di ogni altra considerazione, è il frutto della convergenza di tante persone connesse tra loro nel pianeta che pensano e scrivono. Tutti scrivono una stessa voce di enciclopedia, contribuendo a un unico lavoro comune. In Qualche modo è come se si «pensasse» insieme.
Il cablaggio delle reti sta dando vita a una forza emergente e vitale, in grado di raccogliere le persone e di farle pensare insieme al di là del tempo e dello spazio. Oggi si pensa e si conosce il mondo non solo nella maniera tradizionale della lettura o dello scambio in un contesto ristretto di relazioni (insegnamento, gruppi di studio,…), ma realizzando una vasta connessione tra intelligenze che lavorano in rete. Potremmo dire che l’intelligenza è distribuita dovunque ci sia umanità, ed essa oggi può essere facilmente interconnessa. La rete di queste conoscenze dà vita a una forma di «intelligenza connettiva».
I media sociali dunque non solamente aiutano ad esprimere agli altri il proprio pensiero, ma aiutano anche a pensare insieme agli altri, a elaborare riflessioni, idee, visioni della realtà. La comunicazione oggi aiuta il comunicatore a pensare insieme a una comunità. Ma direi di più: può aiutare il comunicatore a pensare insieme alle persone alle quali si rivolge grazie alla possibilità di ricevere continuamente feedback e commenti.
Cosa questo significherà per il dialogo teologico?
Nelle reti sociali gli uomini sono coinvolti – si legge nel Messaggio – «nell’essere stimolati intellettualmente e nel condividere competenze e conoscenze». Internet comporta la connessione e la condivisione di contenuti e idee. Già nel Messaggio del 2011 il Papa notava che il web sta contribuendo allo sviluppo di «nuove e più complesse forme di coscienza intellettuale e spirituale, di consapevolezza condivisa».
I networks sociali dunque non solamente aiutano ad esprimere agli altri il proprio pensiero, ma aiutano anche a pensare insieme agli altri, elaborando riflessioni, idee, visioni della realtà.
- Chi è il mio «prossimo»?
La possibile separazione tra connessione e incontro, tra condivisione e relazione implica il fatto che oggi le relazioni, paradossalmente, possono essere mantenute senza rinunciare alla propria condizione di egoistico isolamento. Sherry Turkle ha riassuto questa condizione nel titolo di un suo libro: Alone together[1], cioè : «insieme ma soli».
Anzi, gli «amici», proprio perché sempre on line, cioè disponibili al contatto o immaginati come presenti a dare un’occhiata ai nostri aggiornamenti sui social network, sono immancabilmente presenti e dunque, proprio per questo, rischiano di svanire in una proiezione del nostro immaginario. La frattura nella prossimità è data dal fatto che la vicinanza è stabilita dalla mediazione tecnologica per cui mi è «vicino», cioè prossimo, chi è «connesso» con me[2].
Qual è il rischio, dunque? Quello di essere «lontano» da un mio amico che abita vicino ma che non è su Facebook e usa poco l’e-mail, e invece di sentire «vicino» una persona che non ho mai incontrato, che è diventata mio «amico» perché è l’amico di un mio amico, e con la quale ho uno scambio frequente in Rete.
Il vero nucleo problematico della questione che stiamo affrontando è il concetto di «presenza» al tempo dei media digitali e dei network sociali che sviluppano una forma di presenza virtuale. Che cosa significa essere presenti gli uni agli altri? Che cosa significa essere presenti a un evento? L’esistenza «virtuale» appare configurarsi con uno statuto ontologico incerto: prescinde dalla presenza fisica, ma offre una forma, a volte anche vivida, di presenza sociale.
Certamente una parte della nostra capacità di vedere e ascoltare è ormai palesemente «dentro» la Rete, per cui la connettività è ormai in fase di definizione come un diritto la cui violazione incide profondamente sulle capacità relazionali e sociali delle persone. La nostra stessa identità viene sempre di più vista come un valore da pensare come disseminata in vari spazi e non semplicemente legata alla nostra presenza fisica, alla nostra realtà biologica.
- Una pastorale attenta all’interiorità e all’interattività
Oltre all’ascolto, più in generale, la vita spirituale dell’uomo contemporaneo è certamente toccata dal mondo in cui le persone scoprono e vivono queste dinamiche della Rete, che sono interattive e immersive. L’uomo che ha una certa abitudine all’esperienza di internet infatti appare più pronto all’interazione che all’interiorizzazione. E generalmente «interiorità» è sinonimo di profondità, mentre «interattività» è spesso sinonimo di superficialità. Saremo condannati alla superficialità? E’ possibile coniugare profondità e interattività? La sfida è di grande portata.
Sostanzialmente possiamo constatare che l’uomo di oggi, abituato all’interattività, interiorizza le esperienze se è in grado di tessere con esse una relazione viva e non puramente passiva, recettiva. L’uomo di oggi ritiene valide le esperienze nelle quali è richiesta la sua «partecipazione» e il suo coinvolgimento.
Una strada è quella proposta dagli Esercizi spirituali ignaziani.
Chi fa gli Esercizi ignaziani viene invitato a immergersi nel testo biblico in almeno tre modi:
– proiettando con l’immaginazione il proprio corpo nella scena rappresentata;
– partecipando alle emozioni dei personaggi;
– rivivendo passo passo le vicende del mistero contemplato.
Come esempio paradigmatico leggo il testo che invita a contemplare la nascita di Gesù:
«Vedere con gli occhi dell’immaginazione la via da Nazareth a Betlemme, considerandone la lunghezza e la larghezza, se tale via è pianeggiante o se attraversa valli o alture. Nello stesso modo, guardando il luogo o grotta della Natività, vedere quanto sia grande o piccolo, basso o alto e come sia addobbato. […] vedere le persone; vale a dire vedere la Madonna, Giuseppe e l’ancella e il bambino Gesù, appena nato. Mi farò simile a un povero e indegno schiavo, guardandoli, contemplandoli e servendoli nei loro bisogni, come se fossi lì presente, con tutto il rispetto e la riverenza possibili; […] guardare, notare e contemplare ciò che dicono, […] guardare e considerare ciò che fanno, per esempio, camminare e lavorare …».
L’esercizio spirituale implica un pieno coinvolgimento dell’esercitante, che si «immerge» nella scena come in una sorta di «realtà virtuale», una Second Life: non vede la scena della natività, della grotta di Bethlem, ma vede se stesso trasferito lì, dentro quella scena.
L’esercitante dunque è chiamato a entrare in un vero e proprio ambiente virtuale, che è la cosiddetta composición viendo el lugar, composizione vedendo il luogo (ES 47), una vera e propria visione stereoscopica totale.
A questo punto però appare molto chiara una cosa: l’esperienza degli Esercizi non è di tipo puramente interiorizzante. Essi generano una esperienza interattiva: l’esercitante è chiamato a immergersi nella realtà contemplata e a interagire pienamente con essa senza filtri.
La spiritualità dell’uomo contemporaneo è molto sensibile a queste esperienze. Il giovane comunicatore che si abitua alla comunicazione digitale che è interattiva e immersiva è quindi chiamato a imparare a vivere la propria spiritualità in una maniera interattiva e immersiva con la Parola di Dio. L’importante, credo, sia non opporre radicalmente profondità a interazione, superficialità a interiorizzazione.
Dunque la profondità si coniuga con una immersione in una vera e propria «realtà virtuale», quella della vicenda biblica resa attuale con l’immaginazione. E si coniuga con un’interazione viva con i personaggi e l’ambiente circostante. Il contemplativo qui non vede la scena della natività, della grotta di Bethlem, ma vede se stesso trasferito «dentro» quella scena.
A questo punto però appare molto chiara una cosa: l’esperienza degli Esercizi Spirituali non è di tipo puramente «interiorizzante». Essi generano un’esperienza «interattiva»: l’esercitante è chiamato a immergersi nella realtà contemplata e a interagire pienamente con essa senza filtri. La profondità qui deriva dall’intensità delle relazioni e delle interazioni che si creano durante la contemplazione.
Nel web inteso come luogo antropologico non ci sono «profondità» da esplorare ma «nodi» da navigare e connettere tra di loro in maniera fitta. Ciò che appare «superficiale» è solamente il procedere in modo, magari inatteso e non previsto, da un nodo all’altro. La spiritualità dell’uomo contemporaneo è molto sensibile a queste esperienze: «la superficie al posto della profondità, la velocità al posto della riflessione, le sequenze al posto dell’analisi, il surf al posto dell’approfondimento, la comunicazione al posto dell’espressione, il multitasking al posto della specializzazione» (Alessandro Baricco).
Quale sarà dunque la spiritualità di quelle persone il cui modus cogitandi è in fase di «mutazione» a causa del loro abitare nell’ambiente digitale? L’uomo oggi è chiamato ad imparare a vivere la propria spiritualità in una maniera interattiva e immersiva con la Parola di Dio. E questo è anche una delle principali sfide educative dei nostri giorni. Il rischio di perdere il valore delle soste meditative, del silenzio, del bisogno di interiorizzazione è grande e va evitato in tutti i modi.
Una via per evitare questa perdita consiste nell’evitare di opporre troppo velocemente profondità a interazione, superficialità a interiorizzazione.
*********
La rete è un ambiente e una esperienza
Il significato spirituale della tecnologia digitale
La fede nell’ambiente digitale.
Alcune sfide importanti:
- Dalla pastorale della risposta alla pastorale della domanda
- Dalla pastorale centrata sui contenuti alla pastorale centrata sulle persone
- Dalla pastorale della trasmissione alla pastorale della testimonianza
- Dalla pastorale della propaganda alla pastorale della prossimità
- Dalla pastorale delle idee alla pastorale della narrazione
- Dalla pastorale della voce e del testo a quella (anche) dell’immagine
- Dalla comunità al network e viceversa
- Dal pensare in gruppo al pensare in rete
- Chi è il mio «prossimo»?
- Una pastorale attenta all’interiorità e all’interattività
La rete non è certo priva di ambiguità e utopie. In ogni caso la società fondata sulle reti di connessione comincia a porre sfide davvero significative sia alla pastorale sia alla comprensione stessa della fede cristiana, a partire dal suo linguaggio di espressione. Le sfide sono esigenti. Il nostro compito lo è altrettanto.
Antonio Spadaro, sj
Fonte: http://docplayer.it/4984018-L-evangelizzazione-e-la-rete-opportunita-e-illusioni-p-antonio-spadaro.html
[1] S. TURKLE, Alone together. Why we expect more from technology and less from each other, New York, Basic Books, , 2011.
[2] Cfr B. E. BRASHER, Give Me That Online Religion, New Brunswick (NJ), Rutgers University Press, 2004, 116-119, cioè il paragrafo: «Who Is Our Virtual Neighbour?».
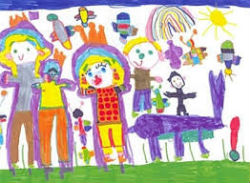 Il decreto legislativo 0-6 anni, pubblicato il 16 maggio 2017, riafferma innanzitutto il diritto inviolabile all’educazione, che spetta a tutti i bambini senza alcuna discriminazione. Nulla di nuovo: il decreto cita testualmente la Costituzione del 1948. Ma quali passi mette in atto per garantire il diritto riconosciuto?
Il decreto legislativo 0-6 anni, pubblicato il 16 maggio 2017, riafferma innanzitutto il diritto inviolabile all’educazione, che spetta a tutti i bambini senza alcuna discriminazione. Nulla di nuovo: il decreto cita testualmente la Costituzione del 1948. Ma quali passi mette in atto per garantire il diritto riconosciuto?


 La buona scuola pubblica paritaria italiana sta morendo?
La buona scuola pubblica paritaria italiana sta morendo?
 La donna oggi al centro della società e nella scuola
La donna oggi al centro della società e nella scuola
 Una battaglia trasversale di civiltà
Una battaglia trasversale di civiltà


 La non violenza: stile di una politica per la pace, tema scelto da Papa Francesco per la Giornata della Pace 2017, indica la pace come fondamento di una società – nazionale che internazionale – nella quale vengano rispettati i diritti della vita, l’accettazione della diversità, l’uguaglianza tra gli uomini di ogni età, categoria sociale, religione; in cui venga salvaguardata la natura di ogni vivente, sia esso uomo o animale.
La non violenza: stile di una politica per la pace, tema scelto da Papa Francesco per la Giornata della Pace 2017, indica la pace come fondamento di una società – nazionale che internazionale – nella quale vengano rispettati i diritti della vita, l’accettazione della diversità, l’uguaglianza tra gli uomini di ogni età, categoria sociale, religione; in cui venga salvaguardata la natura di ogni vivente, sia esso uomo o animale.
 L’abate Arsenio diceva d’essersi pentito spesso d’aver parlato, e mai d’aver taciuto. Intendeva che il silenzio è una disciplina interiore alla quale va prestata attenzione. Dice santa Teresa: «È grave colpa quando una sorella
L’abate Arsenio diceva d’essersi pentito spesso d’aver parlato, e mai d’aver taciuto. Intendeva che il silenzio è una disciplina interiore alla quale va prestata attenzione. Dice santa Teresa: «È grave colpa quando una sorella
 La rete è un ambiente e una esperienza
La rete è un ambiente e una esperienza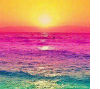
 E’ con viva trepidazione che mi accingo a dire soltanto qualcosa sul tema. Lo faccio consapevole che, prima ancora di parlare a voi, è un dialogo intenso con il mio cuore, anche perché, durante tutta la mia vita, ho sempre sentito la fecondità della beatitudine “Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia” (Mt 5,7).
E’ con viva trepidazione che mi accingo a dire soltanto qualcosa sul tema. Lo faccio consapevole che, prima ancora di parlare a voi, è un dialogo intenso con il mio cuore, anche perché, durante tutta la mia vita, ho sempre sentito la fecondità della beatitudine “Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia” (Mt 5,7).
 …La sequela di Gesù è un impegno serio e al tempo stesso gioioso; richiede radicalità e coraggio per riconoscere il Maestro divino nel più povero e scartato della vita e mettersi al suo servizio. Per questo, i volontari che servono gli ultimi e i bisognosi per amore di Gesù non si aspettano alcun ringraziamento e nessuna gratifica, ma rinunciano a tutto questo perché hanno scoperto il vero amore. E ognuno di noi può dire: “Come il Signore mi è venuto incontro e si è chinato su di me nel momento del bisogno, così anch’io vado incontro a Lui e mi chino su quanti hanno perso la fede o vivono come se Dio non esistesse, sui giovani senza valori e ideali, sulle famiglie in crisi, sugli ammalati e i carcerati, sui profughi e immigrati, sui deboli e indifesi nel corpo e nello spirito, sui minori abbandonati a sé stessi, così come sugli anziani lasciati soli. Dovunque ci sia una mano tesa che chiede aiuto per rimettersi in piedi, lì deve esserci la nostra presenza e la presenza della Chiesa che sostiene e dona speranza”. E, questo, farlo con la viva memoria della mano tesa del Signore su di me quando ero a terra.
…La sequela di Gesù è un impegno serio e al tempo stesso gioioso; richiede radicalità e coraggio per riconoscere il Maestro divino nel più povero e scartato della vita e mettersi al suo servizio. Per questo, i volontari che servono gli ultimi e i bisognosi per amore di Gesù non si aspettano alcun ringraziamento e nessuna gratifica, ma rinunciano a tutto questo perché hanno scoperto il vero amore. E ognuno di noi può dire: “Come il Signore mi è venuto incontro e si è chinato su di me nel momento del bisogno, così anch’io vado incontro a Lui e mi chino su quanti hanno perso la fede o vivono come se Dio non esistesse, sui giovani senza valori e ideali, sulle famiglie in crisi, sugli ammalati e i carcerati, sui profughi e immigrati, sui deboli e indifesi nel corpo e nello spirito, sui minori abbandonati a sé stessi, così come sugli anziani lasciati soli. Dovunque ci sia una mano tesa che chiede aiuto per rimettersi in piedi, lì deve esserci la nostra presenza e la presenza della Chiesa che sostiene e dona speranza”. E, questo, farlo con la viva memoria della mano tesa del Signore su di me quando ero a terra.