 La vita è come un castello, un castello di nostra proprietà, al cui interno è la camera da letto dove il Signore, padrone del castello e nostro amante, ci attende. Perché quella camera è anche la nostra camera, la camera d’amore che ci appartiene. Ma noi siamo fuori del castello, alle sue porte, a chiedere l’elemosina, senza comprendere che quel castello è nostro e vi possiamo entrare come e quando vogliamo. Viviamo di carrube fuori del castello eppure ne siamo i proprietari.
La vita è come un castello, un castello di nostra proprietà, al cui interno è la camera da letto dove il Signore, padrone del castello e nostro amante, ci attende. Perché quella camera è anche la nostra camera, la camera d’amore che ci appartiene. Ma noi siamo fuori del castello, alle sue porte, a chiedere l’elemosina, senza comprendere che quel castello è nostro e vi possiamo entrare come e quando vogliamo. Viviamo di carrube fuori del castello eppure ne siamo i proprietari.
Ecco la potente metafora del Castello interiore di Teresa d’Avila. Quante volte ci sentiamo come fuori dalla nostra stessa vita, spettatori di un film che scorre e che non è il nostro. Quante volte ci sembra di essere fuori dal cuore della nostra stessa vita, persi dietro desideri secondari, poiché non sappiamo ancora dove mettere radici, poiché non sappiamo cosa realmente desideriamo.
Ecco come Teresa inizia a tratteggiare l’immagine del castello:
«Oggi stavo supplicando il Signore di parlare in luogo mio, perché non sapevo cosa dire, né come cominciare ad obbedire al comando che mi è stato imposto, ed ecco quello che mi venne in mente. Mi servirà di fondamento a quanto dirò. Possiamo considerare la nostra anima come un castello fatto di un sol diamante o di un tersissimo cristallo, nel quale vi siano molte mansioni [stanze in successione sempre più interne], come molte ve ne sono in cielo.
Del resto, sorelle, se ci pensiamo bene, che cos’è l’anima del giusto se non un paradiso, dove il Signore dice di prendere le sue delizie? E allora come sarà la stanza in cui si diletta un Re così potente, così saggio, così puro, così pieno di ricchezze? No, non vi è nulla che possa paragonarsi alla grande bellezza di un’anima e alla sua immensa capacità!»
Al cuore della nostra stessa vita, così come essa è, c’è una stanza dove abita Dio. Questo rende la nostra vita la più alta delle realtà create. Vivere non è un assurdo:
«Il nostro intelletto, per acuto che sia, non arriverà mai a comprenderla, come non potrà mai comprendere Iddio, alla cui immagine e somiglianza noi siamo stati creati. Se ciò è vero – e non se ne può dubitare – è inutile che ci stanchiamo nel voler comprendere la bellezza del castello. Tuttavia, per avere un’idea della sua eccellenza e dignità, basta pensare che Dio dice di averlo fatto a sua immagine, benché tra il castello e Dio vi sia sempre la differenza di Creatore e creatura, essendo anche l’anima una creatura».
L’assurdo della condizione umana sta nel fatto che l’uomo non si cura della bellezza della propria vita, non si cura della bellezza della propria anima. Ed è come se uno non sapesse come si chiama o chi è!
«Non sarebbe grande ignoranza, figliuole mie, se uno, interrogato chi fosse, non sapesse rispondere, né dare indicazioni di suo padre, di sua madre, né del suo paese di origine?
Se ciò è indizio di grande ottusità, assai più grande è senza dubbio la nostra se non procuriamo di sapere chi siamo, per fermarci solo ai nostri corpi.
Sì, sappiamo di avere un’anima, perché l’abbiamo sentito e perché ce l’insegna la fede, ma così all’ingrosso, tanto vero che ben poche volte pensiamo alle ricchezze che sono in lei, alla sua grande eccellenza e a Colui che in essa abita.
E ciò spiega la nostra grande negligenza nel procurare di conservarne la bellezza. Le nostre preoccupazioni si fermano tutte alla rozzezza del castone, alle mura del castello, ossia a questi nostri corpi.
Come ho detto, questo castello risulta di molte stanze, alcune poste in alto, altre in basso ed altre ai lati. Al centro, in mezzo a tutte, vi è la stanza principale, quella dove si svolgono le cose di grande segretezza tra Dio e l’anima».
Il paradosso della vita è che Dio è nel nostro cuore, ma noi siamo fuori dal nostro stesso cuore. Noi non entriamo abitualmente in noi stessi e viviamo come mendicanti alle porte del castello ed, allo stesso tempo, siamo dentro il castello e ne siamo i proprietari: è la nostra anima, dove possiamo parlare con Dio:
«Tornando al nostro incantevole e splendido castello, dobbiamo ora vedere il modo di potervi entrare. Sembra che dica uno sproposito, perché se il castello è la stessa anima, non si ha certo bisogno di entrarvi, perché si è già dentro. Non è forse una sciocchezza dire a uno di entrare in una stanza quando già vi sia? Però dovete sapere che vi è una grande differenza tra un modo di essere e un altro, perché molte anime stanno soltanto nei dintorni, là dove sostano le guardie, senza curarsi di andare più innanzi, né sapere cosa si racchiuda in quella splendida dimora, né chi l’abiti, né quali appartamenti contenga. Se avete letto in qualche libro di orazione consigliare l’anima ad entrare in se stessa, è proprio quello che intendo io».
La via della preghiera ci permette di cominciare ad addentrarci nel castello. Se l’uomo smette di essere attento solo al possesso delle cose e rientra in se stesso, ecco che pian piano si addentra nei primi appartamenti, nelle prime mansioni del castello. Entra cioè in se stesso, nella propria bellezza, inizia a scoprire la propria vocazione:
«Mi diceva ultimamente un gran teologo che le anime senza orazione sono come un corpo storpiato o paralitico che ha mani e piedi, ma non li può muovere. Ve ne sono di così ammalate e talmente avvezze a vivere fra le cose esteriori, da esser refrattarie a qualsiasi cura, quasi impotenti a rientrare in se stesse. […] Per quanto io ne capisca, la porta per entrare in questo castello è l’orazione e la meditazione».
Chi non prega, non incontra il padrone del castello, Dio, e non scopre di essere l’amante di quel Signore, che l’attende per regnare con lei nel castello.
Già aver deciso di entrare nel castello, anche se è solo il primo passo, è decisivo. L’uomo smette di vivere di espedienti ed inizia ad avvicinarsi a Dio, iniziando al contempo ad avvicinarsi al cuore della propria anima, poiché l’una e l’altra realtà non si possono mai separare:
«Parliamo […] di quelle che […] finiscono con entrare nel castello. Benché ingolfate nel mondo, non mancano di buoni desideri: di tanto in tanto si raccomandano a Dio, e, sia pure in fretta, rientrano in se stesse con qualche considerazione. Pregano qualche volta al mese, benché distrattamente, dato che il loro pensiero è quasi sempre tra gli affari, a cui sono molto attaccate, secondo il detto: Dov’è il tuo tesoro ivi è il tuo cuore. Però, di tanto in tanto decidono di liberarsene perché, grazie al proprio conoscimento – che è sempre una gran cosa – riconoscono che la strada per cui camminano non è quella che conduce al castello. Finalmente entrano nelle prime stanze del pianterreno, ma vi portano con sé un’infinità di animaletti, i quali non solo impediscono di veder le bellezze del castello, ma neppur permettono di rimanervi in pace. Tuttavia han già fatto molto con l’entrarvi».
Parlando di questi primi appartamenti, di queste prime mansioni, in cui l’anima si addentra, Teresa fa notare che all’inizio tutto appare buio, nel fondo del nostro cuore, a motivo del peccato. Ma non appena l’anima comincia ad allontanarsi dal peccato e a rivolgersi al bene, ecco che si accorge che in realtà il castello all’interno è luminoso. Il castello, la nostra vita, si trasfigura se viviamo nel bene, se ci avviciniamo al bene. Tutto cambia nell’anima se vive nel peccato o se comincia a cercare la verità:
«Prima di andare innanzi, vi prego di considerare come si trasformi questo castello meraviglioso e risplendente, questa perla orientale, quest’albero di vita piantato nelle stesse acque vive della vita che è Dio, quando s’imbratti di peccato mortale. Non vi sono tenebre così dense, né cose tanto tetre e buie, che non ne siano superate e di molto. Il Sole che gli compartiva tanta bellezza e splendore è come se più non vi sia, perché, pur rimanendo ancora nel suo centro, l’anima tuttavia non ne partecipa più. Conserva sempre la capacità di goderlo, come il cristallo di riflettere i raggi, ma intanto non vi è più nulla che le sia di merito; e finché dura in quello stato, non le giovano a nulla per l’acquisto della gloria neppure le sue buone opere, perché, non procedendo esse da quel principio per cui la nostra virtù è virtù – voglio dire da Dio, da cui, anzi, si allontanano – non gli possono essere accette. Infatti, chi commette un peccato mortale intende di contentare, non Dio, ma il demonio; e siccome il demonio non è che tenebra, la povera anima si fa tenebra con lui. So di una persona [Parla di se stessa, ndr] a cui il Signore volle far vedere lo stato di un’anima in peccato mortale».
Ma se anche noi siamo nel peccato, la stanza dove Dio abita e ci ama e ci attende, resta intatta al centro del castello! Il cuore della nostra anima risplende e noi non lo sappiamo:
«Si deve intanto considerare che la fonte, o, a meglio dire, il Sole splendente che sta nel centro dell’anima, non perde per questo il suo splendore né la sua bellezza. Continua a star nell’anima, e non vi è nulla che lo possa scolorire. Supponete un cristallo esposto ai raggi del sole, ravvolto in un panno molto nero: il sole dardeggerà sulla stoffa, ma il cristallo non ne verrà illuminato».
C’è un cuore del castello che è abitato. C’è un cuore del castello dove abita Dio. C’è un cuore del castello dove Dio vuole parlare e intrattenersi con noi. Noi possiamo esserne fuori, ma Egli è là, al cuore del nostro cuore.
Teresa aggiunge qui un secondo esempio, quello del cuore della palma che si trova in Andalusia:
«Ritorniamo dunque al nostro castello e alle sue molte mansioni. Non dovete figurarvi queste mansioni le une dopo le altre, come una fuga di stanze. Portate il vostro sguardo al centro, dove è situato l’appartamento o il palazzo del Re. Egli vi abita come in una palmista [palma tipica dell’Andalusia, ndr] di cui non si può prendere il buono se non togliendo le molte foglie che lo coprono. Così qui: intorno e al di sopra della stanza centrale, ve ne sono molte altre, illuminate in ogni parte dal Sole che risiede nel mezzo. Le cose dell’anima si devono sempre considerare con ampiezza, estensione e magnificenza, senza paura di esagerare, perché la capacità dell’anima sorpassa ogni umana immaginazione. Importa molto che un’anima di orazione, a qualunque grado sia giunta, sia lasciata libera di circolare come vuole, in alto, in basso, e ai lati, senza incantucciarla e restringerla in una sola stanza».
Antonio Maria Sicari, carmelitano e grande studioso della spiritualità carmelitana, ha voluto paragonare il castello di Teresa al Castello di F. Kafka. Il grande romanziere ha utilizzato come Teresa l’immagine del castello per dire, però, il definitivo spaesamento dell’uomo, destinato a non capire nulla della vita. Nel Castello di Kafka l’uomo non riesce a comprendere nulla di quella struttura immensa che è solo un’assurdità che rivela come la vita stessa sia assurda e l’uomo destinato a non poterne mai raggiungere i senso.
Ne Il processo F. Kafka inserisce un racconto, che sarà poi pubblicato separatamente, che dice molto della sua esperienza di vita. Si intitola Davanti alla legge.
Davanti alla legge sta un guardiano. Un uomo di campagna viene da questo guardiano e gli chiede il permesso di accedere alla legge. Ma il guardiano gli risponde che per il momento non glielo può consentire. L’uomo dopo aver riflettuto chiede se più tardi gli sarà possibile. «Può darsi,» dice il guardiano, «ma adesso no.» Poiché la porta di ingresso alla legge è aperta come sempre e il guardiano si scosta un po’, l’uomo si china per dare, dalla porta, un’occhiata nell’interno.
Il guardiano, vedendolo, si mette a ridere, poi dice: «Se ti attira tanto, prova a entrare ad onta del mio divieto. Ma bada: io sono potente. E sono solo l’ultimo dei guardiani. All’ingresso di ogni sala stanno dei guardiani, uno più potente dell’altro. Già la vista del terzo riesce insopportabile anche a me.»
L’uomo di campagna non si aspettava tali difficoltà; la legge, nel suo pensiero, dovrebbe esser sempre accessibile a tutti; ma ora, osservando più attentamente il guardiano chiuso nella sua pelliccia, il suo gran naso a becco, la lunga e sottile barba nera all’uso tartaro decide che gli conviene attendere finché otterrà il permesso. Il guardiano gli dà uno sgabello e lo fa sedere a lato della porta.
Giorni e anni rimane seduto lì. Diverse volte tenta di ricevere il permesso di entrare, e stanca il guardiano con le sue preghiere. Il guardiano sovente lo sottopone a brevi interrogatori, gli chiede della sua patria e di molte altre cose, ma sono domande fatte con distacco, alla maniera dei gran signori, e alla fine conclude sempre dicendogli che non può consentirgli l’ingresso. L’uomo, che si è messo in viaggio ben equipaggiato, dà fondo ad ogni suo avere, per quanto prezioso possa essere, pur di corrompere il guardiano, e questi accetta sì ogni cosa, pero gli dice: «Lo accetto solo perché tu non creda di aver trascurato qualcosa.»
Durante tutti quegli anni l’uomo osserva il guardiano quasi incessantemente; dimentica che ve ne sono degli altri, quel primo gli appare l’unico ostacolo al suo accesso alla legge. Impreca alla propria sfortuna, nei primi anni senza riguardi e a voce alta, poi, man mano che invecchia, limitandosi a borbottare tra sé. Rimbambisce, e poiché, studiando per tanti anni il guardiano, ha individuato anche una pulce nel collo della sua pelliccia, prega anche la pulce di intercedere presso il guardiano perché cambi idea.
Alla fine gli s’affievolisce il lume degli occhi, e non sa se è perché tutto gli si fa buio intorno, o se siano i suoi occhi a tradirlo. Ma ora, nella tenebra, avverte un bagliore che scaturisce inestinguibile dalla porta della legge. Non gli rimane più molto da vivere.
Prima della morte tutte le nozioni raccolte in quel lungo tempo gli si concentrano nel capo in una domanda che non ha mai posta al guardiano; e gli fa cenno, poiché la rigidità che vince il suo corpo non gli permette più di alzarsi. Il guardiano deve abbassarsi grandemente fino a lui, dato che la differenza delle stature si è modificata a svantaggio dell’uomo. «Che cosa vuoi sapere ancora?» domanda il guardiano, «sei proprio insaziabile.»
«Tutti si sforzano di arrivare alla legge,» dice l’uomo, «e come mai allora nessuno in tanti anni, all’infuori di me, ha chiesto di entrare?»
Il guardiano si accorge che l’uomo è agli estremi e, per raggiungere il suo udito che già si spegne, gli urla: «Nessun altro poteva ottenere di entrare da questa porta, a te solo era riservato l’ingresso. E adesso vado e la chiudo».
Nella visione kafkiana l’uomo è come un alienato che attende invano. Esiste un castello, un complicato labirinto inaccessibile, pensato per ogni singolo uomo, ma solo perché ognuno vi sprechi ogni energia inutilmente per entrarvi, per trovare un senso alle cose.
Per Teresa, invece, l’uomo può entrare nel castello se solo lo vuole. Perché la vita non è un assurdo. Perché l’uomo, nella sua visione, non desidera tanto comprendere la Legge, bensì intuisce di avere un cuore, la propria anima, in cui abita Dio. Anche per Teresa chi non entra nel castello resta un alienato, ma ella scrive perché ognuno trovi la fiducia di non restare ai margini della vita, bensì diventi credente, scoprendo che è possibile entrare nel cuore della propria vita, per scoprire che ci appartiene e che Dio ci attira a sé.
Questa la potente immagine teresiana. Il castello interiore descrive poi le sette dimore. Dopo la prima che insiste sul conoscere se stessi, segue la seconda nella quale l’anima scopre la fatica di pregare e che la fatica stessa è preghiera. Viene poi la terza nella quale l’anima è tentata di prendere se stessa a misura della vita spirituale ed è ossessionata dal guardarsi. segue la quarta nella quale l’anima impara a raccogliersi per lasciarsi accogliere da Dio come un bambino che si raccoglie per gettarsi in braccio a suo padre. Viene poi la quinta, con la famosa immagine del bozzolo, nella quale l’anima impara a morire per ritrovare in Dio la vita. Segue poi la sesta con il fidanzamento spirituale e la notte dello spirito nella quale l’anima impara che Dio è veramente tutto e che è bene lasciare ogni cosa per essere con Lui come avviene con l’avanzare del fidanzamento quando si rinuncia a tutto per l’amato. L’opera culmina poi con la settima, l’unione con Dio, l’ingresso nella stanza della comunione mistica con il Signore. Ma per capirne anche solo qualcosa non basta leggere l’intero volume di Teresa, serve una vita intera, serve l’esperienza viva di un cammino di fede.
A noi bastava in questa presentazione introdurre al castello della nostra vita perché ognuno possa incamminarsi sapendo che quel castello gli appartiene e che quel castello non è disabitato, come sembrerebbe a chi non conosce la vita: la nostra vita è, invece, già abitata da Dio.
Don Andrea Lonardo
 La misericordia è un tema comune delle due religioni, cristianesimo e islam, una parola “ponte” come si dice.
La misericordia è un tema comune delle due religioni, cristianesimo e islam, una parola “ponte” come si dice.




 La virtù è “un dispositivo” etico e umano e si costruisce attraverso la pratica; presuppone, quindi, un processo di crescita del soggetto: l’uomo virtuoso è, infatti, colui che agisce con consapevolezza e responsabilità. In una società come la nostra, intessuta dai media digitali, diventa di vitale importanza lavorare (educare, fare pastorale) per aiutare le persone a diventare “soggetti virtuosi” anche nel loro quotidiano “scenario digitale”.
La virtù è “un dispositivo” etico e umano e si costruisce attraverso la pratica; presuppone, quindi, un processo di crescita del soggetto: l’uomo virtuoso è, infatti, colui che agisce con consapevolezza e responsabilità. In una società come la nostra, intessuta dai media digitali, diventa di vitale importanza lavorare (educare, fare pastorale) per aiutare le persone a diventare “soggetti virtuosi” anche nel loro quotidiano “scenario digitale”.
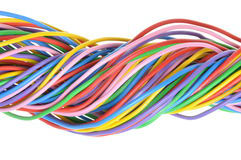 La vita è un tessuto nel quale si intrecciano i fili che possiamo chiamare « il filo dei progetti» e « il filo degli imprevisti ». Con il filo dei progetti (dei piani, delle previsioni…), gestito dalla spola della nostra mente indagatrice, immaginiamo il futuro, elaboriamo programmi, cerchiamo di modificare volontariamente i nostri comportamenti e le nostre reazioni…; ed è bene che sia così, perché « da principio Dio creò l’uomo e lo lasciò in balìa del suo proprio volere » (Sir 15,14). Quando davanti a noi si impone l’orizzonte dell’invecchiamento, abbiamo bisogno di esercitare la nostra capacità di affrontare questa tappa e di progettare come vogliamo viverla.
La vita è un tessuto nel quale si intrecciano i fili che possiamo chiamare « il filo dei progetti» e « il filo degli imprevisti ». Con il filo dei progetti (dei piani, delle previsioni…), gestito dalla spola della nostra mente indagatrice, immaginiamo il futuro, elaboriamo programmi, cerchiamo di modificare volontariamente i nostri comportamenti e le nostre reazioni…; ed è bene che sia così, perché « da principio Dio creò l’uomo e lo lasciò in balìa del suo proprio volere » (Sir 15,14). Quando davanti a noi si impone l’orizzonte dell’invecchiamento, abbiamo bisogno di esercitare la nostra capacità di affrontare questa tappa e di progettare come vogliamo viverla.
 Gli apostoli hanno parlato in tutte le lingue. Così certamente Dio volle allora manifestare la presenza dello Spirito Santo, in modo che colui che l’avesse ricevuto, potesse parlare in tutte le lingue. Bisogna infatti comprendere bene, fratelli carissimi, che è proprio grazie allo Spirito Santo che la carità di Dio si trova nei nostri cuori. E poiché la carità doveva radunare la Chiesa di Dio da ogni parte del mondo, un solo uomo, ricevendo lo Spirito Santo, poté allora parlare tutte le lingue. Così ora la Chiesa, radunata per opera dello Spirito Santo, esprime la sua unità in tutte le lingue. Perciò se qualcuno dirà a uno di noi: Hai ricevuto lo Spirito Santo, per quale motivo non parli in tutte le lingue? Devi rispondere: Certo che parlo in tutte le lingue, infatti sono inserito in quel corpo di Cristo cioè nella Chiesa, che parla tutte le lingue. Che cosa altro in realtà volle significare Dio per mezzo della presenza dello Spirito Santo, se non che la sua Chiesa avrebbe parlato in tutte le lingue?
Gli apostoli hanno parlato in tutte le lingue. Così certamente Dio volle allora manifestare la presenza dello Spirito Santo, in modo che colui che l’avesse ricevuto, potesse parlare in tutte le lingue. Bisogna infatti comprendere bene, fratelli carissimi, che è proprio grazie allo Spirito Santo che la carità di Dio si trova nei nostri cuori. E poiché la carità doveva radunare la Chiesa di Dio da ogni parte del mondo, un solo uomo, ricevendo lo Spirito Santo, poté allora parlare tutte le lingue. Così ora la Chiesa, radunata per opera dello Spirito Santo, esprime la sua unità in tutte le lingue. Perciò se qualcuno dirà a uno di noi: Hai ricevuto lo Spirito Santo, per quale motivo non parli in tutte le lingue? Devi rispondere: Certo che parlo in tutte le lingue, infatti sono inserito in quel corpo di Cristo cioè nella Chiesa, che parla tutte le lingue. Che cosa altro in realtà volle significare Dio per mezzo della presenza dello Spirito Santo, se non che la sua Chiesa avrebbe parlato in tutte le lingue?
 Vorrei condividere con voi alcune riflessioni che, alla luce dell’Anno della Misericordia e in stretto legame con l’ambito economico, toccano da vicino il nostro vissuto personale e pastorale.
Vorrei condividere con voi alcune riflessioni che, alla luce dell’Anno della Misericordia e in stretto legame con l’ambito economico, toccano da vicino il nostro vissuto personale e pastorale.
 La vita è come un castello, un castello di nostra proprietà, al cui interno è la camera da letto dove il Signore, padrone del castello e nostro amante, ci attende. Perché quella camera è anche la nostra camera, la camera d’amore che ci appartiene. Ma noi siamo fuori del castello, alle sue porte, a chiedere l’elemosina, senza comprendere che quel castello è nostro e vi possiamo entrare come e quando vogliamo. Viviamo di carrube fuori del castello eppure ne siamo i proprietari.
La vita è come un castello, un castello di nostra proprietà, al cui interno è la camera da letto dove il Signore, padrone del castello e nostro amante, ci attende. Perché quella camera è anche la nostra camera, la camera d’amore che ci appartiene. Ma noi siamo fuori del castello, alle sue porte, a chiedere l’elemosina, senza comprendere che quel castello è nostro e vi possiamo entrare come e quando vogliamo. Viviamo di carrube fuori del castello eppure ne siamo i proprietari.
 Camminando attraverso i giorni luminosi e oscuri di questo nostro tempo …
Camminando attraverso i giorni luminosi e oscuri di questo nostro tempo …
 Misericordia rivelata nella croce e nella resurrezione
Misericordia rivelata nella croce e nella resurrezione
 Nella Sacra Scrittura, il Signore è presentato come “Dio misericordioso”. È questo il suo nome, attraverso cui Egli ci rivela, per così dire, il suo volto e il suo cuore. Egli stesso, come narra il Libro dell’Esodo, rivelandosi a Mosè si autodefinisce così: «Il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà» (34,6). Anche in altri testi ritroviamo questa formula, con qualche variante, ma sempre l’insistenza è posta sulla misericordia e sull’amore di Dio che non si stanca mai di perdonare (cfr Gn 4,2; Gl 2,13; Sal 86,15; 103,8; 145,8; Ne 9,17). Vediamo insieme, una per una, queste parole della Sacra Scrittura che ci parlano di Dio.
Nella Sacra Scrittura, il Signore è presentato come “Dio misericordioso”. È questo il suo nome, attraverso cui Egli ci rivela, per così dire, il suo volto e il suo cuore. Egli stesso, come narra il Libro dell’Esodo, rivelandosi a Mosè si autodefinisce così: «Il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà» (34,6). Anche in altri testi ritroviamo questa formula, con qualche variante, ma sempre l’insistenza è posta sulla misericordia e sull’amore di Dio che non si stanca mai di perdonare (cfr Gn 4,2; Gl 2,13; Sal 86,15; 103,8; 145,8; Ne 9,17). Vediamo insieme, una per una, queste parole della Sacra Scrittura che ci parlano di Dio.