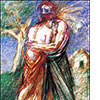Introduzione
Dopo aver a lungo riflettuto su questo tema così bello e affascinante, ho pensato di partire dalla seconda parte del tema: l’oggi della storia. Questo perché l’analisi del tempo in cui viviamo costituisce da molto tempo uno degli oggetti principali della mia ricerca intellettuale. Questo è insomma il mio pane quotidiano. Solo in un secondo momento, ho poi provato a cogliere degli spunti che diano respiro e profondità alla prima parte del titolo del nostro incontro: la profezia della donna consacrata.
Ovviamente questo tema della profezia della donna consacrata e più generale della vita consacrata è stato molto richiamato in questo anno speciale a voi dedicato. Basterebbe pensare ai documenti emanati apposta. Aggiungerci qualcosa non è facile. Confido, tuttavia, che i tre “aspetti profetici” che ho individuato, in stretta relazione allo sviluppo della prima parte della mia riflessione, possano contribuire ad allargare gli orizzonti della riflessione sulla presenza profetica nell’oggi della storia, che immagino non sarà mai stata così abbondante come in questo anno speciale.
Enucleo tre passaggi, ognuno dei quali è introdotto da una domanda.
a) Primo passaggio: capire l’oggi della storia implica fare un po’ di storia dell’oggi; quindi prima domanda: da dove veniamo?
b) Secondo passaggio: cogliere qual è il profilo antropologico dell’oggi della storia; quindi seconda domanda: che cosa ci contraddistingue di più nella nostra esperienza umana oggi?
c) Terzo passaggio: individuare gli ingredienti della “profezia” della donna consacrata; quindi terza domanda: che cosa può “ricordare”, a che cosa può dare voce, quali elementi può evidenziare la donna consacrata che in quest’oggi della storia sono dimenticati, vengono messi a tacere e sono stati mandati come in pensione anticipata?
Segnalo sin da subito sinteticamente le risposte a queste tre domande:
a) la prima è data dal fatto che il nostro oggi è frutto di una profonda rivoluzione/trasformazione che riguarda il nostro modo di essere al mondo, il nostro sentimento di vita, il nostro modo di sognare, di amare, di progettare, di valutare nulla di meno che l’umano in quanto tale. Per citare papa Francesco: non siamo in un’epoca di cambiamento ma in un cambiamento d’epoca;
b) la seconda risposta è la constatazione che non siamo quasi mai all’altezza di questo cambiamento (la cosa di per sé non è difficile da comprendere: si pensi solo alla questione della longevità: dobbiamo “programmare” almeno altri 20 anni di vita dopo la nostra pensione!): e per questo il carattere che contraddistingue di più l’uomo e la donna di oggi è “l’immaturità”, il giovanilismo diffuso, la fatica di essere adulti, la sindrome di Peter Pan che è diventato pure una scelta di vita e nello stesso tempo il tallone d’Achille su cui continuamente ci colpisce il potere forte di questa epoca: il mercato, il quale teme come la peste la gente matura, adulta (si pensi al fatto che ogni anno, in Italia, nonostante la crisi, spendiamo qualcosa come 9 miliardi di euro per prodotti per la cosmesi, inclusi i prodotti contro la caduta dei capelli, quando è a tutti noi che solo il pavimento è capace di fermare la caduta dei capelli!);
c) la terza risposta è data dal rilievo che oggi abbiamo perso un’importante familiarità con il carattere contingente dell’esistenza, con l’esperienza liberante e tonificante della preghiera e con quella fiducia d’anticipo sul carattere salvifico della comunità.
Insomma: in un universo culturale profondamente cambiato, nel quale gli umani faticano a salvaguardare la loro dignità, la donna consacrata è chiamata a essere voce, a far profezia del fatto che dobbiamo benedire la contingenza della vita, che senza la preghiera la pubblicità ci “frega” e che senza la dimensione comunitaria le famiglie si surriscaldano eccessivamente e il corpo sociale muore di assideramento.
Tre parole per la profezia della donna consacrata oggi: benedizione della contingenza, preghiera, comunità.
1. Primo passaggio: da dove veniamo
Per avviare la prima tappa del nostro itinerario, mi piace ricordare quanto ha scritto Galimberti: «Gli uomini non hanno mai abitato il mondo, ma sempre e solo la descrizione che di volta in volta il mito, la religione, la filosofia, la scienza hanno dato del mondo. Una descrizione attraverso parole stabili, collocate ai confini dell’universo per la sua delimitazione e all’interno dell’universo per la sua articolazione»[1].
Questo è il punto: noi abitiamo sempre una descrizione del mondo fatta da parole stabili, da punti cardinali, da valori forti, che ci offrono e determinano la possibilità di leggere e apprezzare il mondo. Ci orientano: ci danno un orizzonte culturale. Ed è proprio la diversa scelta e composizione delle parole stabili che contraddistingue la differente descrizione del mondo per esempio di un aborigeno australiano rispetto a quella di un occidentale.
Quando dico che la risposta giusta alla domanda “da dove veniamo?” è quella di riconoscersi all’indomani di una grande rivoluzione che riguarda il senso della vita, intendo più precisamente affermare che dobbiamo prendere coscienza del fatto che è cambiata la descrizione tradizionale dell’universo (occidentale): quella, per capirci, in cui e grazie alla quale ancora i nostri nonni e le nostre nonne abitavano il mondo[2].
In sostanza oggi sono molto diverse – rispetto appunto a quelle dei nostri nonni e delle nostre nonne – le parole chiave con cui leggiamo e valutiamo a livello spontaneo la nostra esistenza e l’esistenza degli altri. Possiamo dire che abitiamo diversamente da loro il mondo e quindi possiamo dire che abitiamo un mondo diverso. Si sono spostati, modificati, sostituiti i valori fondamentali, i punti di riferimento, gli assi cardinali della nostra immaginazione e del nostro giudizio spontanei. Con tanti guadagni e ovviamente con tante sfide. Siamo dunque in un mondo che è cambiato.
Per ridire la cosa con le parole di Marco Aime, dobbiamo accettare che «Le culture sono occhiali con cui leggere il mondo. Cambiando occhiali, anche la realtà sembra differente. Possiamo dire che ogni cultura cerca di dare un proprio ordine alla natura»[3]. Ecco cosa ci è successo: per tanto tempo abbiamo usato un tipo assai particolare di occhiali che ci faceva vedere le cose “così e così” e ora abbiamo cambiato appunto occhiali…
Il cambiamento di cui parliamo – la fabbricazione dei nuovi occhiali per restare all’esempio di prima – ha avuto inizio nella metà dell’Ottocento; tuttavia esso si è iniziato ad imporsi a livello diffuso a partire dalla rivoluzione culturale del Sessantotto, per questo parlavo dei nostri nonni e delle nostre nonne. In un primo momento il cambiamento ha riguardato alcune élite culturali oppure si è concentrato in specifici eventi storici; solo successivamente ha determinato il nostro modo di guardare e giudicare il mondo: la nostra descrizione del mondo. In sintesi: il nostro mondo.
Entriamo nei particolari di questo discorso e portiamoci al 1859. Che cosa succede nel 1859?
1)In quella data, Charles Darwin scrive il libro L’origine delle specie; con le tesi ivi esposte egli sgancia la comparsa dell’uomo sulla terra dal legame con Dio: invita a guardare l’origine della specie umana, piuttosto che in direzione dell’alto (il paradiso, il cielo, l’eternità), in direzione della nostra comune parentela con altri animali. Inizia così il cambiamento; e a seguire, pochi anni dopo Darwin, troviamo la prima e la seconda internazionale che intendono trasformare la protesta di Marx – non possiamo attendere il paradiso! – in programma politico. Ancora: Freud riformula il concetto di anima quale centro di aggregazione energetico, spogliandolo di ogni aspetto spirituale (non è più il cordone ombelicale del paradiso); l’avvio di quella che normalmente viene indicata come seconda rivoluzione industriale getta le basi per quella espansione globale del mercato, di cui oggi siamo spettatori. In quegli anni si sviluppa, infatti, l’impresa della General Motors e quella di Henry Ford, nasce la Coca cola e la Fiat: la terra non viene più percepita quale valle di lacrime, ma come un posto nel quale ci si può agevolmente installare. Che cosa capita, dunque? Con le parole di Nietzsche, si assiste al pensionamento del Platonismo, inteso come descrizione del mondo secondo due piani: il mondo eterno e vero, da una parte, e il mondo finito e finto, dall’altra; una descrizione secondo la quale l’uomo, dotato di un’anima eterna, aveva nel cielo la sua patria; il finito era inteso come un carcere da cui doversi liberare. Dopo Darwin, Freud, Marx, Ford, gli occhiali di Platone non servono più. Inizia a cambiare radicalmente la risposta alle quattro domande della vita: da dove veniamo? (Darwin); dove andiamo? (Marx); chi siamo? (Freud); che cosa facciamo qui? (si passa dall’economia della salvezza alla salvezza attraverso l’economia: patrimonio di Ford fu di 199 miliardi di dollari).
La prima parola chiave della tradizione classica occidentale che qui viene messa in discussione è quella dell’eternità, del paradiso, del cielo, mentre assume una nuova risonanza e consistenza la “finitezza”, il mondo concreto, la politica, l’economia. E questo avrà grande effetto ad ogni livello dell’immaginario, sia umano che religioso: oggi è rimasta solo la Lavazza a parlare del Paradiso….
2) Questo primo ribaltamento – dall’eterno al finito – è di grande impatto sulla “cultura alta” del primo decennio del Novecento ed assistiamo così ad una rivisitazione profonda di ogni branca del sapere. Il finito non è più una cosa negativa, dipendente esclusivamente dall’eterno, ma riveste un’altra dimensione. Tra il 1905 e il 1908 accade così un’altra grande stagione di rivisitazione della descrizione classica dell’Occidente. È l’epoca di Einstein e della sua teoria della relatività, è l’epoca di Picasso e il suo dipinto Les demoiselles d’Avignon che introduce l’arte cubista, è l’epoca di Schönberg e dei suoi Sei piccoli pezzi per pianoforte Op. 19 che avviano la musica atonale, è l’epoca di Joyce e di Proust con il Ritratto del giovane artista e La ricerca del tempo perduto, che sconvolgono i canoni letterari di fine Ottocento. È ancora l’epoca di Freud, che sgancia la sessualità dalla necessità della riproduzione.
È pure l’epoca di Thomas Mann e di Pirandello, l’epoca di Kafka, che ribalta ogni primato del vincitore sul vinto, del forte sulla vittima. E ancora si trova Kurt Gödel, il quale sancisce l’impossibilità di rinvenire principi primi da cui derivare la matematica. E cosa non dire della fenomenologia di Husserl, del pensiero ebraico dell’alterità e dell’attesa messianica di Buber e di Rosenzweig?
Che cosa succede? Succede che non si ha più fiducia in un’unica verità e in una verità unica, in una prospettiva definita e definitiva, ma emerge tutto il fascino della soggettività, dell’emotività, del lato notturno del cuore umano, della differenza, dell’alterità, dell’apertura e dell’ospitalità del diverso, del rispetto, del politicamente corretto, della tolleranza, dell’attesa. Un enorme cambiamento e positivo, pure, ma anche con grandi ripercussioni sull’elementare della vita: mancando di una prospettiva centrale, maggioritaria, la nostra coscienza è oggi un piccolo parlamento di tante voci, sovrapposte l’una all’altra a volte in modo caotico (come i canali digitali, che passano da TV2000 con “una serata insieme a papa Francesco” a Mediaset-extra con Bonolis e Ciao Darwin…).
3) Un terzo decisivo elemento di cambiamento è dato dalla tragedia dell’Olocausto. Nel 1942, nel campo di sterminio nazista di Auschwitz, “nasce” l’epoca della tecnica, la quale si caratterizza per il fatto che la ricerca finalizzata al potenziamento di mezzi più veloci per sterminare i prigionieri segna lo sganciamento della tecnica dal diretto legame con i bisogni del soggetto umano. Si impone l’assioma secondo il quale ciò che tecnicamente sperimentabile va semplicemente sperimentato: è l’avvio di quel processo di autoperfezionamento dei prodotti della ricerca tecnica, che prescinde dall’ambiente umano e che però rimodella di continuo. Questo modello ha avuto subito successo per i grandi cambiamenti che ha realizzato nel miglioramento delle condizioni medie della vita degli occidentali, dall’igiene alla salute (l’incredibile longevità attuale), dai viaggi alle comunicazioni, ma ha anche inciso su una certa concezione del mondo e della vita umana. Il mondo non è più un insieme di sostanze stabili e fisse, ma di relazioni e la vita non è fatta di faticose conquiste da preservare e migliorare ma di possibilità, di occasioni.
E che cosa ne è allora per esempio delle leggi naturali, in un mondo che non riconosce più alcun elemento di stabilità alle cose e agli individui? Tutto è relazione, tutto è in relazione, tutto è in vista della relazione.
Non dimentichiamo poi anche la forza dirompente dell’Olocausto sul livello inconscio dell’immagine di Dio. Di fronte all’Olocausto, chi ora ha ragione, il prete che predica la creazione divina degli uomini o Darwin che dimostra la loro derivazione dalle scimmie? Chi ha ragione il catechista che proclama la santità celeste dell’anima oppure Freud che la diagnostica quale pura energia disponibile tanto all’eros quanto al thanatos – all’amore e alla morte? Né va posto a tacere la questione del silenzio di Dio, di quel Dio dei filosofi e dei teologi dell’onnipotenza. Come è stato giustamente detto, con la Shoah accade qualcosa di profondo: muore il Dio morale, il Dio che fonda la morale nella paura. È un Dio senz’altro lontano dal Vangelo, ma è quel Dio largamente diffuso nel tempo dopo il Concilio di Trento. Anzi già dal tempo della grande peste del XIV. Quale paura potrà più evocare il Dio che non ha fermato la mano di Mussolini e quella di Hitler? Per questo oggi più nessuno si sente in colpa per non essere un credente praticante o per non essere andato a Messa la domenica… e cambia pure la concezione del peccato.
4) Tutto questo cammino si concretizza e si diffonde su larga scala nella rivoluzione culturale del Sessantotto. Cosa succede con e nel Sessantotto? È il tempo in cui si compiono le profezie di Nietzsche. Lui sapeva di venir in anticipo rispetto al proprio tempo ed è esattamente nell’anno della rivoluzione del maggio francese che le sue istanze diventano pane quotidiano del cittadino medio occidentale. Parliamo dell’istanza della singolarità, dell’unicità, della corporeità, della musica orgiastica, della scelta, dell’autonomia del soggetto. “Vietato vietare”: ecco lo slogan del ’68, con il quale si attacca la tradizione culturale e morale del passato, giudicata eccessivamente irrispettosa della singolarità di ciascuno. “Ognuno è per sé”. Qui saltano in aria le forme di vita (matrimonio, paternità, maternità), i ritmi di vita (adolescenza, giovinezza, maturità), i mestieri. E cosa non dire dell’emancipazione sessuale e sociale della donna? “La” pillola ha cambiato alchimie psichiche che andavano avanti da migliaia di secoli! La forza deflagrante di questa invenzione era stata preparata anche dal voto dato alle donne nel 1946 e poi dall’obbligatorietà della scuola media, nel 1957. Potere politico, potere culturale, potere fisico e infine sempre di più potere economico, con l’autonomia dai soldi del marito che il lavoro consente alle donne: si rompe un archetipo mascolino potente (gli stivali ormai li portano solo le donne e le forze dell’ordine).
Più in generale, ancora, in modo indiretto, riconosciamo nel ’68 un attacco a un altro grande pilastro della tradizione cristiana e della tradizione occidentale, quello costituito dal pensiero di Sant’Agostino, che aveva invitato l’uomo a leggere la sua vita all’interno di un generale quadro di tipo provvidenziale, nel quale la lotta contro il peccato e il male passava nel cuore di ogni uomo, che doveva essere ben disposto ad accogliere anche la parola e la realtà del sacrificio/rinuncia in vista della città di Dio, del paradiso. Grande parola chiave della descrizione occidentale del mondo, fino a quanto è rimasto un luogo della terra povero (anni ’60, boom economico).
Ora, al posto di Agostino, arriva John Lennon che invita a una forma di immaginazione diversa, a una descrizione diversa del mondo: Imagine. Sì, immagina che non ci sia il paradiso, se stai cercando la felicità, la vita buona. Si compie qui un salto dimensionale forte nell’immaginario diffuso: dopo due millenni vissuti all’ombra della cacciata dal paradiso, si assiste ora alla cacciata del paradiso! E non è un caso che nel 1969 l’uomo arrivi sulla luna e possa fissare dall’alto dei cieli il suo mondo! (E non è ancora un caso che con la musica pop nascano le discoteche: straordinari laboratori ove si può sperimentare l’evoluzione umana: sei milioni di anni per passare dalle scimmie all’uomo, un quarto d’ora di musica assordante per fare il viaggio al contrario dall’uomo alle scimmie…).
5) L’ultima tappa del viaggio che ha deciso la ristrutturazione dell’immaginario attuale diffuso riguarda la crisi dell’autorità, della legge, della forza degli istituti giuridici a plasmare la vita della città. La coscienza tradizionale è stata profondamente influenzata dal diritto romano: cioè dal riconoscimento del vincolo della legge quale garanzia assoluta di una convivenza pacifica. Ebbene, nella fatica dell’elaborazione del lutto della seconda guerra mondiale (dove era più l’autorità della forza che non la forza dell’autorità), nella lotta contro il terrorismo, nel crollo del muro di Berlino, accaduto nel novembre del 1989, negli scandali finanziari di Mani pulite, nel crollo delle Torre Gemelli, nella recente mescolanza delle religioni e delle culture, nella rapida globalizzazione dell’economia, ha luogo una decisa svolta contro la forza dell’autorità.
Quale legge può salvarci? Quale polizia può difenderci? Quale politica per questo scenario? Quale futuro per questa economia? Che senso avrà mai l’autorità?
Il punto di sintesi è che nessuno oggi può avallare le sue idee semplicemente invocando il ruolo che riveste. È la sottrazione del carattere performante alla parola dell’autorità. Al posto dell’autorità sorge il tema della convinzione e la forma elementare della convivenza è quella della democrazia, cioè della libera determinazione del singolo. Ed ovviamente i mass media di nuova generazione esaltano questo elemento della singolarità, della soggettività: I-phone, I-pad, I-pod, ecc. Eccoci allora al nostro oggi, al nostro tempo, le cui parole chiave sono la finitezza, l’alterità, il pluralismo, la tolleranza, il sentimento, la tecnica, la salute, il cambiamento, l’aggiornamento, la corporeità, la donna, il consumo, il benessere, la giovinezza, la longevità, la singolarità, la sessualità, la democrazia, la convinzione, la comunicazione, la partecipazione… mentre tutto ciò che sa di eternità, paradiso, scomunica, natura, legge naturale, fissità, maturità, adultità, spirito, morte, mascolinità, sobrietà, povertà, sacrificio, autorità, diritto, tradizione: ecco, tutto questo passa in secondo piano… (come amo dire ironicamente oggi l’unica e ultima esperienza possibile di eternità è quella dell’accensione di un mutuo: un mutuo – come un diamante – è davvero per sempre…).
E la sfida per tutti è la seguente: come reggere ad un tale capovolgimento, a questo nuovo immaginario, a questa inedita scala di valori, che così all’improvviso ci si è imposta e che di continuo ci toglie il respiro ad ogni ora del giorno e della notte?
2. Secondo passaggio: che cosa ci contraddistingue
Da un punto di vista generale, non stupisce affatto che quasi nessuno oggi riesca ad essere all’altezza del nuovo scenario umano in cui ci troviamo a vivere. Ed è proprio questa situazione ciò che dobbiamo registrare come “sintomo” caratteristico dell’umanità attuale: il sintomo/carattere di una diffusa “immaturità” ovvero di un giovanilismo diffuso, di una fatica incredibile a diventare adulti, maturi; insomma, la sindrome di Peter Pan[4]. Ed è malattia che ha aggredito soprattutto la generazione degli adulti, quelli nati grosso modo tra il 1946 e il 1964 e che hanno vissuto pienamente il Sessantotto. Tramite loro, la malattia dell’immaturità e del giovanilismo ha letteralmente inquinato l’aria che respiriamo; ed è questa malattia che ci sottrae a volte la forza di sperare, di guardare con fiducia al futuro del nostro mondo; è per questa malattia che ci vogliono oggi “uomini e donne di profezia”: a causa di questa malattia gli adulti in particolare stanno perdendo la loro originaria vocazione e forza generativa ed educativa, non riuscendo più ad educare e a trasmettere la fede. E si rendono conto, giorno dopo giorno, che stanno lasciando una società parecchio guastata ai pochi figli quasi per nulla preparati ad essa.
Ma che cosa è questa malattia dell’immaturità, questa sindrome di Peter Pan, questa fatica di essere adulti? Facciamoci aiutare da Francesco Stoppa, che usa un linguaggio più immediato e offre analisi di grande profondità. Interrogandosi sull’identità della generazione adulta (quella nata tra il 1946 e il 1964), Stoppa avverte che «La specificità di questa generazione è che i suoi membri, pur divenuti adulti o già anziani, padri o madri, conservano in se stessi, incorporato, il significante giovane. Giovani come sono stati loro, nessuno potrà più esserlo – questo pensano. E ciò li induce a non cedere nulla al tempo, al corpo che invecchia, a chi è arrivato dopo ed è lui, ora, il giovane»[5]. Per questo è alla fine dei conti una generazione che ama più la giovinezza che i giovani. Innestando così elementi di concorrenza intergenerazionale al posto dei salutari conflitti intergenerazionali.
Il contenuto di questo ideale di giovinezza nulla ha a che fare con ciò che normalmente si intende con “spirito della giovinezza” o “giovinezza dello spirito”. La giovinezza come ideale è qui intesa piuttosto come grande salute, performance, libertà sempre negoziabile, via sicura per l’affermazione della propria sessualità, del proprio successo, del proprio fascino, disponibilità ininterrotta a “fare esperienze”, a completarsi e a rinnovarsi. Giovinezza è viagra! (Scusate la rudezza).
Va da sé che qui non esiste più alcuno spazio per il lato etico-morale, educativo, specificante l’età adulta: definitività delle scelte lavorative ed affettive, anche quando non sono più all’altezza delle promesse che avevano lasciato intravedere all’inizio; responsabilità generativa ed educativa, che comporta quel costante oblio di sé a favore di altri; impegno appassionato per un’accurata e costante manutenzione dello spazio politico, condizione essenziale per la realizzazione del bene dei figli; e da ultimo consumazione del lutto con la presa di coscienza del proprio inevitabile destino mortale, con tutto il carico di lavoro su di sé che questa crisi comporta e che apre lo spazio per il passaggio del testimone (gli Dei greci immortali normalmente mangiano i figli…). Per questo l’orizzonte di riferimento degli adulti attuali – annota Marcel Gauchet – è quello di «essere il meno adulti possibile, nel senso peggiorativo acquisito dal termine, sfruttarne i vantaggi aggirandone gli inconvenienti, mantenere una distanza rispetto agli impegni e ai ruoli imposti, conservare il più possibile delle riserve per altre possibili direzioni».
Quella degli adulti è perciò una generazione che ha fatto della giovinezza il suo bene supremo: si può dire per paradosso che è una generazione che ama la giovinezza più dei giovani. Più dei figli. Ed è a causa di questo amore al contrario che sta procedendo ad un inquinamento senza precedenti del nostro immaginario valoriale di base, dalla lingua che parliamo alla grammatica fondamentale dell’esistenza umana: la vecchiaia, la malattia, la fragilità umana, la morte e infine la stessa giovinezza. Con gravi ricadute nell’educativo. Vediamo.
A livello linguistico: se uno muore a 70 anni si dice che è morto giovane, se uno ha quarantacinque anni è ancora un ragazzo, un giovane: può aspettare perciò… In Chiesa abbiamo i giovani, i giovanissimi, i giovani adulti, gli adulti giovani, i diversamente giovani e gli adultissimi…
Per questo la vecchiaia è diventata oggi il nemico “numero uno” della nostra società: è parola eliminata da Wikipedia (chiedetevi semplicemente: quando diventerò vecchio? Cioè a quale età dichiarerò di essere vecchio?), nulla si vende che non sia “anti-age”, è l’ultima e imperdonabile offesa che si possa rivolgere ad un essere umano, è il tallone d’Achille su cui mortalmente ci ferisce la pubblicità e il sistema economico capitalistico (“a tutto possiamo resistere, tranne a ciò che ci aiuta a lottare contro la vecchiaia”). A questo proposito è importante tenere conto della straordinaria capacità del mercato di inserirsi brillantemente in questi processi di riscrittura della qualità adulta dell’umano: adulti che non vogliono smettere di fare i giovani sono perfettamente adesivi al sistema economico imperante, che ha sempre bisogno di elargire soddisfazioni “a termine” e quindi di alimentare l’insoddisfazione dei consumatori. Un consumatore soddisfatto è l’incubo del mercato. Il mito della giovinezza va a braccetto con questo sistema: esiste qualcosa di più irraggiungibile della giovinezza? No, ma se tu pensi che sia possibile (ed è questo che induce a credere il mercato) allora inizi a spendere e paradossalmente più la insegui, più ti sfugge, la giovinezza. Ma non importa. L’importante è spendere.
Oltre che con la vecchiaia, cambia il nostro rapporto con la medicina (e quindi con la fragilità umana): non è più un sintomo, un messaggio da parte del corpo (stai facendo troppo, corri di meno, mangia meglio, dormi di più, smetti di fumare), ma è intesa come un’interruzione, un blocco di motore, che basta rimuovere per ripartire. E abbiamo medicine sempre più potenti. E la pubblicità ci raccomanda di non leggere le avvertenze (negli spot pubblicitari questo passaggio è sempre velocissimo).
Un discorso simile vale per la morte: essa ha subìto un incredibile esorcismo linguistico che l’ha fatta sparire anche dai manifesti funebri: in Italia, la gente scompare, viene a mancare, compie un transito, si spegne, si ricongiunge, si addormenta, va qui, va là, addirittura è rapita, convocata, chiamata in cielo… Nessuno che semplicemente muoia!
Cambia il rapporto con la giovinezza e con i giovani “anagrafici”, con i figli: la giovinezza non è più un periodo preciso della vita, è il senso della vita. Per questo essa non indica semplicemente una stagione particolare dell’esistenza, irripetibile e specificatamente destinata ad apportare un importante contributo al rinnovamento e ringiovanimento della società. La giovinezza è il senso della vita. Essa non può finire, non deve finire. Chi la possiede, nulla gli manca. Tutti abbiamo diritto alla giovinezza. Ma in un mondo in cui tutti hanno diritto alla giovinezza, nessuno può essere più giovane degli altri! E il risultato, qual è? Che la nostra società pensa di non aver bisogno dei giovani, che può farcela anche senza di loro, che non siano necessari. Ma soprattutto questo comporta il venir meno del ruolo educativo connesso all’essere adulto.
Nell’ oggi della storia alla fine dei conti non riusciamo più né ad educare né a trasmettere la fede: che senso avrebbe infatti educare i giovani, quando per noi il massimo della vita e la vita al massimo è la giovinezza, di cui loro sono titolari? Verso quale luogo (e-ducare significa portare fuori) dovremmo portare i giovani se per noi la giovinezza è il paradiso? L’educazione finisce quando l’adulto interpreta la propria vita non come cammino in avanti, ma come goffo tentativo di tornare indietro. E poi la fede. La fede è una questione degli occhi. Ebbene che cosa vedono i nostri giovani e i nostri ragazzi davanti a loro? Adulti che pregano? (Nemmeno il don Matteo della tv prega! Restano solo le suore a farlo, per fortuna). Adulti che leggono il Vangelo? Adulti che orientano la loro esistenza secondo Gesù? Adulti felici di essere cristiani? Vedono solo adulti disperati di non essere più giovani…adulti malati di immaturità…
Questo è a mio avviso il punto decisivo e critico dell’oggi della storia. E c’è da sottolineare ancora che il potere forte di questo nostro tempo – il potere dei poteri: il mercato – vuole a tutti i costi mantenere una tale situazione di immaturità: vuole cioè degli eterni giovani, cui far da guida verso la “felicità”.
3. Terzo passaggio: la profezia della donna consacrata
Alla luce del percorso che ho proposto a me pare che siano tre gli ambiti più attuali, più necessari, più consonati, più richiesti della profezia della donna consacrata oggi:
– la benedizione del contingente
– la grazia della preghiera
– la mistica della comunità.
a) benedizione della contingenza
Oggi non si crede più al paradiso e nello stesso tempo abbiamo una vita lunghissima. Per questo viviamo tutti uno strano pathos dell’infinito: si vuole tutto e il contrario di tutto, mentre la vita si disperde. Senza la misura del Paradiso, è come se avessimo perso la misura del finito, del mondo, della sua contingenza, della sua ricchezza e pure della sua limitatezza. Come dice un famoso comico, dobbiamo erigere un monumento al “limite ignoto”.
Da questo punto di vista rilanciare il carattere benedicente della vita consacrata mi pare di grande forza: una benedizione che nasce dal discernimento tra ciò che facilita la vita – personale e comunitaria – e ciò che la ostacola, tra ciò che la rende scialba e ciò che la arricchisce, tra ciò che l’abbassa e ciò che la eleva, tra ciò che la manda in frantumi e ciò che la tiene in sé, la contiene, la rende una vita contenta; infine tra ciò che permette di vedere giorni felici e ciò che lo impedisce. Avendo fissi gli occhi sulla verità che questo mondo non è il paradiso e che tuttavia il paradiso viene dopo questo mondo. In questo sono soprattutto gli adulti ad aver bisogno di aiuto: cercano sempre altra vita, altra giovinezza, dobbiamo convincerli che in verità l’uomo è fatto anche per una vita altra, per una giovinezza altra. E che quindi invecchiare non è la cosa peggiore che ci possa capitare.
b) la grazia della preghiera
Se non ci convinciamo che oggi la gente non solo non conosce più le preghiere (del tipo: “il Corpo di Cristo”, “Grazie”; del tipo: funerali e matrimoni celebrati senza che nessuno risponda alle parole del sacerdote; ecc.), ma più radicalmente ha perso il senso stesso della preghiera, del pregare, perdiamo un’occasione preziosa di profezia.
La preghiera oggi come non mai ci è necessaria. “Chi prega ha le mani sul proprio portafoglio”, si libera cioè dalle sirene della pubblicità, del mercato e per questo vogliono spegnere la domenica. Che belle le parole del prefazio comune IV: “Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie; i nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva, per Cristo nostro Signore”.
Sì, la preghiera ci dona la grazia di poterci riconciliare con noi stessi, ponendoci di fronte all’istanza misericordiosa di Dio che Gesù ci ha manifestato con la sua croce gloriosa. La preghiera ci dona la grazia di sfondare la cappa soffocante delle nostre preoccupazioni e idiosincrasie, lasciandoci inondare dal soffio dello Spirito Santo. La preghiera ci dona la grazia di rimettere la nostra causa e la nostra fatica, il nostro patire e il nostro lottare alla speranza del futuro, alla promessa del paradiso abbandonandoci alle mani fedeli e giuste del Padre.
Dobbiamo perciò preoccuparci molto di iniziare o meglio re-iniziare alla preghiera, alla preghiera personale, alla preghiera quotidiana, alla preghiera degli adulti e alla preghiera dei giovani.
Qui mi piace ricordare un passaggio dell’Evangelii gaudium in cui Papa Francesco parlando dell’evangelizzazione delle città afferma la necessità «di immaginare spazi di preghiera e di comunione con caratteristiche innovative, più attraenti e significative per le popolazioni urbane» (75). E questo vale anche per le donne di oggi che hanno un’elevata cultura delle donne e chiedono nuovi spazi di preghiera e di comunione…
c) la mistica della comunità
Quest’ultima forma di profezia è particolarmente urgente. Oggi ci manca la comunità, quel ponte, quello spazio “terzo” tra famiglie e corpo sociale, tra famiglie troppo calde e corpo sociale troppo freddo. Ognuno pensa che il mondo coincida con i limiti del proprio io o al massimo si estenda a quelli della sua tribù; ed accade che la società sia sempre di più in mano alla burocrazia e al mercato. Il Papa dice che ci vuole una mistica dell’incontro, della comunità. Lo cito: «Oggi, quando le reti e gli strumenti della comunicazione umana hanno raggiunto sviluppi inauditi, sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la “mistica” di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po’ caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio. In questo modo, le maggiori possibilità di comunicazione si tradurranno in maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti. Se potessimo seguire questa strada, sarebbe una cosa tanto buona, tanto risanatrice, tanto liberatrice, tanto generatrice di speranza! Uscire da se stessi per unirsi agli altri fa bene. Chiudersi in sé stessi significa assaggiare l’amaro veleno dell’immanenza, e l’umanità avrà la peggio in ogni scelta egoistica che facciamo» (Evangelii gaudium 87).
Piccolo commento: abbiamo da una parte maggiori mezzi di comunicazione eppure la sfida resta, dall’altra, sempre quella di fare il primo passo, di uscire da sé, di superare la logica dell’individualismo, del narcisismo, della sirena pubblicitaria che vorrebbe convincerci che il mondo è tutto attorno a noi e che siamo destinati a essere solo e sempre noi stessi. Urge, dice papa Francesco, un salto, un passo non calcolato, un caparra di fiducia, un’intuizione anticipatrice, una visione da lontano, una prospettiva non meramente calcolante: un atteggiamento mistico. Ed è proprio questo che suggerisce il numero 93 che chiude la sezione dedicata al Sì alle nuove relazioni generate da Gesù Cristo!, di cui il numero precedentemente citato rappresenta l’inizio: «Lì sta la vera guarigione, dal momento che il modo di relazionarci con gli altri che realmente ci risana invece di farci ammalare, è una fraternità mistica, contemplativa, che sa guardare alla grandezza sacra del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano, che sa sopportare le molestie del vivere insieme aggrappandosi all’amore di Dio, che sa aprire il cuore all’amore divino per cercare la felicità degli altri come la cerca il loro Padre buono. Proprio in questa epoca, e anche là dove sono un “piccolo gregge” (Lc 12,32), i discepoli del Signore sono chiamati a vivere come comunità che sia sale della terra e luce del mondo (cfr Mt 5,13-16). Sono chiamati a dare testimonianza di una appartenenza evangelizzatrice in maniera sempre nuova. Non lasciamoci rubare la comunità!».
Il compito che qui papa Francesco assegna alla sua Chiesa è quello di una testimonianza possibile della comunità: che sia cioè visibile un luogo ove ci si sottragga alle sirene continue del mercato e allo stile freddo delle istituzioni pubbliche dissanguate non solo economicamente ma ancora di più di senso e di profilo umano; un luogo dunque di comunione, di condivisione, di partecipazione, di comunicazione, di ospitalità reciproca, nel segno dell’amore e del riconoscimento della pari dignità di ognuno e di ognuna. In questo può ancora una volta rendersi presente il Signore Gesù. Dovremmo a mio avviso scommettere di più sulla costruzione di comunità vere, vivibili e visibili, nelle quali sia possibile ospitare la diversità, far dialogare le generazioni, celebrare la vita in tutte le sue fasi e le sue età, permettere la riconciliazione e il lutto con il lato sfidante dell’esistenza umana, abilitare ciascuno al rito prezioso della benedizione come gesto elementare con il quale farsi innanzi alla vita che è sempre e comunque sorprendente.
La vita consacrata, quella femminile in particolare, mi pare sia la punta di diamante in questa direzione: tocca a voi insegnare di nuovo alla Chiesa e al mondo che cosa vuol dire essere comunità!
La storia della fondazione delle vostre congregazioni ci insegna che le suore hanno capito per prime le esigenze del momento e sono fermamente convinto che anche in questo oggi della storia sarà così.
Don Armando Matteo
Docente di Teologia fondamentale
Pontificia Università Urbaniana
* Relazione tenuta alle sorelle che frequentano quest’anno il Trimestre sabbatico
all’USMI nazionale.
[1] U. Galimberti, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, Feltrinelli, Milano 2007, 15.
[2] Aldo Schiavone ha scritto in modo calzante che «oggi basta avere almeno quarant’anni per percepire la sensazione di distacchi epocali da interi mondi di abitudini e di comportamenti perduti, e che si stanno completamente dimenticando» (Storia e destino, Einaudi, Torino 2007, 52).
[3] M. Aime-G. Pietropolli Charmet, La fatica di diventare grandi, Einaudi, Torino 2014, 36.
[4] Cfr. F. Cataluccio, Immaturità. La malattia del nostro tempo, Einaudi, Torino 20142; G. Cucci, La crisi dell’adulto. La sindrome di Peter Pan, Cittadella 2012; M. Recalcati, Il complesso di Telemaco. Genitori e figli dopo il tramonto del padre, Feltrinelli Milano 2013. L’analisi qui presentata dipende molto dai saggi, citati oltre, di Francesco Stoppa e di Marcel Gauchet.
[5] F. Stoppa, La restituzione. Perché si è rotto il patto tra le generazioni, Feltrinelli, Milano 2011, 9-10.
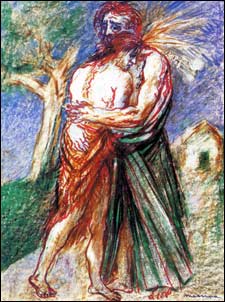 1. Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il mistero della fede cristiana sembra trovare in questa parola la sua sintesi. Essa è divenuta viva, visibile e ha raggiunto il suo culmine in Gesù di Nazareth. Il Padre, « ricco di misericordia » (Ef 2,4), dopo aver rivelato il suo nome a Mosè come « Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà » (Es 34,6), non ha cessato di far conoscere in vari modi e in tanti momenti della storia la sua natura divina. Nella « pienezza del tempo » (Gal 4,4), quando tutto era disposto secondo il suo piano di salvezza, Egli mandò suo Figlio nato dalla Vergine Maria per rivelare a noi in modo definitivo il suo amore. Chi vede Lui vede il Padre (cfrGv 14,9). Gesù di Nazareth con la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua persona rivela la misericordia di Dio.
1. Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il mistero della fede cristiana sembra trovare in questa parola la sua sintesi. Essa è divenuta viva, visibile e ha raggiunto il suo culmine in Gesù di Nazareth. Il Padre, « ricco di misericordia » (Ef 2,4), dopo aver rivelato il suo nome a Mosè come « Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà » (Es 34,6), non ha cessato di far conoscere in vari modi e in tanti momenti della storia la sua natura divina. Nella « pienezza del tempo » (Gal 4,4), quando tutto era disposto secondo il suo piano di salvezza, Egli mandò suo Figlio nato dalla Vergine Maria per rivelare a noi in modo definitivo il suo amore. Chi vede Lui vede il Padre (cfrGv 14,9). Gesù di Nazareth con la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua persona rivela la misericordia di Dio.