Dal Vangelo di Giovanni 1,1-18
 In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.
……………………………………………
Nel giorno di Natale ci viene proposto il prologo di Giovanni, il testo che più di tutti parla della preesistenza del Figlio presso il Padre al principio di ogni cosa. Giovanni nel redigere questo inno fa una sintesi tra la cultura greca, in cui vive, e quella ebraica, in cui si è svolta l’esistenza terrena di Cristo. Nell’inno infatti si parla del Logos, la Parola (che in italiano troviamo tradotto con Verbo), che nella cultura ellenistica di tipo stoico era la “ragione immanente al mondo”, che assicurava la coesione dell’universo e lo compenetrava nei suoi diversi aspetti. I testi biblici che sono stati modello del nostro inno sono invece Siracide 24 e Proverbi 8, che parlano della Sapienza personificata e della sua discesa dal cielo verso la terra. Lectio In principio era il Verbo, Giovanni per parlarci delle origini di Colui nel quale la comunità cristiana ha posto la propria fede, risale oltre gli antenati per fissarsi sull’inizio dell’universo. Giovanni ci porta alle soglie della storia, fin nelle profondità di Dio. Il principio di cui si parla in questo primo versetto è quello della Genesi “In principio Dio creò il cielo e la terra” (Gn 1,1). Ma qui non si parla di un’azione, ma di una esistenza che precede questo inizio. C’era il Logos. Non è stato creato, egli è al principio in modo assoluto. Non può essere catalogato tra le creature. e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Il Verbo è qualcuno di distinto da Dio, però è vicino a Dio. Al tempo stesso il Verbo è Dio, ma nell’originale greco in questa seconda parte della frase il termine Dio non ha l’articolo, quindi ci fa capire che il Verbo è Dio, ma in modo diverso da Dio.
Vi è una relazione tra queste due persone che non si può ancora chiamare Padre-Figlio (ciò avverrà solo con l’incarnazione). E’ una relazione dinamica in espansione. Solo la relazione caratterizza l’essere divino nella sua profondità. Egli era, in principio, presso Dio: Abbiamo dunque una prima localizzazione del Verbo. Egli stava sin dal principio presso Dio. E’ la Parola di Dio, un Dio che vuole dare una comunicazione all’esterno di se stesso. Dio non è mai stato senza Parola, senza la possibilità di comunicare se stesso. Ancora, il Logos è il modello di tutto ciò che verrà creato mediante la Parola. Accogliere il Logos significa disporsi, mediante lui, a esistere con Dio. All’inizio quindi vi è il mistero di Dio che risplende mediante il suo Logos e che pone ogni essere in dialogo con lui. Tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. Questa frase completa la presentazione iniziale del Logos: pur essendo essenzialmente “presso Dio” in quanto parola è rivolto al “di fuori” di Dio, verso l’interlocutore, verso ciò che sta per essere chiamato all’essere “in principio”, verso lo sbocciare della creazione. Il Padre resta l’autore della creazione, ma ha creato tutto con la mediazione del Verbo. Nulla ha ricevuto l’esistenza se non mediante la presenza attiva del Logos. Quel tutto che è stato creato è la traduzione di panta, non solo il cosmo nel suo complesso, ma ogni singolo essere nella sua individualità e nella sua storia. La creazione però è una realtà dinamica, non è un atto originario limitato nel tempo, si rinnova continuamente. La Parola di Dio è presente e attiva lungo tutta la storia, con rivelazioni progressive del suo disegno e del suo ministero. La storia è dunque in cammino verso la salvezza definitiva ed è mediante il Logos che accade ogni evento. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; il Logos viene presentato ora come dono della vita. Si tratta dell’esistenza suscitata al momento della creazione, ma anche la partecipazione alla vita divina del Logos. Solo Dio è il vivente per eccellenza (cf. Sal 36,10) e tutto ciò che esiste è legato al suo soffio (Sal 104,28ss). Di conseguenza la vita che Dio ha suscitato per poter mantenersi deve rimanere senza interruzione in contatto con Dio, la sua sorgente. La vita implica anche una finalità da raggiungere, quel pieno sviluppo che corrisponderà al progetto di Dio sull’uomo. L’uomo è invitato a vivere fin da questa terra in accordo profondo, in comunione con Dio stesso. Però questo scopo non è raggiunto automaticamente: ci vuole la fede, che suscita un comportamento di giustizia e fedeltà basato sui valori che Dio propone. C’è un dialogo tra uomo e Dio fin dal principio, la dialettica dell’alleanza. La parola vita riguarda dunque l’esistenza, ma anche la relazione vivente, esistenziale con Dio stesso attraverso il Logos. Vi è dunque una vita che non è ancora assunta in pienezza, e che si sviluppa nella relazione con Dio. A tale riguardo il Logos-luce interviene per indicare all’uomo la via da percorrere, per crescere sempre più nella relazione con Dio. Questa luce riguarda valori essenziali di salvezza e anche un comportamento morale. Ciò era espresso anche nel libro della Sapienza: la Sapienza è detta riflesso della luce eterna (Sap 7,26). Gesù stesso nel vangelo di Giovanni si definirà in questi termini: “Io sono la luce del mondo chi segue me… avrà la luce della vita (Gv 8,12)”. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. Troviamo qui una coppia di nomi molto usata nella Bibbia: luce e tenebre. Ma le tenebre non sono preesistenti alla luce. Qui per tenebre dobbiamo intendere il caos, il non-essere presente prima della creazione. Su questo caos ha vinto la luce. Dopo il peccato originale però la tenebra è divenuta una potenza in azione, la possibilità di dire di no. Ecco che la luce risplende nelle tenebre e le tenebre non possono vincerla, come Gesù è sceso nel regno dei morti e non è stato vinto dalla morte. Chi rifiuta la parola di Gesù rimane nelle tenebre, resta cieco senza saperlo (Gv 9,39). Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Il discorso viene bruscamente interrotto da un nuovo personaggio: Giovanni il Battista. Si stava parlando della luce che non è stata vinta dalle tenebre. Non è stata una vittoria automatica. Il Dio di Israele, abituato a trovarsi sempre in giudizio con il suo popolo, ci tiene a portare a processo i suoi testimoni. Quindi anche qui nel prologo compare un personaggio che è chiamato a essere testimone del Logos presente nel mondo. Il testimone è “mandato da presso Dio”, dignità che il IV vangelo riserva solo a Gesù di Nazaret e al Paraclito. Questa qualifica rievoca le vocazioni dei profeti come Mosè, Isaia, Geremia, o il profeta atteso annunciato da Malachia (Ml 3,1.23). Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Un uomo di questo mondo viene dunque incaricato di proclamare agli uomini la presenza della luce del Logos, affinché gli uomini la riconoscano. La finalità di questa testimonianza è che tutti credano. Tutti devono riconoscere la luce che il Logos irradia nel mondo, la luce di vita. Cosa si intende per tutti? Il contesto universalistico in cui è immersa la prima parte del prologo invita a comprendere in questa parola non solo i contemporanei di Giovanni, ma gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa precisazione può rivelare la presenza di qualche polemica all’interno della comunità cristiana. Forse i seguaci di Giovanni affermavano fosse lui il vero Messia, quindi l’evangelista delimita la missione di Giovanni pur esprimendo per lui grande stima. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Il discorso ritorna sul Logos e si focalizza sul suo incontro con l’umanità. Il Logos qui è ricordato come “luce autentica”, in contrapposizione con le false luci che sarebbero apparse nel mondo, che non sono altro che ingannevoli idoli. Solo il Dio vivente è veritiero. Nella Bibbia si può leggere il desiderio della luce divina, ad es. Sal 4,7; 119,105; Is 9,1. Anche la Sapienza istruisce da sempre ogni uomo, rivela i misteri divini, ispira i saggi e i giusti donando loro il discernimento della volontà di Dio. Il Logos dunque illumina ogni uomo, ciascun uomo nella sua singolarità. Egli viene incontro a ciascun uomo, di ogni generazione, anche a quanti non appartengono al popolo di Dio (cf. Rm 1,19-21). Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Qual è stata la risposta del mondo davanti alla luce vera? Sebbene il mondo fosse stato creato per mezzo di lui, anche se gli uomini e le creature fossero in rapporto vitale con il loro Creatore, ebbene il mondo, le creature non hanno riconosciuto la luce che veniva a loro. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. Questo versetto precisa ancora meglio questo rifiuto: il Logos veniva nella sua “proprietà”, presso il popolo con cui aveva una relazione particolare. Qui ci sarebbe un riferimento a Israele. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome. C’è qualcuno però che ha accolto il Logos, la Parola di Dio. Sono gli uomini che hanno riconosciuto nel Logos il principio della loro esistenza e nelle sue promesse di vita il senso della loro storia: essi si lasciano illuminare da lui. Questa accoglienza è possibile a tutti. Il risultato dell’accoglienza è la fede nel “nome”. Il nome di Gesù Cristo, ma anche il nome di Dio, JHWH. A coloro che lo hanno accolto, il Logos ha dato il potere di divenire figli di Dio. C’è un dono che essi ricevono dal Logos, il potere, cioè la dignità, l’autorità di essere figli di Dio. Essere figlio di Dio indica un’appartenenza profonda a Dio, una vera salvezza vissuta nel presente, anche senza aver ancora la pienezza di grazia che annuncerà il v. 16. I quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Coloro che hanno accolto il Logos quindi diventano figli di Dio, non appartengono più a un popolo particolare, non vengono più generati per il desiderio della sopravvivenza, ma provengono da Dio. La loro illuminazione coincide con il loro diventare figli di Dio. E il Verbo si fece carne. Questo versetto dà senso a tutto l’inno e ci introduce all’incarnazione del Logos, ultima tappa della storia di Dio che si comunica. Vi è una modifica nel modo della presenza e della manifestazione del Verbo. Il testo utilizza la parola carne invece che uomo, forse per non metterlo sullo stesso piano di Giovanni. Oppure si tratta di indicare in modo più incisivo la condizione nuova del Logos divenuto uomo. Il termine carne indica la condizione di fragilità, di miseria e di precarietà dell’essere umano. Forse qui indica già la morte con cui Gesù salverà il mondo. E venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, Letteralmente le parole greche sarebbero “e drizzò la propria tenda in mezzo a noi”. Questo dimorare è ricco di significato: si fa riferimento alla tenda del santuario portatile di JHWH nel cammino dell’esodo. Il Dio che si rendeva presente nell’arca dell’alleanza, cioè nella legge, ora si rende presente in una carne mortale. E’ una presenza che non riguarda solo Israele, ma “noi”, cioè ogni uomo. Così “noi” abbiamo potuto vedere la gloria del Logos. Questo noi indica soprattutto i testimoni della vita di Gesù di Nazaret, ma anche tutti coloro che nella fede si lasciano illuminare dalla luce del Logos. Nel Vangelo di Giovanni la gloria di Cristo si manifesta soprattutto nei segni (cf. Cana, Gv 2,11). Gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Si tratta di una gloria particolare, poiché il Figlio è unigenito, è unico e irripetibile. Egli è veramente generato dal Padre e pertanto egli è la gloria del Padre. Il Logos si è incarnato: a partire da questo versetto Dio non viene più definito Dio, ma Padre. Il Figlio è uscito dal Padre affinché in Lui risplenda la gloria del Padre stesso. Il Logos incarnato poi è “riempito” di grazia e di verità. La grazia è il dono divino, la sua benevolenza, il suo favore (cf Rm 5,15). La verità si può intendere qui come la conoscenza di Dio. Il Logos può quindi comunicare la verità del Padre. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: “Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me”. Giovanni dava testimonianza alla luce, ora ripete la sua testimonianza riguardo il Logos incarnato. Gesù è al di sopra di Giovanni. Questo verrà ripetuto nel prologo narrativo del IV Vangelo (Gv 1,27). Già prima di incontrarlo Giovanni conosceva la superiorità di Colui che sarebbe venuto e si sentiva indegno di essere suo schiavo.
Questa testimonianza di Giovanni non è stata fatta una volta per tutte, essa continua nel tempo. la sua parola si fa garante di una realtà che deve essere sempre nuovamente riconosciuta. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Ora la parola torna ai credenti, non solo i testimoni diretti, ma la comunità dei discepoli che si sono moltiplicati. Noi abbiamo ricevuto, partecipiamo alla pienezza di Lui, alla pienezza di grazia propria dell’Unigenito di Dio. L’espressione “grazia su grazia” significherebbe una grazia che si sovrappone a un’altra. La prima grazia sarebbe la Legge ebraica, sulla quale si è posta la legge di Gesù che la porta a compimento. Ma per non restringere troppo il senso di questa affermazione, potremmo pensare alla prima grazia come quella della presenza universale del Logos non incarnato; la seconda è il dono della verità mediante l’incarnazione di Gesù Cristo. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Questo versetto presenta il superamento della legge di Mosè e dell’esperienza di Israele. Vi è un parallelismo tra Mosè e Gesù. Secondo la costruzione della frase in greco alla legge corrisponde la verità e al verbo “fu data” corrisponde la grazia. Al dono della legge corrisponde il dono della verità in Gesù Cristo. Tra i due membri della frase non vi è opposizione ma progressione e la progressione va dalla legge alla verità. Questa verità supera la legge che è soltanto una manifestazione incompleta, e rivela pienamente ciò che il Dio dell’Alleanza aveva voluto comunicare a Israele fin dalla sua elezione. Non vi è dunque contrapposizione tra Antico e Nuovo Testamento. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. Al termine del poema Giovanni risale con uno slancio in verticale a colui presso il quale era il Logos: Dio in senso assoluto. Vi è un collegamento tra vedere/rivelare. Vedere Dio è l’aspirazione più profonda del credente, secondo la Bibbia. Ma salvo eccezioni quest’aspirazione deve attendere il cielo per potersi realizzare. Per questo lungo i secoli è stato trasportato nel culto l’incontro con Dio. Nel tempio si poteva soddisfare simbolicamente il desiderio di accostarsi al Signore, di fare esperienza diretta del Dio vivente. Secondo la tradizione biblica l’uomo non può vedere Dio a causa della sua condizione di peccatore e perché Dio è assolutamente trascendente. Solo in Cristo la gloria di Dio si lascia vedere. Il Figlio unigenito ce lo ha raccontato (è questa una traduzione più incisiva di exegeomai). E’ una manifestazione che implica quindi un ascoltare e un obbedire, secondo la tradizione sapienziale. Un’esperienza che coinvolge molto più profondamente che il semplice vedere. Di fatto il Logos, la Parola va ascoltata. Egli ci spiega il Padre nei minimi particolari. Ecco cosa siamo chiamati ad ascoltare nella lettura del Vangelo di Giovanni.
Monastero Matris Domini
 In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo.
In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo.


 In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.
 Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa». Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa». Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.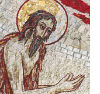


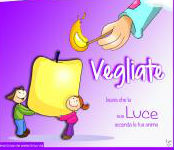 Dal vangelo secondo Marco Mc 13, 33-37
Dal vangelo secondo Marco Mc 13, 33-37 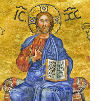
 Dal Vangelo di Matteo 25,31-46
Dal Vangelo di Matteo 25,31-46

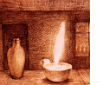
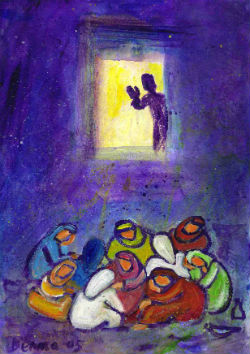 Dal Vangelo di Matteo 25, 1-13
Dal Vangelo di Matteo 25, 1-13
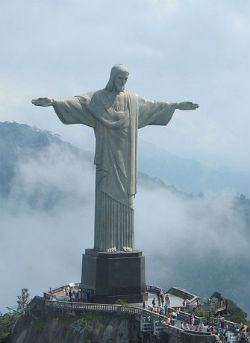 Da Vangelo di Matteo 23,1-12
Da Vangelo di Matteo 23,1-12
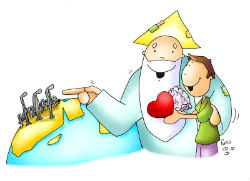 In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?». Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».
In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?». Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».