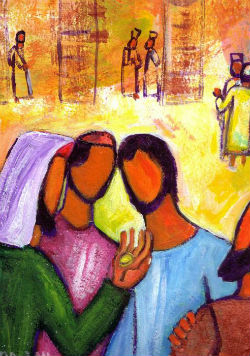 Dal Vangelo di Matteo, 22,15-21
Dal Vangelo di Matteo, 22,15-21
In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come coglierlo in fallo nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio».
………………………………………..
Matteo continua a raccontarci cosa sia avvenuto nell’ultima settimana che Gesù ha trascorso su questa terra. Dopo le tre parabole che egli aveva dedicato ai capi dei sacerdoti e agli anziani, vi sono tre dispute architettate per cogliere in fallo Gesù. La prima, quella di questa domenica (Mt 22,15-21) è escogitata dai farisei in collaborazione con gli erodiani, e riguarda il rapporto del credente con il potere civile (in quel caso addirittura il potere straniero che occupava Israele). La seconda, che la liturgia salta (Mt 22,23-33), riguarda la risurrezione dei morti ed è provocata dai sadducei. La terza vede un’altra volta i farisei salire sul ring per chiedere a Gesù quale sia il precetto più grande di tutta la Legge (Mt 22,34-40) e se ne parlerà domenica prossima.
In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Gesù è stato molto duro con i capi dei sacerdoti e gli anziani. Ha raccontato loro tre parabole il cui senso era quello del rifiuto e dell’indegnità del popolo di Israele. Qui si parla di farisei che se ne vanno. Si tratta certo dei sacerdoti che facevano parte di questo gruppo. Se ne vanno a complotto per cercare il modo di cogliere in fallo Gesù. L’espressione “tennero consiglio” (symboùlion) è il termine tecnico per indicare la convocazione del sinedrio, convocato dai sommi sacerdoti, di cui si parlerà più tardi nel corso del racconto della passione (Mt 27,1.7; 28,12). Matteo lo anticipa qui, per ricordarci che la condanna di Gesù era stata architettata già da tempo. L’espressione che troviamo “cogliere in fallo” letteralmente si traduce con “prendere al laccio con una parola”: è un semitismo molto espressivo che ci fa comprendere come possa bastare una parola sola per mettere nei guai una persona. Matteo usa questo termine solo in questa occasione. E’ evidente l’atteggiamento ostile dei farisei nei confronti di Gesù.
Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni a via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. I capi dei farisei non vanno direttamente da Gesù (ci andranno per la terza disputa, cf. Mt 22,34-40). Mandano i loro discepoli. Non solo: c’è anche la presenza degli erodiani. Questa si spiega con la natura della disputa. Erode era un collaborazionista del potere dei romani su Israele. Qualora Gesù avesse espresso delle parole di disapprovazione nei confronti dei romani e del loro pretendere delle imposte essi sarebbero stati i primi a denunciarlo presso gli occupanti come un sovversivo. Erodiani e farisei erano nemici: gli uni collaboravano con il potere dei romani, gli altri lo consideravano un castigo di Dio. Però quando si tratta di mettere in difficoltà Gesù si mettono d’accordo! Il preambolo della domanda è fin troppo adulatorio, sembra quasi una provocazione e di fatto ottiene da parte di Gesù delle parole di biasimo (“ipocriti”). Il dire “non guardi in faccia agli uomini” potrebbe sembrare un’istigazione a sfidare il potere di Cesare.
Dunque, dì a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». Il tributo di cui i farisei parlano era la tassa pro-capite imposta dai romani dopo l’occupazione della Palestina avvenuta nel 6 a.C. (il cui nome tecnico era census). Questo veniva richiesto a tutti gli abitanti della Giudea, Samaria e Idumea (uomini, donne, schiavi) dai dodici fino ai sessantacinque anni. Il Cesare di cui si parla è Tiberio Cesare, imperatore di Roma dal 14 al 37 d.C. Il tributo era di un denaro d’argento a testa, ossia la paga quotidiana di un bracciante. Il pagamento di questo tributo era una condizione essenziale per poter vivere in pace come sudditi dell’impero romano ed esercitare i diritti derivanti da questo stato.
Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Non c’è bisogno di avere la conoscenza del cuore umano che aveva Gesù per capire che quel lungo preambolo e la domanda che gli veniva posta non erano altro che tentativi cattivi di incastrarlo. Gesù sa bene che qualunque sua risposta diretta lo avrebbe messo in una posizione difficile. Se avesse detto che il tributo era lecito avrebbe avuto contro di sé gli zeloti e tutti coloro che mal sopportavano l’occupazione romana. Se avesse detto di no, gli erodiani lo avrebbero denunciato ai romani. Quindi è legittima la sua protesta: perché mi tentate, perché mi mettete alla prova? Essi sono davvero dei falsi (ipocriti).
Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Ma Gesù, risponde alla domanda in modo indiretto. Sposta l’attenzione sul fatto oggettivo, in se stesso. Esisteva una moneta speciale, coniata dai romani, per pagare questo tributo e il fatto che gli interlocutori di Gesù gliela possano mostrare subito significava che vi era una certa facilità nel reperire e maneggiare tale tipo di denaro. Secondo un’interpretazione stretta del secondo comandamento (Es 20,4) una moneta recante un’immagine e l’iscrizione che divinizzava l’imperatore dovevano considerarsi idolatriche. Eppure anche i farisei ne facevano uso in modo piuttosto disinvolto. Egli domandò loro: «Questa immagine e l’iscrizione di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio!». La moneta portava l’immagine dell’imperatore Tiberio, e l’iscrizione che diceva Tiberio Cesare, augusto figlio del divino Augusto, sommo sacerdote. Dall’altro lato vi era sua madre Livia, raffigurata come dea della pace. Gesù mette la sua risposta su di un piano di appartenenza. Se la moneta riporta l’immagine di Cesare è da dare a Cesare. Tutti i vantaggi che il popolo di Israele godeva grazie alla presenza dei romani sul suo territorio dovevano essere riconosciuti e ripagati con questo tributo. Ma il potere di Cesare per quanto grande non poteva essere assoluto. Vi è anche una “moneta” che porta l’immagine di Dio, cioè l’uomo (Gn 1,26). Quindi ciò che porta l’immagine di Dio va reso a Dio, deve dedicarsi a Lui. Durante la storia cristiana si ha avuto la tendenza a usare questo testo come base della dottrina dei rapporti tra «Chiesa e Stato», giungendo spesso alla conclusione che si tratta di due sfere separate. Matteo per conto suo era più interessato a mostrare la capacità di Gesù di evitare i tranelli tesigli dai suoi avversari e alla sua esortazione a prestare altrettanta (e anche maggiore) attenzione a “quello che è di Dio” rispetto a “quello che è di Cesare”.
Meditiamo
– Mi capita mai di cercare di mettere Dio con le spalle al muro davanti alle mie richieste?
– Quale è il mio atteggiamento verso il potere politico? – In quale modo sono chiamato/a arealizzare il “dare a Dio quello che è di Dio”?
Monastero Matris Domini – Bergamo

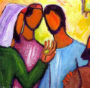

 Dal vangelo secondo Matteo Mt 22,1-14
Dal vangelo secondo Matteo Mt 22,1-14
 In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre.
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre.
 In quel tempo, disse Gesù ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli; rivoltosi al primo disse: Figlio, và oggi a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Sì, signore; ma non andò. Rivoltosi al secondo, gli disse lo stesso. Ed egli rispose: Non ne ho voglia; ma poi, pentitosi, ci andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Dicono: «L’ultimo». E Gesù disse loro: «In verità vi dico: I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. E` venuto a voi Giovanni nella via della giustizia e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, pur avendo visto queste cose, non vi siete nemmeno pentiti per credergli».
In quel tempo, disse Gesù ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli; rivoltosi al primo disse: Figlio, và oggi a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Sì, signore; ma non andò. Rivoltosi al secondo, gli disse lo stesso. Ed egli rispose: Non ne ho voglia; ma poi, pentitosi, ci andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Dicono: «L’ultimo». E Gesù disse loro: «In verità vi dico: I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. E` venuto a voi Giovanni nella via della giustizia e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, pur avendo visto queste cose, non vi siete nemmeno pentiti per credergli». 
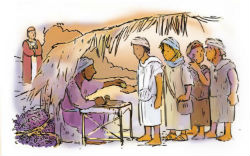 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi».
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi».
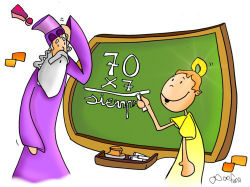
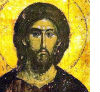


 In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche». Dal Vangelo di Matteo 13,24-43
Dal Vangelo di Matteo 13,24-43
 Dal Vangelo secondo Matteo
Dal Vangelo secondo Matteo