L’anima nostra ha bisogno di solitudine. Sant’Agostino (354-430)
 Il grande Agostino scrive della solitudine voluta da Dio per il primo uomo: “Fu molto meglio che il genere umano… abbia avuto origine da un solo uomo creato all’inizio, piuttosto che aver origine da molti… L’uomo dunque fu da Dio creato singolo e solo: solo, non tuttavia nel senso che sarebbe stato privo di società umana, ché anzi più avrebbe sentito il vincolo di questa società e l’unità concorde, essendo gli uomini uniti tra di loro non solo dalla somiglianza di natura, ma anche dall’affetto della parentela…”. Prospettiva da ampi e precisi orizzonti e solida concretezza agostiniana!
Il grande Agostino scrive della solitudine voluta da Dio per il primo uomo: “Fu molto meglio che il genere umano… abbia avuto origine da un solo uomo creato all’inizio, piuttosto che aver origine da molti… L’uomo dunque fu da Dio creato singolo e solo: solo, non tuttavia nel senso che sarebbe stato privo di società umana, ché anzi più avrebbe sentito il vincolo di questa società e l’unità concorde, essendo gli uomini uniti tra di loro non solo dalla somiglianza di natura, ma anche dall’affetto della parentela…”. Prospettiva da ampi e precisi orizzonti e solida concretezza agostiniana!
L’uomo dunque fu ‘creato singolo e solo’, ma non per vivere ‘appartato’, in solitudine. La sua vocazione identitaria è alla relazione, alla fraternità, alla comunione, dalla e nella ‘parentela’. Spinto da una ineludibile esigenza interiore, a volte brama la solitudine, altre la patisce con una intensità implacabile.
“Sono solo” dice con profonda amarezza qualche anziano… “Vorrei vivere in un deserto” è l’anelito espresso in momenti di giornate particolarmente faticose o caotiche. La solitudine imposta dalle circostanze e la solitudine anelata e/o cercata come ‘salvagente’ non serve. Sono gingilli o macigni senza senso; scuse fasulle che esprimono povertà interiore.
Spazi di solitudine sono necessari a chiunque: rispondono al giusto e salutare desiderio di rimanere soli per meditare su situazioni personali o relazionali, per capire meglio se stessi; per scavare con maturità entro se stessi, prendere coscienza delle proprie reazioni, o semplicemente per distendersi e riposare.
La solitudine così vissuta aiuta a diventare serenamente concreti, realisti sul proprio passato e capaci di protendersi verso un futuro con il cuore libero, pronti ad attendere e a vivere nuove primavere.
Icona di una donna che ha saputo vivere e maturare in solitudine è Maria. L’angelo le appare, le annuncia un radioso futuro poi, ‘partì da lei’. La trova sola; la lascia con un bimbo che lei porterà in grembo per nove mesi. Quando questo bimbo sarà adulto, sceglierà di vivere 40 giorni nel deserto, in solitudine, pronto alle sue battaglie con il grande nemico, Satana. E a tutto quello che il Padre vorrà da Lui…
Così i grandi della storia, molti asceti, e gli stessi Fondatori che, quando necessitavano certezze per sé e per i loro Istituti, si ritiravano per un periodo in solitudine. Agostino scriveva: “Ritorna in te stesso… all’interno dell’uomo abita la Verità”. Questa solitudine, liberamente scelta e vissuta con saggezza e con calma aiuta a vivere intensamente i vari momenti della giornata, assorbendo e gustando tutta la ricchezza e la bellezza in essi racchiusa. Non vi saranno più sprechi di energie; non si proietteranno su altri le colpe dei propri dissapori… Vi sarà pacifica concentrazione e raccoglimento e nuova fresca capacità di relazione, di quel semplice, caldo e pacifico ‘dono di sé’ che rende ancora più bella la vita propria e quella degli altri.
Biancarosa Magliano, fsp
biancarosam@tiscali.it



 Sono preoccupato per l’isolamento che viviamo nella mia comunità: ciascuno si occupa delle proprie cose, con relazioni minime con i fratelli, mentre verso l’esterno c’è un’attività frenetica. È come una specie di doppia personalità: estremamente sociale, simpatica e disponibile ad extra, ma alquanto ermetica ad intra, forse perché le persone non si sentono valorizzate. Un formatore
Sono preoccupato per l’isolamento che viviamo nella mia comunità: ciascuno si occupa delle proprie cose, con relazioni minime con i fratelli, mentre verso l’esterno c’è un’attività frenetica. È come una specie di doppia personalità: estremamente sociale, simpatica e disponibile ad extra, ma alquanto ermetica ad intra, forse perché le persone non si sentono valorizzate. Un formatore
 Il grande Agostino scrive della solitudine voluta da Dio per il primo uomo: “Fu molto meglio che il genere umano… abbia avuto origine da un solo uomo creato all’inizio, piuttosto che aver origine da molti… L’uomo dunque fu da Dio creato singolo e solo: solo, non tuttavia nel senso che sarebbe stato privo di società umana, ché anzi più avrebbe sentito il vincolo di questa società e l’unità concorde, essendo gli uomini uniti tra di loro non solo dalla somiglianza di natura, ma anche dall’affetto della parentela…”. Prospettiva da ampi precisi orizzonti e solida concretezza agostiniana!
Il grande Agostino scrive della solitudine voluta da Dio per il primo uomo: “Fu molto meglio che il genere umano… abbia avuto origine da un solo uomo creato all’inizio, piuttosto che aver origine da molti… L’uomo dunque fu da Dio creato singolo e solo: solo, non tuttavia nel senso che sarebbe stato privo di società umana, ché anzi più avrebbe sentito il vincolo di questa società e l’unità concorde, essendo gli uomini uniti tra di loro non solo dalla somiglianza di natura, ma anche dall’affetto della parentela…”. Prospettiva da ampi precisi orizzonti e solida concretezza agostiniana!
 La favola-mito della cura essenziale è di origine latina con base greca. La riporta Igino, scrittore del I secolo d.C.; se ne servirà Heidegger, quando analizzerà il tema della “Cura” (Sorge) in Essere e Tempo.
La favola-mito della cura essenziale è di origine latina con base greca. La riporta Igino, scrittore del I secolo d.C.; se ne servirà Heidegger, quando analizzerà il tema della “Cura” (Sorge) in Essere e Tempo.
 Orizzonte dell’uomo è un cuore plurale
Orizzonte dell’uomo è un cuore plurale
 Meglio commettere errori con gentilezza che fare miracoli con scortesia, esortava Madre Teresa. D’accordo. Ma, al di là della cordialità da salotto, stiamo davvero comunicando gli uni con gli altri? Non è cosa da poco chiederselo perché la comunicazione, a partire da quella fondamentale tra una mamma e il suo bambino, vive nella relazione e mette in gioco ogni legame. Quando è distorta ferisce profondamente e conduce a rapporti distorti. Non è esagerato affermare che, proprio nell’epoca dell’estensione capillare della rete, paradossalmente, la comunicazione è venuta a mancare. Comunicare infatti è disponibilità a lasciarsi arricchire dal positivo dell’altro, anche quando è nascosto da un cumulo di miserie e di errori e ci sembra di ‘perdere tempo’ a cercarlo; è aprirsi ad un rapporto orientato all’effettiva e reciproca crescita. Presuppone perciò una partecipazione attiva sia nell’esprimere che nel ricevere. Il che teoricamente è il desiderio di molti e praticamente il programma di pochi.
Meglio commettere errori con gentilezza che fare miracoli con scortesia, esortava Madre Teresa. D’accordo. Ma, al di là della cordialità da salotto, stiamo davvero comunicando gli uni con gli altri? Non è cosa da poco chiederselo perché la comunicazione, a partire da quella fondamentale tra una mamma e il suo bambino, vive nella relazione e mette in gioco ogni legame. Quando è distorta ferisce profondamente e conduce a rapporti distorti. Non è esagerato affermare che, proprio nell’epoca dell’estensione capillare della rete, paradossalmente, la comunicazione è venuta a mancare. Comunicare infatti è disponibilità a lasciarsi arricchire dal positivo dell’altro, anche quando è nascosto da un cumulo di miserie e di errori e ci sembra di ‘perdere tempo’ a cercarlo; è aprirsi ad un rapporto orientato all’effettiva e reciproca crescita. Presuppone perciò una partecipazione attiva sia nell’esprimere che nel ricevere. Il che teoricamente è il desiderio di molti e praticamente il programma di pochi.
 La più grave epidemia del mondo contemporaneo – affermava il grande maestro R. Panikkar – è la superficialità, che fa vivere di ‘immediato’ e di ‘cose’ che non durano. Questo blocca la vita al bordo del Mistero e impedisce di riconoscere cosa significa essere umani. E l’uomo – fatto per essere coinvolto in un amore assoluto e incondizionato – si ritrova a sperimentare solo una tristezza infinita.
La più grave epidemia del mondo contemporaneo – affermava il grande maestro R. Panikkar – è la superficialità, che fa vivere di ‘immediato’ e di ‘cose’ che non durano. Questo blocca la vita al bordo del Mistero e impedisce di riconoscere cosa significa essere umani. E l’uomo – fatto per essere coinvolto in un amore assoluto e incondizionato – si ritrova a sperimentare solo una tristezza infinita.
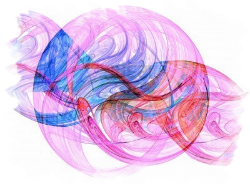 Chi dice ‘incontro’
Chi dice ‘incontro’
 Navighiamo in un mondo di distrazione crescente e di relazioni personali sempre più in pericolo. Il male, sotto forme diverse, germoglia un po’ ovunque. Fin troppo facile snocciolarne il lungo elenco. Ma è certo – come assicurava Teresa di Calcutta – che fra tutti i mali, il peggiore che può soffrire un essere umano è la mancanza di affetto. Eppure anche nella fotografia più scura fanno capolino piccole luci di speranza, accese da chi senza clamore non s’arrende e non rinuncia ad essere se stesso, con dignità; il suo sguardo vede e soccorre chi incontra; svolge il suo compito responsabilmente; fa del bene nelle situazioni più ordinarie… Gente normale, insomma. Inconsapevolmente eroica. Gente che nella fatica quotidiana conosce la gioia di imparare a sintonizzarsi sugli altri in modo genuino. E nel nostro mondo argina l’imperante disaffezione alle idee, all’impegno, alla fede…
Navighiamo in un mondo di distrazione crescente e di relazioni personali sempre più in pericolo. Il male, sotto forme diverse, germoglia un po’ ovunque. Fin troppo facile snocciolarne il lungo elenco. Ma è certo – come assicurava Teresa di Calcutta – che fra tutti i mali, il peggiore che può soffrire un essere umano è la mancanza di affetto. Eppure anche nella fotografia più scura fanno capolino piccole luci di speranza, accese da chi senza clamore non s’arrende e non rinuncia ad essere se stesso, con dignità; il suo sguardo vede e soccorre chi incontra; svolge il suo compito responsabilmente; fa del bene nelle situazioni più ordinarie… Gente normale, insomma. Inconsapevolmente eroica. Gente che nella fatica quotidiana conosce la gioia di imparare a sintonizzarsi sugli altri in modo genuino. E nel nostro mondo argina l’imperante disaffezione alle idee, all’impegno, alla fede…