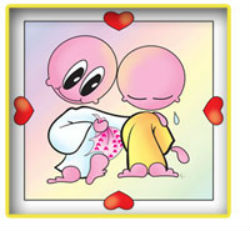 Le afflizioni sono sempre molteplici. Hanno origini e motivazioni diverse. E sono supportate con modalità così diverse quante sono le persone che le vivono sulla propria pelle, nella propria storia, nelle proprie giornate. Davvero ogni giorno si presenta, a volte sin dal mattino, con il proprio affanno. Ogni giorno può apparire con una sorpresa nuova e dolorante, anche perché – come ha lasciato scritto Blaise Pascal: “Basta poco per consolarci perché poco basta per affliggerci”.
Le afflizioni sono sempre molteplici. Hanno origini e motivazioni diverse. E sono supportate con modalità così diverse quante sono le persone che le vivono sulla propria pelle, nella propria storia, nelle proprie giornate. Davvero ogni giorno si presenta, a volte sin dal mattino, con il proprio affanno. Ogni giorno può apparire con una sorpresa nuova e dolorante, anche perché – come ha lasciato scritto Blaise Pascal: “Basta poco per consolarci perché poco basta per affliggerci”.
Ci si può sentire oppressi da situazioni gravose, improvvise o subodorate, perché la propria sensibilità o suscettibilità a volte le intuisce, le annuncia, le capta. Nessuno è esonerato dalla sofferenza. Non lo è il bimbo che nasce piangendo; non lo è il morente che versa le sue ultime lacrime. Non lo è il giovane che può incappare in delusioni cocenti o l’adulto che vede svanire i propri sogni. E c’è il dolore fisico per una malattia; l’umiliazione per ideali non realizzati; ci può essere la frustrazione per meriti non riconosciuti. A volte volteggia nell’aria la possibilità di un fallimento, di essere estromessi dal posto di lavoro e, sempre molto amareggiante, essere dimenticati dalle persone con cui si era stretto un forte legame di amicizia.
L’umana capacità di resistenza al male non è infinita. E allora la fede barcolla, la speranza non sostiene più. Le illusioni sulle proprie capacità di sopportazione svaniscono. Sono i momenti in cui una parola o un gesto di conforto, di vicinanza sono opportuni o necessari. Non parole o gesti convenzionali, ma partecipazione viva, vera, efficace. Quello che conta, infatti, è lo stile della partecipazione; altrimenti il tutto può risultare inutile quando non irritante. Conta il rapporto umano, non formale; motivato, garbato, amabile, caldo. Conta la ‘vicinanza’. “Vi sono vicino” dice papa Francesco in caso di sofferenze a volte enormi, di catastrofi o altro.
Tutta la Bibbia è incastonata di pensieri sulla consolazione. Dio conosce il dolore dell’uomo e ne sente pietà: “Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio” è scritto nel libro del profeta Isaia. E san Paolo addita la fonte di ogni vera consolazione: “Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione affinché, per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione. Poiché, come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda pure la nostra consolazione (2Cor 1,3-5).
Tutti i battezzati, in forza dell’unzione dello Spirito Santo, siamo stati abilitati a lenire le sofferenze, a fasciare le ferite degli sfiduciati, a indicare motivi per una nuova e più bella vita, per una rinascente speranza, a segnalare vie d’uscita da difficoltà e apprensioni varie.
Ed è umanamente vero che ci possono essere consolazioni spicciole: un cielo azzurro, limpido e sereno, una lettura interessante, nostalgie e ricordi. Ma… scriveva un grande, fine e suggestivo personaggio:
In me tutto è buio,
ma tu sei la luce io sono solo,
ma tu non mi lasci son pusillanime, ma da te c’è aiuto sono irrequieto,
ma da te c’è pace in me c’è amarezza,
ma da te pazienza le tue vie non comprendo,
ma tu conosci la retta via per me. (Dietrich Bonhoeffer)



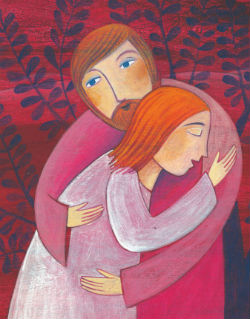 Chi è il peccatore?
Chi è il peccatore?
 “Esiste un solo bene, la conoscenza; e un solo male, l’ignoranza”. E’ una lampante affermazione di quell’antico filosofo, e attualissimo antropologo, di nome Socrate.
“Esiste un solo bene, la conoscenza; e un solo male, l’ignoranza”. E’ una lampante affermazione di quell’antico filosofo, e attualissimo antropologo, di nome Socrate.
 Il cimitero è l’ultima tappa di quello che resta della persona umana sulla terra. Cimitero monumentale o cimitero rustico non fa la differenza. Un piccolo loculo o una cappella vistosa: neppure qui la differenza ha valore. Sono immagini di una ricchezza più o meno simulata e di un amore che non va soggetto al tempo, né alla ‘presenza’ della persona amata. E’ la sede di chi ha terminato il suo corso… Una visita del vivente – con o senza fiori – è dovuta in forza di quell’amore che unisce e che perdura nel ricordo commosso, nell’amore, nella gratitudine, forse anche nella nostalgia, nel rimpianto. E lì, nel cimitero, si impara l’assoluto primato di Dio… grandezza, splendori, potenza senza un supporto spirituale, sono valori che tramontano. Ma… e chi nel cimitero non ci andrebbe mai se non portato da uno sconosciuto? Quel simpatico e provocante libro sulla sapienza qual è il Siracide consiglia: “La tua generosità si estenda a ogni vivente e al morto non negare la tua grazia” (Sir 7,33). Ancor più esplicito è il libro di Tobia il cui autore racconta di sé: “Al tempo di Salmanàssar facevo spesso l’elemosina a quelli della mia gente; donavo il pane agli affamati, gli abiti agli ignudi e, se vedevo qualcuno dei miei connazionali morto e gettato dietro le mura di Ninive, io lo seppellivo. Seppellii anche quelli che aveva uccisi Sennàcherib” (Tb 1,16).
Il cimitero è l’ultima tappa di quello che resta della persona umana sulla terra. Cimitero monumentale o cimitero rustico non fa la differenza. Un piccolo loculo o una cappella vistosa: neppure qui la differenza ha valore. Sono immagini di una ricchezza più o meno simulata e di un amore che non va soggetto al tempo, né alla ‘presenza’ della persona amata. E’ la sede di chi ha terminato il suo corso… Una visita del vivente – con o senza fiori – è dovuta in forza di quell’amore che unisce e che perdura nel ricordo commosso, nell’amore, nella gratitudine, forse anche nella nostalgia, nel rimpianto. E lì, nel cimitero, si impara l’assoluto primato di Dio… grandezza, splendori, potenza senza un supporto spirituale, sono valori che tramontano. Ma… e chi nel cimitero non ci andrebbe mai se non portato da uno sconosciuto? Quel simpatico e provocante libro sulla sapienza qual è il Siracide consiglia: “La tua generosità si estenda a ogni vivente e al morto non negare la tua grazia” (Sir 7,33). Ancor più esplicito è il libro di Tobia il cui autore racconta di sé: “Al tempo di Salmanàssar facevo spesso l’elemosina a quelli della mia gente; donavo il pane agli affamati, gli abiti agli ignudi e, se vedevo qualcuno dei miei connazionali morto e gettato dietro le mura di Ninive, io lo seppellivo. Seppellii anche quelli che aveva uccisi Sennàcherib” (Tb 1,16).




