 Vogliamo ora, seguendo alcune indicazioni della dottrina conciliare su Maria e la Chiesa, approfondire un aspetto particolare dei rapporti intercorrenti tra Maria e la Liturgia, vale a dire: Maria quale modello dell’atteggiamento spirituale con cui la Chiesa celebra e vive i divini misteri. L’esemplarità della Beata Vergine in questo campo deriva dal fatto che ella è riconosciuta eccellentissimo modello della Chiesa nell’ordine della fede, della carità e della perfetta unione con Cristo, cioè di quella disposizione interiore con cui la Chiesa, sposa amatissima, strettamente associata al suo Signore, lo invoca e, per mezzo di lui, rende il culto all’eterno Padre.
Vogliamo ora, seguendo alcune indicazioni della dottrina conciliare su Maria e la Chiesa, approfondire un aspetto particolare dei rapporti intercorrenti tra Maria e la Liturgia, vale a dire: Maria quale modello dell’atteggiamento spirituale con cui la Chiesa celebra e vive i divini misteri. L’esemplarità della Beata Vergine in questo campo deriva dal fatto che ella è riconosciuta eccellentissimo modello della Chiesa nell’ordine della fede, della carità e della perfetta unione con Cristo, cioè di quella disposizione interiore con cui la Chiesa, sposa amatissima, strettamente associata al suo Signore, lo invoca e, per mezzo di lui, rende il culto all’eterno Padre.
Maria è la Vergine in ascolto, che accoglie la parola di Dio con fede; e questa fu per lei premessa e via alla maternità divina, poiché, come intuì sant’Agostino, la beata Maria colui (Gesù) che partorì credendo, credendo concepì.45 Infatti, ricevuta dall’Angelo la risposta al suo dubbio (cfr Lc 1,34-37) essa, piena di fede e concependo il Cristo prima nella sua mente che nel suo grembo, Ecco – disse – la serva del Signore, sia fatto di me secondo la tua parola (Lc 1,38);46 fede, che fu per lei causa di beatitudine e certezza circa l’adempimento della promessa: E beata colei che ha creduto nell’adempimento delle parole del Signore (Lc 1,45); fede con la quale ella, protagonista e testimone singolare della Incarnazione, ritornava sugli avvenimenti dell’infanzia di Cristo, raffrontandoli tra loro nell’intimo del suo cuore (cfr Lc 2,19. 51). Questo fa anche la Chiesa, la quale, soprattutto nella sacra Liturgia, con fede ascolta, accoglie, proclama, venera la parola di Dio, la dispensa ai fedeli come pane di vita47 e alla sua luce scruta i segni dei tempi, interpreta e vive gli eventi della storia.
Maria è, altresì, la Vergine in preghiera. Così essa appare nella Visita alla madre del Precursore, in cui effonde il suo spirito in espressioni di glorificazione a Dio, di umiltà, di fede, di speranza: tale è il cantico L’anima mia magnifica il Signore (cfr Lc 1,46-55), la preghiera per eccellenza di Maria, il canto dei tempi messianici nel quale confluiscono l’esultanza dell’antico e del nuovo Israele, poiché – come sembra suggerire sant’Ireneo – nel cantico di Maria confluì il tripudio di Abramo che presentiva il Messia (cfr Gv 8,56) e risuonò, profeticamente anticipata, la voce della Chiesa: Nella sua esultanza Maria proclamava profeticamente a nome della Chiesa: L’anima mia magnifica il Signore. Infatti, il cantico della Vergine, dilatandosi, è divenuto preghiera di tutta la Chiesa in tutti i tempi.
Vergine in preghiera appare Maria a Cana dove, manifestando al Figlio con delicata implorazione una necessità temporale, ottiene anche un effetto di grazia: che Gesù, compiendo il primo dei suoi «segni», confermi i discepoli nella fede in lui (cfrGv 2,1-12).
Anche l’ultimo tratto biografico su Maria ce la presenta Vergine orante. Infatti gli Apostoli erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la Madre di Gesù, e con i fratelli di lui (At 1,14): presenza orante di Maria nella Chiesa nascente e nella Chiesa di ogni tempo, poiché ella, assunta in cielo, non ha deposto la sua missione di intercessione e di salvezza. Vergine in preghiera è anche la Chiesa, che ogni giorno presenta al Padre le necessità dei suoi figli, loda il Signore incessantemente e intercede per la salvezza del mondo.
Maria è, ancora, la Vergine madre, cioè colei che per la sua fede e obbedienza generò sulla terra lo stesso Figlio del Padre, senza contatto con uomo, ma adombrata dallo Spirito Santo: prodigiosa maternità, costituita da Dio quale tipo e modello della fecondità della Vergine- Chiesa, la quale diventa anche essa madre, poiché con la predicazione e il Battesimo genera a vita nuova e immortale i figli, concepiti per opera dello Spirito Santo e nati da Dio. Giustamente gli antichi padri insegnavano che la Chiesa prolunga nel Sacramento del Battesimo la maternità verginale di Maria. Tra le loro testimonianze ci piace ricordare quella del Nostro illustre Predecessore san Leone Magno, il quale in una omelia natalizia afferma: L’origine che (Cristo) ha preso nel grembo della Vergine, l’ha posta nel fonte battesimale; ha dato all’acqua quel che aveva dato alla Madre; difatti, la virtù dell’Altissimo e l’adombramento dello Spirito Santo (cfr Lc 1,35), che fece sì che Maria desse alla luce il Salvatore, fa anche sì che l’acqua rigeneri il credente. Volendo attingere alle fonti liturgiche, potremmo citare la bella Conclusione della Liturgia ispanica: Quella (Maria) portò la Vita nel grembo, questa (la Chiesa) la porta nell’onda battesimale. Nelle membra di lei fu plasmato il Cristo, nelle acque di costei fu rivestito il Cristo.
Maria è, infine, la Vergine offerente Nell’episodio della presentazione di Gesù al tempio (cfr Lc 2,22- 35), la Chiesa, guidata dallo Spirito, ha scorto, al di là dell’adempimento delle leggi riguardanti l’oblazione del primogenito (cfr Es 13,11-16) e la purificazione della madre (cfr Lv 12,6-8), un mistero salvifico, relativo appunto alla storia della salvezza: ha rilevato, cioè, la continuità dell’offerta fondamentale che il Verbo incarnato fece al Padre, entrando nel mondo (cfr Eb 10,5-7); ha visto proclamata l’universalità della salvezza poiché Simeone, salutando nel Bambino la luce per illuminare le genti e la gloria di Israele (cfr Lc 2,32), riconosceva in lui il Messia, il Salvatore di tutti; ha inteso il riferimento profetico alla Passione di Cristo: che le parole di Simeone, le quali congiungevano in un unico vaticinio il Figlio segno di contraddizione (Lc 2,34) e la Madre, a cui la spada avrebbe trafitto l’anima (cfr Lc 2,35), si avverarono sul Calvario. Mistero di salvezza, dunque, che nei suoi vari aspetti orienta l’episodio della presentazione al tempio verso l’evento salvifico della croce. Ma la Chiesa stessa, soprattutto a partire dai secoli del medioevo, ha intuito nel cuore della Vergine, che porta il Figlio a Gerusalemme per presentarlo al Signore (cfr Lc 2,22), una volontà oblativa, che superava il senso ordinario del rito. Di tale intuizione abbiamo testimonianza nell’affettuosa apostrofe di san Bernardo: Offri il tuo Figlio, o Vergine santa, e presenta al Signore il frutto benedetto del tuo seno. Offri per la riconciliazione di noi tutti la vittima santa, a Dio gradita.
Questa unione della Madre con il Figlio nell’opera della Redenzione raggiunge il culmine sul Calvario, dove Cristo offrì se stesso quale vittima immacolata a Dio (Eb 9,14) e dove Maria stette presso la Croce (cfr Gv 19,25), soffrendo profondamente con il suo Unigenito e associandosi con animo materno al sacrificio di lui, amorosamente consenziente all’immolazione della vittima da lei generata58 e offrendola anch’ella all’eterno Padre. Per perpetuare nei secoli il sacrificio della Croce il divin Salvatore istituì il sacrificio eucaristico, memoriale della sua morte e risurrezione, e lo affidò alla Chiesa, sua sposa, la quale, soprattutto alla domenica, convoca i fedeli per celebrare la Pasqua del Signore, finché egli ritorni: il che la Chiesa compie in comunione con i Santi del Cielo e, prima di tutto, con la Beata Vergine, della quale imita la carità ardente e la fede incrollabile.
Modello di tutta la Chiesa nell’esercizio del culto divino, Maria è anche, evidentemente, maestra di vita spirituale per i singoli cristiani. Ben presto i fedeli cominciarono a guardare a Maria per fare, come lei, della propria vita un culto a Dio e del loro culto un impegno di vita. Già nel IV secolo, sant’Ambrogio, parlando ai fedeli, auspicava che in ognuno di essi fosse l’anima di Maria per glorificare Dio: Dev’essere in ciascuno l’anima di Maria per magnificare il Signore, dev’essere in ciascuno il suo spirito per esultare in Dio. Maria, però, è soprattutto modello di quel culto che consiste nel fare della propria vita un’offerta a Dio: dottrina antica, perenne, che ognuno può riascoltare, ponendo mente all’insegnamento della Chiesa, ma anche porgendo l’orecchio alla voce stessa della Vergine, allorché essa, anticipando in sé la stupenda domanda della preghiera del Signore: Sia fatta la tua volontà (Mt 6,10), rispose al messaggero di Dio: Ecco la serva del Signore: sia fatto di me secondo la tua parola (Lc 1,38). E il «sì» di Maria è per tutti i cristiani lezione ed esempio per fare dell’obbedienza alla volontà del Padre la via e il mezzo della propria santificazione.
È importante, d’altra parte, osservare come la Chiesa traduca i molteplici rapporti che la uniscono a Maria in vari ed efficaci atteggiamenti cultuali: in venerazione profonda, quando riflette sulla singolare dignità della Vergine, divenuta, per opera dello Spirito, madre del Verbo incarnato; in amore ardente, quando considera la maternità spirituale di Maria verso tutte le membra del Corpo mistico; in fiduciosa invocazione, quando esperimenta l’intercessione della sua Avvocata e Ausiliatrice; in servizio di amore, quando scorge nell’umile Ancella del Signore la Regina di misericordia e la Madre di grazia; in operosa imitazione, quando contempla la santità e le virtù della «piena di grazia» (Lc 1,28); in commosso stupore, quando vede in lei, come in una immagine purissima, ciò che essa, tutta, desidera e spera di essere;65 in attento studio, quando ravvisa nella cooperatrice del Redentore, ormai pienamente partecipe dei frutti del mistero pasquale, il compimento profetico del suo stesso avvenire, fino al giorno in cui, purificata da ogni ruga e da ogni macchia (cfrEf 5,27), diverrà come una sposa ornata per lo sposo, Gesù Cristo (cfr Ap 21,2).
Considerando, dunque, la venerazione che la tradizione liturgica della Chiesa universale e il rinnovato Rito Romano esprimono verso la santa Madre di Dio; ricordando che la Liturgia, per il suo preminente valore cultuale, costituisce una regola d’oro per la pietà cristiana; osservando, infine, come la Chiesa, quando celebra i sacri misteri, assuma un atteggiamento di fede e di amore simili a quello della Vergine, comprendiamo quanto sia giusta l’esortazione del Concilio Vaticano II a tutti i figli della Chiesa, perché promuovano generosamente il culto, specialmente liturgico, della Beata Vergine: esortazione, che vorremmo vedere dappertutto accolta senza riserve e tradotta in pratica con zelo.
Dall’Esortazione apostolica,
Marialis cultus (1974) di papa Paolo VI


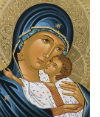
 Il Cristo pasquale è l’incarnazione definitiva della misericordia, il suo segno vivente: storico salvifìco ed insieme escatologico. Nel medesimo spirito, la liturgia del tempo pasquale pone sulle nostre labbra le parole del Salmo: Canterò in eterno le misericordie del Signore.
Il Cristo pasquale è l’incarnazione definitiva della misericordia, il suo segno vivente: storico salvifìco ed insieme escatologico. Nel medesimo spirito, la liturgia del tempo pasquale pone sulle nostre labbra le parole del Salmo: Canterò in eterno le misericordie del Signore. 
 Ai piedi della croce, nell’ora suprema della nuova creazione, Cristo ci conduce a Maria. Ci conduce a Lei perché non vuole che camminiamo senza una madre, e il popolo legge in quell’immagine materna tutti i misteri del Vangelo. Al Signore non piace che manchi alla sua Chiesa l’icona femminile. Ella, che lo generò con tanta fede, accompagna pure «il resto della sua discendenza, […] quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù» (Ap 12,17)…È l’amica sempre attenta perché non venga a mancare il vino nella nostra vita. È colei che ha il cuore trafitto dalla spada, che comprende tutte le pene.
Ai piedi della croce, nell’ora suprema della nuova creazione, Cristo ci conduce a Maria. Ci conduce a Lei perché non vuole che camminiamo senza una madre, e il popolo legge in quell’immagine materna tutti i misteri del Vangelo. Al Signore non piace che manchi alla sua Chiesa l’icona femminile. Ella, che lo generò con tanta fede, accompagna pure «il resto della sua discendenza, […] quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù» (Ap 12,17)…È l’amica sempre attenta perché non venga a mancare il vino nella nostra vita. È colei che ha il cuore trafitto dalla spada, che comprende tutte le pene.