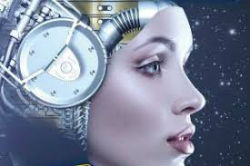 Homo Cyborg. Il futuro dell’uomo, tra tecnoscienza, intelligenza artificiale e nuovo umanesimo.
Homo Cyborg. Il futuro dell’uomo, tra tecnoscienza, intelligenza artificiale e nuovo umanesimo.
Quale sarà l’evoluzione del genere umano? Ci attende un futuro da “cyborg”, a metà tra uomo e macchina? Dove sono arrivate le nuove scoperte scientifiche e le nuove tecnologie applicate alla vita? È lecito porsi delle domande su eventuali limiti in questo campo?
Su queste questioni epocali si è confrontato il Convegno nazionale dell’Associazione Scienza & Vita in programma il 25 maggio c.a. a Roma.
L’associazione S&V, ha inteso dare il proprio contributo per cercare risposte all’appello urgente lanciato da Papa Francesco (ottobre 2017): “La potenza delle biotecnologie, che già ora consente manipolazioni della vita fino a ieri impensabili, pone questioni formidabili. È urgente, perciò, intensificare lo studio e il confronto sugli effetti di tale evoluzione della società in senso tecnologico per articolare una sintesi antropologica che sia all’altezza di questa sfida epocale”.
Partendo dalla presa di coscienza della contemporaneità della prospettiva trans/post-umanista, l’intento è stato quello di offrire ai partecipanti, attraverso una approfondita riflessione antropologica e l’incontro con alcune esperienze concrete, alcuni possibili strumenti di discernimento per orientarsi in tale scenario e per valutare come e con quali presupposti l’innovazione tecnologica possa realmente garantire uno sviluppo umano autentico. In tale prospettiva il convegno è stato non solo un’esperienza intellettuale, ma anche un’esperienza concreta di riflessione e di azione in chiave antropologica, da esportare nel proprio spazio sociale.
I lavori sono stati introdotti dalla relazione del Cardinale Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza Episcopale Italiana.
“Il nuovo umanesimo” è “una grande sfida, non solo per la Chiesa, ma per l’umanità intera”. Nel mondo contemporaneo, osserva il cardinale, “è ormai emersa una nuova questione sociale che investe la sfera economica e quella antropologica, la dimensione culturale e quella politica, i cui riflessi si fanno sentire profondamente anche in ambito religioso”. Ed è proprio “la consapevolezza di questa nuova questione sociale che ci impone la sfida del nuovo umanesimo. Una questione sociale che tende ad interpretare e a vedere in modo unitario la crisi antropologica e quella economica, la crisi ambientale e quella politico-culturale”.
“Il nuovo potere tecnico non è solo un’applicazione economica della scienza nella vita quotidiana ma è una concezione filosofica del mondo e una visione parareligiosa della vita comune”. Di qui l’esortazione a intellettuali e scienziati “a dare una nuova forma e un nuovo senso a quell’umanesimo cristiano e laico che per secoli ha caratterizzato la vita quotidiana del continente europeo. La sfida del nuovo umanesimo non è una questione da eruditi rinchiusi nella Torre Eburnea ma è un progetto di grandissimo respiro che ha come ambizione ultima la ‘custodia dell’umanità’”. Di fronte al rischio di un “nuovo Adamo tecnologico” occorre, come ha in più occasioni affermato il Papa, “un nuovo umanesimo europeo vicino agli ultimi”. Un umanesimo, “non di facciata”, ma “estremamente concreto, che si proponga di umanizzare la tecnica, rendendola al servizio dell’uomo, e di custodire la vita umana in ogni istante dell’esistenza”.
L’invito è a non avere paura dei “segni dei tempi” e ad “analizzare cosa si muove sotto la superficie del mare” per “capire come e perché si muovono le correnti che agitano il mondo in cui viviamo”. “Tutti noi siamo chiamati ad esercitare questo sguardo e ad assumere questa prospettiva storica”, oggi “un po’ marginale nel dibattito pubblico” ma invece “estremamente importante”. Di qui il monito a non dimenticare che “il mondo in cui viviamo” è “il prodotto di un processo storico” all’interno del quale si è verificato 40 anni fa un evento ancora oggetto di riflessione: la nascita di Louise Brown, prima bambina nata con la fecondazione in vitro.
Con riferimento quindi al “futuro della natura umana”, citazione dal titolo di un noto volume di Jürgen Habermas, il presidente Cei ricorda i timori del filosofo tedesco per i rischi dell’incontro tra medicina riproduttiva e ingegneria genetica: una società in cui viene esaltato “il potere taumaturgico della tecnica” che rende disponibile ciò che prima era indisponibile, “ovvero la creazione della vita”, e “lo strapotere dell’economico nella vita degli uomini” assurto a “criterio di giudizio” anche nelle questioni eticamente sensibili. Oggi, le società occidentali sembrano “attraversate da una profonda crisi antropologica che sta mercificando tutto, persino il corpo degli esseri umani” mentre la “cultura del benessere” anestetizza la mente e il cuore delle persone tramite una “nuova idolatria del denaro” e attraverso “la riduzione dell’essere umano ad uno dei suoi bisogni: il consumo”.

